e del progetto
Tra la fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento prende Nascita
vita un nuovo fenomeno sia nel campo letterario sia in quel-dell’Umanesimo
lo delle arti figurative: l’Umanesimo, così definito per l’attenzione rivolta alla dignità dell’uomo, costituisce un movimento culturale unitario insieme al Rinascimento, periodo storico e artistico compreso tra il 1420 e il 1550.
Il termine Rinascimento esprime un desiderio di rinascita, Gli ideali
una nuova concezione dell’uomo e della natura: l’uomo può rinascimentali
conoscere e comprendere il mondo e risalire al suo Creatore
in virtù della ragione, forma di intelletto donatagli da Dio e
quindi uguale a quella di Dio stesso. Il passato non è qualco-sa cui attingere per ricavarne una semplice imitazione delle
forme espressive, ma è fonte di ispirazione per elaborazioni
autonome e legate al contesto storico. L’arte diviene anch’essa L’arte come
strumento di conoscenza del reale, assumendo i metodi di strumento
indagine della scienza e basandosi su fondamenti razionali di conoscenza
quali la prospettiva. L’architetto del Quattrocento è parago-nabile a uno scienziato, poiché fa tesoro del passato per ri-L’architetto leggerlo in un’ottica nuova, basata sull’analisi scientifica.
si fa scienziato
Le origini italiane e gli aspetti politici
e culturali dell’epoca
All’inizio del Quattrocento il clima generale di interesse per la
civiltà classica vede la città di Firenze rivestire il ruolo di culla La culla
del Rinascimento. Le ragioni dell’origine fiorentina si possono del Rinascimento
cogliere nel fatto che tra la fine del XII e la metà del XIII secolo si afferma il Protorinascimento, caratterizzato da una sensibilità verso i motivi architettonici romani e da una propen-Protorinascimento 153
Architettura del Rinascimento
LA PROSPETTIVA RINASCIMENTALE
I principi del metodo prospettico erano
zonte di fronte all’occhio dell’osservatore;
già contenuti in nuce nella teoria ottica
su queste diagonali visive vengono distri-medievale, ma, mentre questa tendeva a
buite le figure, che assumono dimensioni
mostrare l’apparenza della realtà, la pro-differenti in relazione alla lontananza o vi-spettiva rinascimentale si pone l’obiettivo cinanza rispetto allo spettatore. La pro-di dare una fedele rappresentazione del
spettiva è di tipo lineare e risolve l’anno-mondo, ricostruito su regole geometri-so problema della rappresentazione di
che. Nata dallo studio della geometria e
una realtà tridimensionale su una superfi-dell’ottica, permette di codificare la realtà
cie piana; è unitaria perché relaziona la
sottoponendola a una legge razionale u-molteplicità degli elementi del reale all’universale. Questa soluzione tecnica rap-nico punto di vista dello spettatore, che ri-presenta gli oggetti secondo una serie di sulta protagonista dello spazio; è infine di
linee convergenti in un unico punto
origine matematica, perché segue preci-
(punto di fuga), posto sulla linea dell’oriz-se leggi razionali imposte dall’uomo.
Il contesto politico
sione per l’eleganza e la grazia. Firenze all’epoca è una repubblica dove il cittadino contribuisce alla crescita della collettività (particolarità riscontrabile anche nel mondo classico).
Tra il 1418 e il 1434 si passa dal regime oligarchico al potere
della famiglia Medici, che diviene una delle maggiori com-Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara mittenze private (la fama degli artisti è subordinata ai committenti, che si identificano con le famiglie facoltose).
Da Firenze
Lo sviluppo del Rinascimento non avviene in modo omoge-al resto d’Italia
neo in tutta la penisola: da Firenze, tramite gli spostamenti
degli artisti, il linguaggio figurativo viene esportato nel resto
d’Italia, dapprima a Roma e Venezia, successivamente a Fer-rara, Urbino, Siena, Pisa, Perugia, Mantova, Milano e Napoli.
Per comprenderlo al meglio è quindi necessario tenere conto delle differenti realtà storiche, politiche e culturali delle
diverse città italiane. Le fasi nelle quali gli storici sono soliti
Tre fasi
suddividere il periodo rinascimentale sono tre.
I Primo Rinascimento
Il primo Rinascimento interessa gli anni compresi tra il 1420
e il 1500. L’utilizzo di forme geometriche, chiaramente deli-neate per mezzo della prospettiva e dell’introduzione del
Nuova concezione
modulo quadrato, dà luogo a una nuova concezione dello
dello spazio
spazio: rigoroso, armonico, semplice. Altro elemento distintivo è l’impiego della pianta a schema centrico e di quella a
schema longitudinale per gli edifici religiosi. La facciata è
concepita come proiezione all’esterno della distribuzione
spaziale interna, per esprimere la relazione tra l’uomo e
l’ambiente. Non meno importante è la ripresa degli ordini
154
1 - Inquadramento storico
architettonici, espressione dell’equilibrio e dell’eleganza Il modello classico
dell’architettura classica: la loro scansione è usata per descrivere lo scheletro strutturale. Gli ordini, così come le campate, vengono combinati insieme secondo leggi geometriche di aggregazione e ripetuti all’infinito creando nuove tipologie edilizie, non solo per gli interni, ma anche per le facciate (esempi significati sono le chiese di San Lorenzo e di Santa Maria Novella, a Firenze).
Tali applicazioni possono trovare espressione, ad esempio,
nella sovrapposizione degli ordini, allo scopo di dare armonia e dinamismo, e nell’ordine architravato o archivoltato.
La ricerca della bellezza attraverso la classicità si manifesta con Ricerca
il sapiente connubio tra elementi verticali (le colonne, le le-della bellezza
sene, le paraste e i capitelli) e orizzontali (le trabeazioni e le
cornici), con la ripresa del modello dell’arco romano a 3 fornici e tramite l’uso dell’arco a tutto sesto. L’impiego di una ricca decorazione (tipica del Tardogotico) scompare per lasciare il posto a scansioni ritmiche degli elementi architettonici, chiara definizione dei volumi costruiti ed equilibrato rapporto tra pieni e vuoti. Le facciate dei templi religiosi fanno mostra di
timpani, coronamenti a lunetta sulle finestre e portali privi di
strombature; per le coperture si preferiscono volte a botte o a
vela e tetti a capanna, e si evidenzia un interesse per l’impiego
della cupola intesa come forma armonica e perfetta.
I padri fondatori del primo Rinascimento sono Filippo Bru-I primi protagonisti
nelleschi e Leon Battista Alberti. Dopo il 1450 il linguaggio
Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara rinascimentale da Firenze si sposta a Venezia e a Milano, con
Michelozzo Michelozzi di Bartolomeo (1396-1472) e Filarete (1400-1469), per non dimenticare le corti principesche
di Rimini, Mantova e l’ambiente urbinate con Luciano Laurana (1420-1479).
I Medio Rinascimento
Il medio Rinascimento si sviluppa in un arco di tempo che va
dal 1500 al 1530 circa. Il XVI secolo vede il ritorno a Roma Il ritorno del Papato
del Papato da Avignone e il conseguente rinnovamento edilizio e culturale della città, con il moltiplicarsi di nuovi palazzi e chiese cui si accompagna il rimaneggiamento di numerose
vecchie costruzioni. Il centro della vita artistica da Firenze si Roma capitale
sposta quindi a Roma.
artistica
Il maggior esponente del periodo è Donato Bramante, attraverso le cui opere si colgono i tratti salienti del Rinascimento maturo: la grande innovazione consiste in un nuovo procedimento di progettazione che supera quello del Brunelleschi, poiché introduce una spazialità in cui l’organismo
architettonico è costituito da una semplice aggregazione di
155
Architettura del Rinascimento
cellule tridimensionali aventi volumi diversi. Altri elementi
cardine del periodo sono la compenetrazione tra pieni e
vuoti e la relazione tra architettura e ambiente: l’impiego
Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara di balaustre, colonnati e nicchie permette allo spazio di penetrare all’interno dell’edificio, e contemporaneamente al-l’edificio stesso di proiettarsi all’esterno attraverso elementi Continuità con il
aggettanti (gradoni, cupole e lanterne). Proseguono la pro-primo Rinascimento
pensione per gli impianti centrali, con piante cruciformi o
quadrate, la sovrapposizione degli ordini, l’orizzontalità dei
tetti con frontoni, la ricchezza degli elementi decorativi e
la ripresa del motivo dell’arco onorario, utilizzato sia nei prospetti sia all’interno delle chiese.
Apice e declino
Il Rinascimento raggiunge l’apice nel Cinquecento, ma nello stesso secolo si segnala anche l’inizio della crisi: l’uomo rinascimentale, proprio perché crede nella ragione, è costantemente spinto dall’ansia della ricerca fino all’estremo delle possibilità, e perciò è destinato all’insoddisfazione.
La diaspora
Il Sacco di Roma del 1527 segna la sottomissione degli Sta-degli artisti
ti italiani alla dominazione spagnola; nel mondo delle arti
inizia la diaspora di molti artisti attivi a Roma e il conseguente
ampliamento del linguaggio rinascimentale su scala europea.
I Tardo Rinascimento e Manierismo
Il tardo Rinascimento copre un arco di vent’anni, dal 1530 al
1550; le idee nate nei decenni tra la fine del Quattrocento e
l’inizio del Cinquecento si sviluppano e il loro significato viene ampliato. La cultura del tardo Quattrocento giudica ogni Tensione ideale
esperienza reale con il metro della perfezione assoluta cui si
verso la perfezione
può tendere; la successiva generazione del Cinquecento sfio-ra questa perfezione, con artisti come Raffaello Sanzio (1483-1520) e Michelangelo Buonarroti (1475-1564). Il tardo Rinascimento non può non essere analizzato insieme con il Manierismo, movimento stilistico che si colloca tra il 1520 e il 1620 circa. I segni precursori del Manierismo si possono già
vedere nei grandi maestri del tardo Rinascimento, che ingi-L’ordine gigante
gantiscono gli stili dell’antichità con l’introduzione del cosiddetto ordine gigante, accentuando gli elementi chiaroscurali con la realizzazione di spazi poliprospettici.
I massimi esponenti del tardo Rinascimento, che nelle loro opere anticipano lo stile manierista, sono Raffaello, con villa Madama, a Roma, Baldassarre Peruzzi (1481-1536), con villa Farnesina e Palazzo Massimo, Michelangelo, con la Sacrestia Nuova, lo scalone della Biblioteca Laurenziana e il Campidoglio.
Il principio fondante
Alla base del Manierismo c’è il rifiuto dell’armonia e della com-del Manierismo
postezza classica, e quindi la sua deformazione. Questo porta
a una trasgressione delle regole, alla ricerca del capriccio, al-156
1 - Inquadramento storico
l’accentuazione delle decorazioni, a ritmi ambigui, all’indeter-minazione spaziale e a un’architettura volta a divertire e stupi-Divertire e stupire re attraverso elementi sovradimensionati o tramite un’articolazione complessa delle superfici. A questo atteggiamento tra-sgressivo mancano la chiarezza d’intenti e la sistematicità necessarie a un rinnovamento del linguaggio architettonico, per il raggiungimento del quale bisognerà attendere l’epoca ba-Mancanza di un
rocca. Il repertorio artistico della “terza maniera”, cioè del pie-linguaggio comune
no Manierismo, rende difficile la formazione di una cultura
omogenea, dando vita a differenti realtà locali; i due primi centri di elaborazione sono Firenze e Roma.
Consulente del granduca Cosimo I è Giorgio Vasari (1511-1574), scrittore e architetto, che si ricorda tra l’altro per il progetto della galleria degli Uffizi (1560), costituita da 2 corpi di Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara fabbrica paralleli che creano 2 lunghe linee prospettiche convergenti nel punto di fuga, individuato nella grande finestra serliana (a 3 aperture) del piano terra.
Ricordiamo anche i manieristi michelangioleschi alla corte I manieristi
medicea nei nomi di Bartolomeo Ammannati (1511-1592) e michelangioleschi
Bernardo Buontalenti (1536-1608).
A Roma si afferma la produzione monumentale della corte pon-tificia. Personaggio chiave fu il Vignola, il quale, oltre a scrivere Il Vignola il trattato Regola delli cinque ordini di architettura, introduce una tipologia edilizia per gli edifici religiosi, mentre per gli edifici civili utilizza il bugnato e la sovrapposizione degli ordini, con paraste che dividono le facciate in moduli regolari.
SCHEMA RIASSUNTIVO
NUOVA CONCEZIONE
L’Umanesimo è un movimento di rinascita che mette l’uomo al centro del ’Univer-DELL’INDIVIDUO
so. L’architettura diventa un modo di conoscere la realtà, grazie al legame con la
E DEL PROGETTO
scienza e la sfera razionale.
LE ORIGINI ITALIANE
Il potere della famiglia Medici a Firenze fa da catalizzatore di architetti e artisti ri-E GLI ASPETTI POLITICI
nascimentali. Il primo Rinascimento (1420-1500) si distingue per l’uso di forme
E CULTURALI DELL’EPOCA
geometriche e del modulo quadrato, che creano uno spazio rigoroso, armonico e
semplice. Filippo Brunelleschi e Leon Battista Alberti ne sono i massimi esponenti. Il medio Rinascimento (1500-1530) vede il ritorno della sede papale da Avignone a Roma. Il Bramante introduce una nuova concezione di progettazione basata sul rapporto tra altezza e larghezza, con la compenetrazione tra pieni e vuoti. Altri esponenti di spicco del periodo sono Leonardo, Michelangelo e Raffaello. Il tardo Rinascimento (1530-1550) si fonde con l’inizio del Manierismo (1520-1620 ca.), che rifiuta l’armonia e la compostezza classiche, ricercando la trasgressione delle regole. A Firenze opera Giorgio Vasari, a Roma il Vignola.
157
2 Aspetti tipologici
Tema fondamentale del ’architettura rinascimentale è lo studio del a città, idealizzata
sul a base di schemi geometrici e leggi prospettiche che consentono di pianificare
un sistema equilibrato e armonico. Stato e Chiesa erigono le proprie costruzioni,
rappresentate rispettivamente da palazzi urbani e vil e e da cattedrali e chiese.
Architettura rinascimentale: la chiesa,
il palazzo, la villa, la città ideale
Ognuno dei tre periodi rinascimentali, pur mantenendo costanti lo stile architettonico e l’ambiente culturale dell’epoca, ha caratteristiche proprie. Anche le tipologie edilizie, di conseguenza, sono soggette a lievi modifiche lungo il tra-scorrere dei secoli.
Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara I La chiesa
Primo Rinascimento
Nel primo Rinascimento viene impiegato più frequentemente lo schema longitudinale a croce latina, con navata unica
circondata da cappelle laterali o a 3 navate; l’ingresso è posto
sul lato breve, mentre l’abside conclude il lato opposto dove è
presente il coro; quest’ultimo è anticipato dal presbiterio, posto all’incrocio tra la navata centrale e i bracci del transetto. La predilezione per queste piante a croce latina, specialmente da
parte del Brunelleschi, è dovuta all’introduzione del modulo
prospettico e di una nuova conseguente conquista lineare dello spazio. La ripetizione del modulo quadrato in pianta (cubico in alzato) permette la formazione delle navate, dei transetti e delle cappelle laterali impostate su campate quadrate.
Equilibrio
Questo elemento modulare, moltiplicato o diviso, genera un
delle tre dimensioni
equilibrio delle tre dimensioni. Per quanto riguarda gli alzati
dell’interno, le pareti sono il piano su cui viene disegnata l’intelaiatura prospettica; la scansione dell’ordine descrive invece lo scheletro strutturale. Nel muro di tamponamento sono scavate nicchie semicircolari sovrastate dall’uniforme disposizione delle finestre, che consente alla luce di illuminare ogni angolo dell’intera aula. La copertura può essere piana, a botte liscia o cassettonata; la cupola posta all’incrocio tra navata e transetto costituisce un elemento costante per gli edifici religiosi.
Esempi di impianti longitudinali sono la chiesa di San Lorenzo e quella di Santo Spirito, a Firenze, del Brunelleschi,
e la chiesa di Sant’Andrea, a Mantova, dell’Alberti.
158
2 - Aspetti tipologici
Insieme agli schemi longitudinali vengono ripresi gli schemi Ripresa dello
centrici già diffusi nell’antichità, poiché il cerchio è il simbolo schema centrico
del divino e forma perfetta (ricordiamo esempi di impianti a
croce greca, cruciforme o centrali come la Sacrestia Vecchia e
la Cappella dei Pazzi, a Firenze, del Brunelleschi). Le facciate
delle chiese sono arricchite da tarsie dicrome che dividono in
parti geometriche le superfici insieme con l’impiego di lesene,
le quali a loro volta definiscono l’altezza della navata centrale
interna, in una corrispondenza reciproca tra esterno e interno
(Sant’Andrea, a Mantova; Santa Maria Novella, a Firenze).
Nel medio Rinascimento si rivoluzionano definitivamente gli Medio Rinascimento
impianti delle chiese, preferendo quelli a pianta centrale: si
abbandona l’equilibrio quattrocentesco per ottenere maggior
dinamismo e plasticità.
Un esempio fondamentale di tempio religioso del tardo RiTardo Rinascimento
nascimento si ritrova nei differenti progetti per la pianta a
croce greca della basilica di San Pietro. I più rilevanti sono
quello del Bramante, del 1505, e quello di Michelangelo, del
1546. Il Bramante propone una croce greca con absidi a con-clusione di ogni braccio, fissando così il modello spaziale. Michelangelo mantiene l’impianto a croce greca, l’ambulacro quadrato sormontato dalla cupola centrale e i bracci della croce, ma elimina tutte le aggregazioni di cellule spaziali bra-mantesche per arrivare a un unico spazio cruciforme sormontato dalla gigantesca cupola.
Con il tardo Manierismo si ritorna all’impianto basilicale, in Tardo Manierismo
particolare per volere della Compagnia dei Gesuiti, che chiede
al Vignola il progetto per la chiesa del Gesù, a Roma (1568).
Rifacendosi alla pianta albertiana, anche qui il progetto configura una navata unica con volte a botte, cappelle laterali basse e cupola all’incrocio tra navata e transetto, con bracci trasversali cortissimi. Il Palladio, dal canto suo, rivoluziona la facciata delle chiese venete attraverso l’uso di motivi classici (chiesa del
Redentore, del 1577, e di San Giorgio Maggiore, del 1566), mentre nelle piante riprende lo schema del Vignola.
I Il palazzo
La tipologia del palazzo rinascimentale si forma in modo gra-Rivisitazione
duale, tramite un processo di aggregazione delle cosiddette delle case
case a corte medievali. Queste case erano dimore organiz-a corte medievali
zate intorno a un cortile circondato da torri, botteghe, magazzini e abitazioni, fino a formare un complesso unitario; il
rinnovamento di queste strutture porta alla nascita del pa-Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara lazzo urbano. Edificio prestigioso, il palazzo è un elemento Elemento simbolo
simbolo della tipologia architettonica rinascimentale, poiché
non è solo residenza di grandi famiglie, ma anche strumento
159
Architettura del Rinascimento
di potere che contribuisce a modificare il tessuto urbano e
a dare magnificenza alla città. Un prototipo del primo Rina-Primo Rinascimento
scimento è rappresentato da palazzo Rucellai (Firenze,
1460), dell’Alberti, primo esempio di applicazione degli ordini classici al fronte di un edificio civile. Due cornici orizzontali dividono la facciata in 3 parti uguali: ogni settore è scandito da un sistema modulare di lesene alternato a bifore a tutto sesto. I semipilastri seguono la sovrapposizione
degli ordini, partendo da tuscanico e ionico per concludere
con il più leggero corinzio; i due estremi dell’edificio, corrispondenti all’attacco al suolo e al suo coronamento, sono caratterizzati dalla fascia basamentale con alto zoccolo e da un pronunciato cornicione. Si genera così una griglia prospettica sovrapposta al bugnato che ricopre il palazzo.
Altri palazzi fiorentini ricalcano le medesime caratteristiche
tipologiche: basti pensare, ad esempio, a palazzo Medici-Riccardi, di Michelozzo (1444), e a palazzo Strozzi, di Benedetto da Maiano (1489).
Tardo Rinascimento
Il tardo Rinascimento vede la realizzazione di opere come palazzo Farnese, di Antonio da Sangallo il Giovane (Roma,
1534), dove permangono la monotonia delle finestre “ingi-nocchiate”, tipiche cinquecentesche, e il cornicione agget-tante finale, ma emerge il contrasto tra la superficie muraria liscia e il bugnato, utilizzato soltanto intorno al portone centrale o a rinforzo degli angoli.
Il Manierismo
Con il Manierismo ci si allontana dai tradizionali principi rinascimentali a favore di nuove illusioni ottiche e palazzi con Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara forme scenografiche: la varietà delle facciate con prospettive distorte, unita all’uso irregolare delle decorazioni, rompe
gli schemi di armonia. Un esempio lampante è Palazzo Te, a
Mantova, di Giulio Romano (1499-1546): qui l’architetto
adotta un linguaggio fatto di serliane ripetute, nicchie dise-guali, bugnato molto accentuato, fregi irregolari, finestre in-corniciate entro archi con motivi ornamentali a ventaglio e colonne tortili. Anche l’architettura civile del Palladio rispecchia i caratteri dei palazzi rinascimentali: si ritrovano il portico a pianterreno, l’ordine gigante, la sovrapposizione
degli ordini, l’equilibrio tra larghezza e altezza, ripetuti giochi chiaroscurali, cornicioni, balaustre e un abbondante uso di sculture (palazzo Thiene, palazzo Chiericati, palazzo Valmarana, palazzo della Ragione, Vicenza, 1550-1566).
I La villa
Vil a Madama
Il primo esempio di villa rinascimentale è il progetto di villa Madama, di Raffaello, del 1516; posta nelle immediate vicinanze di Roma, ricorda nell’impianto una struttura termale. Di stile più
160
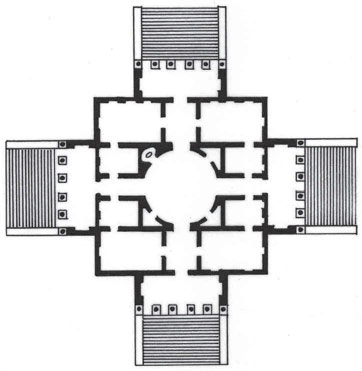
2 - Aspetti tipologici
elegante è Baldassarre Peruzzi: nella sua villa Farnesina, a Ro-Vil a Farnesina
ma, propone una pianta a U con avancorpi laterali aggettanti
verso il giardino e un sottile marcapiano (la fascia orizzontale
che segna la divisione in piani, in questo caso 2). Il ritmo delle
facciate è dato dal loggiato ad arco e da finestre trabeate con paraste angolari lievi. Di tipologia simile sono le ville del Vignola, per l’integrazione dell’edificio con il giardino retrostante grazie
Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara all’impiego di bracci laterali rettilinei o semicircolari, alleggeriti
da loggiati e belvedere. In villa Farnese, a Caprarola (1559), il Vi-Vil a Farnese
gnola raccorda i dislivelli mediante scale rettilinee o curvilinee;
la villa, a pianta pentagonale, offre
contemporaneamente la vista
frontale e laterale, generando un
inserimento della massa edificata
nello spazio.
L’architetto che stabilì nuove regole nell’architettura delle ville fu
Andrea Palladio: di proporzioni
armoniche è villa Capra, detta La
Rotonda (Vicenza, 1566), la cui
particolarità è la pianta geometrica articolata sulla forma del quadrato, del cerchio e del rettangolo. Una sala centrale circolare e cupolata è circondata infatti da 4
sale rettangolari; da ciascuno dei
4 lati del quadrato sporge un pronao, dando origine così a 4 facciate simmetriche. Grazie ai pronai con colonnato ionico e timpano triangolare, al porticato aperto con arco laterale e ai gra- Figura 40
dini di accesso al giardino, il blocco chiuso e compatto della Pianta di villa Capra,
villa si apre in tutte le direzioni verso la campagna, in una fu- detta La Rotonda,
a Vicenza.
sione tra armonia classica e natura.
I La città ideale
La città diviene il principale centro di potere e il luogo in cui
si accentrano le ricchezze e le attività umane. Negli architetti
rinascimentali nasce il desiderio di fondare nuove città o di Nuovo ideale di città
riprogettare quelle più antiche ispirandosi agli stili dell’antichità: le città ideali sono insediamenti urbani che seguono schemi geometrici e leggi della prospettiva in un sistema
equilibrato e armonico. Lo scopo è quello di stabilire un insieme coerente di edifici e di spazi pubblici, che esprima anche i rapporti tra Stato e Chiesa. I palazzi ridisegnano il profilo urbano, le strade e i viali assumono una disposizione cen-161
Architettura del Rinascimento
tralizzata in base alle regole prospettiche, le cattedrali sono
ubicate nel centro cittadino con l’inserimento di fortificazioni per una maggiore difesa.
Pienza, città ideale
Un esempio di città ideale è Pienza: la piazza, di forma trapezoidale, viene iniziata nel 1459 da Bernardo Rossellino (1409-1464); il palazzo vescovile e quello papale divergono rispetto al duomo, posto sul lato lungo del trapezio.
Urbino
Anche il grande cantiere di Urbino è un esempio d’aggregazione di edifici perfettamente coerente con il paesaggio natu-Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara rale e urbano; dal 1466 Luciano Laurana e Francesco di Giorgio Martini (1439-1502) progettano una città-palazzo: l’elegante cortile rettangolare è l’elemento ordinatore delle varie parti del complesso edilizio, illuminato dall’alto, circondato da
pareti traforate mediante l’impiego del loggiato e di finestre
rettangolari intervallate da paraste. L’organismo ben si raccorda con le preesistenze edilizie, nel suo alternarsi di corti e torri cuspidate medievali, generando una compenetrazione tra costruzione e spazio libero. Nel 1538 Michelangelo, con il pro-Piazza
getto di piazza del Campidoglio, a Roma, si pone l’obiettivo di
del Campidoglio
trasformare uno spazio aperto in una piazza trapezoidale che
guarda verso la città moderna attraverso una scala, la quale si
allarga via via che si procede verso l’alto creando una prospettiva centrale perfetta. Ricordiamo infine Sabbioneta, vici-Sabbioneta no a Parma, datata 1554, e Palmanova, presso Udine (1593),
e Palmanova
raro esempio di città ideale a planimetria stellare.
SCHEMA RIASSUNTIVO
LA CHIESA
Il tipo di pianta prediletto nel primo Rinascimento è quello a croce latina, con navata
unica circondata da cappelle laterali e con un rapporto tra moduli quadrati in pianta e
cubici in alzato. Elemento costante è la cupola, posta all’incrocio tra navata e transetto. La pianta a schema centrico, scarsamente utilizzata, viene invece preferita nel medio Rinascimento, come mostrano i progetti di Bramante e Michelangelo per la basilica di San Pietro. Il Manierismo ripropone poi l’impianto basilicale.
IL PALAZZO
Il palazzo rinascimentale ha una forma geometrica chiusa intorno a una corte (vedi palazzo Rucellai, a Firenze), con elementi decorativi classici. Il Manierismo introduce nuove illusioni ottiche e prospettive distorte, come in Palazzo Te, a Mantova.
LA VILLA
Andrea Palladio stabilisce nuove regole nell’architettura delle vil e, con una pianta geometrica articolata sul quadrato, sul cerchio e sul rettangolo. Il blocco della vil a si apre verso la campagna, fondendo l’armonia classica dell’edificio con la natura.
LA CITTÀ IDEALE
Nel Rinascimento nasce il desiderio di costruire città ideali, o di rimodellare quelle esistenti, basandosi su schemi geometrici razionali e leggi prospettiche. Esempi sono Pienza, Urbino e piazza del Campidoglio, a Roma. Palmanova è un raro modello di città
costruita ex novo a planimetria stellare.
162
3 Architetti e opere
Artefici del pieno compimento degli ideali espressi durante l’Umanesimo
– primo fra tutti la riscoperta del a centralità del ’uomo al ’interno del Creato
tramite l’utilizzo del a ragione –, gli architetti del Rinascimento, figure complesse
e polivalenti dedite al e più diverse attività artistiche e scientifiche, riescono
a concretizzare in importanti opere lo spirito del proprio tempo.