La torre e il cavallo
Il giorno in cui compiva sessant’anni, il 18 settembre 1970, Vittorio dette le dimissioni dal sindacato e si ritirò «a vita privata». Così almeno disse, anche se non fu proprio così. Comunque, lasciò la CGIL e vi avrebbe fatto ritorno solo negli anni Ottanta, in tutt’altra situazione, a dirigerne il centro studi. La sera stessa, si imbarcò con Lisa per una vacanza in Sicilia, dove furono raggiunti da mia sorella Bettina. Cominciava per lui una nuova vita. Di questa vita io ho poche memorie dirette, a differenza che per gli anni precedenti e per quelli successivi. Me ne ero andata di casa nel 1964 e dopo la nascita di mio figlio ero molto più vicina alla famiglia di mio marito, più tradizionale, che mi aiutava a prendermi cura del bambino, che a loro, nonni amorevoli ma molto impegnati. Mai come in quegli anni le nostre vite furono distanti. Cerco però di ricostruirle reinserendo nella mia memoria un po’ offuscata quanto emerge dai loro scritti.
Le dimissioni, scrive Vittorio, le aveva maturate nei due anni fra il ’68 e il ’70. È come se il Sessantotto avesse catalizzato tutte le sue insoddisfazioni, tutti i suoi dubbi sulla sua attività di sindacalista, e lo avesse spinto alla ricerca, al mutamento. C’era forse, scrive, anche una sorta di disagio per la nomina di Lama, pochi mesi prima, a segretario generale della CGIL, a cui pure aveva dato il suo assenso. Rileggendo con attenzione quello che ne ha scritto, mi sembra che pensasse che quel ruolo dovesse toccare a lui. Ma sapeva anche che l’unico motivo per cui non era stato così era il fatto che a dirigere la CGIL poteva andare solo un comunista. Il suo legame con il sindacato, rotto a quel punto in maniera traumatica anche se mascherata, era ormai fatto solo di memorie – lui usa anche il termine «tenerezza» – ma sarebbe rimasto sempre vivissimo. Ed è infatti alla CGIL che si tenne il suo funerale, nel 2008, con la sua bara nella camera ardente circondata per un giorno e mezzo da un picchetto che si alternava ogni due minuti. C’era un clima di grande partecipazione, eppure erano passati quasi quarant’anni dalle sue dimissioni, quarant’anni da quando non lo si poteva più definire un «sindacalista». Ma era a casa. Ricordo di essere arrivata là molto presto la mattina con mia sorella Bettina e di aver scambiato qualche parola con delle compagne del sindacato che facevano il primo turno di picchetto. Si erano svegliate all’alba per poter venire – abitavano fuori Roma – e sarebbero subito ripartite per andare al lavoro. La loro partecipazione ci impressionò molto.
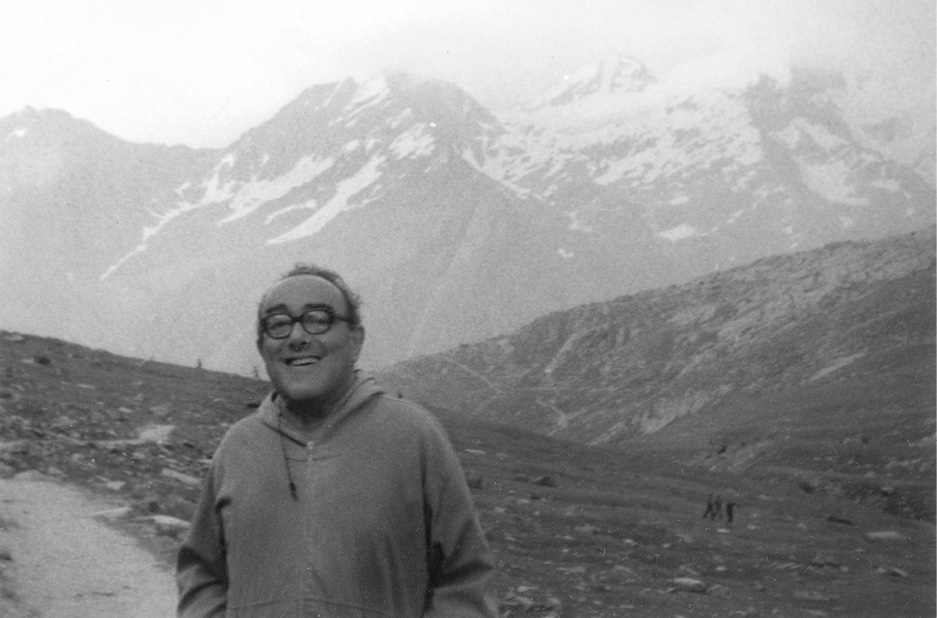
Dopo le dimissioni, Vittorio voleva soprattutto studiare. E poi sperava di ricostruire il rapporto con mia madre, che negli ultimi anni si andava sempre più logorando. Il primo obiettivo gli riuscì, il secondo no. Le loro strade, anzi, si sarebbero divise sempre più, fino alla separazione, nel 1978. La politica, come ho già detto, giocava un ruolo importante in questa loro crisi, e come stupirsene dato il posto importante, anzi determinante che aveva nella vita di entrambi? In Il Cavallo e la Torre mio padre affronta proprio questo problema: «Il mio rapporto politico con Lisetta – scrive – era inseparabile dalla mia visione d’insieme della nostra vita». Nei primi anni, nonostante la diversità delle rispettive posizioni politiche, avevano dei valori comuni, dapprima la memoria resistenziale che volevano trasmettere ai loro figli, poi il gusto di «guardar oltre», un «realismo non privo di spregiudicatezza e quindi di risvolti morali». Forti erano comunque le loro diversità: radicale ed anti-istituzionale mia madre, portato verso sbocchi istituzionali o di governo mio padre. Il radicalismo di sua moglie appariva a Vittorio come «un faro che gli impediva di finire sugli scogli», cioè nelle istituzioni o nel compromesso. Quando questo si era dissolto era finita anche la loro storia comune. Questa l’interpretazione che Vittorio dà della sua separazione. Lisa, invece, nella sua autobiografia, non ne dà spiegazioni. Ma c’è un duro paragrafo sul suo rifiuto della locuzione «il senso dello Stato», inserito proprio nelle pagine dedicate a quegli anni, che forse va in quella direzione. Premette di essere forse prevenuta a causa delle scuole fatte nel periodo fascista, in mezzo alla retorica patriottica. Ma afferma di non comprendere come si possa avere «il senso dello Stato» e vede, dietro lo Stato, apparire il mostro repressivo del Leviatano.
Studiare voleva dire per Vittorio leggere ma anche insegnare: «La mia percezione della politica diventava sempre più contigua con quella dell’educazione», scrive. Nel 1973 comincia a insegnare a Modena, alla facoltà di Economia. Fu questo il suo Sessantotto, si potrebbe dire. La facoltà era nata proprio nel 1968, frutto di un progetto condiviso fra il Partito comunista e la Democrazia cristiana. Ma essa era soprattutto il frutto delle trasformazioni introdotte dalla rivoluzione sessantottina nella vita accademica, dell’attenzione data all’economia politica, che diventava una sorta di scienza privilegiata nell’interpretazione dei processi sociali, e della fortunata circostanza di un gruppo di giovani studiosi, tutti ricollegabili al pensiero di Sraffa e tutti reduci da un intenso periodo di studi a Cambridge, intenti a trasformare gli studi di economia – fino a quel momento prevalentemente orientati a formare i commercialisti – in un corso di economia politica e ancor più in un laboratorio sociale in stretto collegamento con le lotte operaie, il sindacato, i conflitti sociali.
A chiamare Vittorio a insegnare, fu in particolare Andrea Ginzburg. Mia sorella ricorda che solo tre anni prima era stato lo stesso Ginzburg a orientarla verso la facoltà di Modena, dove si sarebbe laureata. Ora Vittorio la seguiva a Modena, da docente. I professori erano tutti di sinistra, in modi e forme diverse, più a sinistra del PCI, come scriveva più tardi uno di loro, Nando Vianello, ricordando quegli anni. E in un primo periodo, ma solo per breve tempo, furono anche visti come estranei non solo alla città, ma anche alla sua vita politica. Era una città tutta comunista, ma anche profondamente razzista verso quegli studenti che venivano dal Sud, non a caso chiamati «maruchein», marocchini. Quando furono varate le 150 ore, che consentivano ai lavoratori un periodo di studio pagato e soprattutto svincolavano lo studio dai suoi esiti pratici, affermando il valore dell’arricchimento personale, la facoltà di Modena decise di non fare corsi separati per i lavoratori, ma di mescolarli agli studenti della facoltà.
È in questo ambiente, che potremmo definire di «aristocrazia del sapere», che Vittorio insegnò alcuni anni Storia sociale contemporanea, rappresentando di fatto il legame della facoltà con il sindacato e con il mondo del lavoro. La facoltà aveva subito richiamato studenti da ogni parte d’Italia, le lezioni erano affollatissime e proseguivano in accese discussioni, spesso davanti a un bicchiere di vino. Studenti e professori, tutti pendolari, dividevano le stesse case in affitto, e da questo punto di vista, come anche da quello del rapporto paritario e non verticale tra colleghi, essa rappresentava davvero una rivoluzione nel mondo accademico italiano. Non durò a lungo, in quella forma. Il nascente terrorismo, l’esodo di molti docenti e la crisi dell’interesse verso l’economia politica contribuirono a normalizzare quell’esperienza. Per mio padre, che da giovane, per disinteresse verso il suo corso di laurea, si era laureato senza frequentare, e che non aveva mai fatto questo genere di vita collettiva, fu un’esperienza stimolante e anche molto divertente. E poi aveva scoperto che insegnare gli piaceva molto. Aveva un grande fascino oratorio, prima lo aveva usato parlando con gli operai, ora lo trasformava in un discorso agli studenti, con gli studenti.
Avrebbe continuato a lungo a tenere corsi sparsi negli anni: a Camerino, a Torino dove avrebbe riannodato i legami con la sua città. Erano per le università gli anni del post-Sessantotto. Cominciavo anch’io a insegnare in quegli anni e ne ricordo bene il clima. La liberalizzazione, l’apertura agli strati non privilegiati, agli studenti lavoratori, aveva portato nelle aule universitarie giovani che consideravano quel percorso di studi come importante per loro, per la loro identità, per il loro futuro. Non era solo il diciotto politico, che fu in definitiva un fenomeno assai limitato e troppo pubblicizzato. Erano le 150 ore in cui gli studenti lavoratori si appassionavano alle lezioni, alle discussioni. Il livellamento tendeva verso l’alto, e non verso il basso come oggi. Almeno questa era la mia percezione nei primi anni in cui insegnavo a Lettere, in una facoltà tradizionalmente di classe che si era appena aperta a studenti che venivano da ogni corso di studi. Per mio padre, che insegnava in una facoltà come Economia, in cui i legami con la politica erano ancora più forti, deve essere stato entusiasmante. L’insegnamento rappresentò forse per lui il passaggio all’attività di scrittura e di riflessione della vecchiaia, e gli insegnò molto.

Non che non ci fossero errori, rischi, e forse si trattò di un momento breve di apertura nel mondo accademico, presto sopraffatto dall’ideologia dei gruppi extraparlamentari, dal ritorno della politica al passato. Ma mi piace pensare che anche questa sia stata l’eredità del Sessantotto.
Lisa si imbatté in Lotta Continua nel 1972, e venne subito attratta – lei che usciva dall’esperienza «austera», come dice, della sinistra storica – dalla sua «anima antiautoritaria e anarchicheggiante», dalla sua «irriverenza». Dal 1973 cominciò a lavorare al giornale, «Lotta Continua», a via Dandolo e poi, dopo lo scioglimento del movimento, a via dei Magazzini Generali. Si occupava – erano i temi che prediligeva – dei Paesi socialisti e in genere delle questioni di politica internazionale. Aveva inoltre fatto molta amicizia con Adriano Sofri e nell’ultima parte della sua vita si batterà con tutte le sue forze per sostenerne l’innocenza ed ottenerne la liberazione. Vivevano le ripercussioni di anni di grandi movimenti, che li entusiasmavano e li coinvolgevano. La Cina, ma anche la rivoluzione dei garofani in Portogallo, il Cile, da cui traevano conseguenze diametralmente opposte a quelle del PCI, che invece vi vedeva la legittimazione del compromesso storico.
Allora, dopo il tragico colpo di Stato di Pinochet, tutti noi dell’area extraparlamentare, non solo loro di Lotta Continua, gridavamo nelle piazze che «il compromesso storico si fa con il fucile». Lisa legava così insieme la sua opposizione durissima al regime liberticida di Brežnev con gli ardori antimperialistici che spingevano fra l’altro tutta la sinistra, vecchia e nuova, a parteggiare senza remore per i palestinesi. Il crogiolo in cui lei mescolava queste spinte in parte contraddittorie era il suo antiautoritarismo, mentre per molti dei suoi compagni era l’ideologia marxista, da cui lei già prendeva le distanze dopo averla misurata nei suoi anni nel PCI, e che le riusciva ardua da accettare anche nella forma spontaneista e non leninista di Lotta Continua. Lotta Continua si sciolse spontaneamente nel 1976, anche se il giornale continuò a vivere fino al 1982.
Anche dopo il 1970 mio padre continuò a fare politica nei partiti. Era la sua fase estremista. Mi domando che spazio lasciasse alla vita di partito dopo la sua uscita dal sindacato, il suo vero amore, e dopo aver preso la decisione di dedicare allo studio il resto della sua vita. Nel PSIUP era entrato nel 1964, quando il piccolo partito era nato dalla scissione del PSI. Mi domando perché abbia attraversato questa fase – che di solito si attraversa da ragazzi, come una malattia esantematica – proprio allora, quando ormai da tanti anni era un leader politico e sindacale di primo piano, con assai poco di estremista nella sua formazione politica. Era forse la sua vena giacobina, radicale? Era l’influsso del Sessantotto? Era una volontà, attraverso l’attenzione all’autonomia delle classi operaie, di riallacciarsi ai vecchi progetti degli anni del PdA? Era il desiderio di uguagliare il percorso politico di sua moglie, compiendone uno analogo, se non identico? Non ho ricordi precisi di quello che accadeva, non ho visto queste vicende da vicino perché ero già fuori casa. E rileggendo quanto lui scrive ho ancor più la sensazione che la rimozione tocchi anche il discorso del dopo, che ci fosse in lui una vera e propria volontà di non ricordare. Il culmine forse di questo momento fu il periodo del PdUP, dal 1972 al 1974, e poi quello successivo di Democrazia proletaria. Ma nel 1979 ebbe il coraggio di staccare la spina e si diede un tempo per riflettere, quattro anni, abbandonando la politica attiva. Nel dialogo con Carlo Ginzburg, questi lo incalza sulle ragioni del suo silenzio. Riconosce che non era certamente una sola, ma insiste sul fatto che il terrorismo vi doveva avere avuto un ruolo importante: «Nel terrorismo – gli dice Ginzburg – vedrei [...] una caricatura grottesca, macabra, di qualcosa che ti stava sommamente a cuore, e cioè un progetto complessivo».
Ambedue, Lisa e Vittorio, ebbero forte il senso dello smarrimento della sinistra extraparlamentare e del prevalere dell’estremismo e del terrorismo, quando andarono a Bologna, nel settembre 1977, a un grande raduno nazionale del movimento. Come tanti altri vicini a loro, non erano partecipanti, ma osservatori. Cercavano di capire e ne tornarono, ricordo, con un grande senso di sconforto. Io, che come docente precaria alla Sapienza, avevo preso parte a lotte e occupazioni all’interno della mia università, avevo derivato una sensazione analoga nei rapporti, difficili e non privi di momenti di conflitto anche materiale, con gli autonomi. Nel febbraio, Lama era stato cacciato dall’università con scontri violenti da parte dell’autonomia operaia. Non ero in facoltà quella mattina, ma ci andai nel pomeriggio per discutere dell’accaduto. Ma, mentre noi docenti della CGIL Scuola aspettavamo in un’aula che qualcuno della Segreteria arrivasse a coordinare quella riunione, ci trovammo soli in un’università deserta, barricata e circondata dalla polizia. Riuscii ad uscire dal cancello principale salendo su una macchina e scavalcandolo. Poi, invece di andare a casa mia, andai dai miei genitori. Raccontai di quel pomeriggio cupo, e cercai un conforto che in realtà non erano capaci di darmi.
Quegli anni fra il 1976 e il 1978, in particolare il 1978 con il rapimento Moro, furono davvero anni difficili, in cui la violenza terrorista era sempre presente alla nostra mente, cambiando il nostro modo di percepire il mondo e le cose in un modo in cui noi stessi non ci rendevamo allora conto. Condannare decisamente il terrorismo, nella sinistra extraparlamentare in cui io, sia pur da lontano, mi identificavo, non era affatto scontato. Ripensandoci ora, avremmo potuto fare molto più di quello che abbiamo fatto, o meglio non abbiamo fatto, per evitare quella deriva sanguinosa. La condanna nei miei genitori era nettissima, anche se talmente ovvia da non dover essere quasi espressa, né nell’uno né nell’altra ci furono mai cedimenti. Lo slogan «Né con lo Stato né con le BR» non ebbe nessuna presa su di loro, né in Vittorio, con il suo forte senso dello Stato, né su Lisa, tanto più anarchica. La loro divisione, che era profonda, era invece sul problema delle trattative con le BR. Lisa, come tutta Lotta Continua, era favorevole alle trattative. Le sembrava che rifiutando di trattare per salvare delle vite umane si valorizzassero i terroristi, si attribuisse loro una capacità di colpire il cuore dello Stato che in realtà non avevano. Vittorio era contrario ad ogni trattativa, ritenendola invece una legittimazione del terrorismo. Il problema era sempre quello di avere o meno il «senso dello Stato».
Periodicamente ritornano anche oggi le spiegazioni del terrorismo in chiave complottistica, il richiamo agli infiltrati dei servizi, alle oscure trame di forze occulte. Ma il terrorismo, come lo vivemmo nella sinistra, come ricordo che lo vivevamo nella mia famiglia, era, per dirla con la definizione di Rossana Rossanda, una storia di famiglia. Il che non vuol dire che gli infiltrati non ci fossero, che i complotti non ci fossero, ma che non erano determinanti, che non erano il cuore di quella storia. Questo rese il terrorismo una minaccia ancora più grave e oscura. Non so quanto il terrorismo di quegli anni abbia contribuito a mettere in crisi la sinistra, e in genere l’intera vita politica italiana o se invece fosse esso stesso il figlio degenere di questa crisi. Stranamente non se ne parla; nessuno si domanda come ci abbia cambiati aver vissuto per anni a contatto con attentati, gambizzazioni, folli proclami ideologici. Mi domando quanto la parola «comunismo», che in altri Paesi era divenuta una bestemmia a causa dei gulag e dei carri armati sovietici, lo diventasse per noi confrontati quotidianamente con il suo uso nei documenti delle BR. Qualcuno potrebbe obiettarmi che c’erano anche gli attentati della destra, piazza Fontana, Brescia, l’Italicus. Ma quelli non erano roba nostra, nostri figli, e potevamo pensarli senza imbarazzo. E, soprattutto, mai un attentato può bilanciarne o giustificarne un altro.
Fu in quegli anni che l’Africa entrò a far parte della nostra vita e dei nostri discorsi di famiglia. Non che fino ad allora non vi avessimo dedicato attenzione. Erano, i primi anni Sessanta, gli anni della decolonizzazione, in cui nella sinistra in Italia si era letto Fanon e ci si mobilitava per le guerre di liberazione dei popoli colonizzati. Renzo aveva vissuto con estrema partecipazione l’assassinio di Lumumba, tanto che ne scriveva ancora così tanti anni dopo, nel suo libro In cattiva compagnia: «Quando ripenso ai miei di eroi, mi accorgo di essermene trascinato dietro uno solo, il più vecchio di tutti, Patrice Lumumba». Nel 1961, quando avevamo partecipato alla prima marcia della pace da Perugia ad Assisi, lui, che aveva allora quindici anni, portava sulla schiena un cartello con la foto del leader congolese assassinato. Perfino io, che ero la più eurocentrica della famiglia, avevo vissuto con passione la guerra d’Algeria. Nostra madre, che all’epoca si occupava dell’edizione italiana della «Monthly Review», la rivista della sinistra americana diretta da Paul Sweezy e Leo Huberman, dedicava, in quella pubblicazione, una grande attenzione alle vicende africane.
Ora era la volta di Bettina che non si limitò a manifestare sulle strade sicure di Roma ma, da poco laureata in economia, nel 1977 partì come cooperante per il Mozambico. La sua attenzione per le vicende di quel Paese, che aveva ottenuto nel 1975 l’indipendenza dal Portogallo dopo una dura guerra di liberazione condotta dal FRELIMO (Fronte di liberazione del Mozambico), era, oltre che politica, determinata dalla volontà di partecipare a un’esperienza reale, abbandonando le ideologie della vecchia Europa. Il Mozambico era in quegli anni affollato di giovani della sinistra di tutta Europa che vi vedevano una possibilità di salvare un’idea di socialismo meno oppressivo e meno legato all’Unione Sovietica, al contrario di quanto accadeva in Angola. Un socialismo dal volto umano, insomma. Bettina aveva abbandonato il suo estremismo politico degli anni del liceo a Roma studiando all’università a Modena, dove aveva assunto un atteggiamento più critico del marxismo-leninismo tanto in voga in quegli anni. Credo che anche per lei, come furono per i nostri genitori gli anni della Resistenza, quei primi anni in Africa siano stati un momento alto, in cui, con i suoi compagni della cooperazione e con i mozambicani, cercavano di costruire un Paese nuovo, si battevano politicamente contro l’apartheid del Sudafrica, avevano poco da mangiare, e si innamoravano perdutamente del Paese in cui vivevano e di cui progettavano uno sviluppo senza troppe disuguaglianze.
Lisa andò spesso a trovarla, e anche Renzo andò una volta, per il suo giornale, «l’Unità», con una nave di solidarietà. A me e a Vittorio, Bettina aveva invece sconsigliato di andare, dicendo che saremmo impazziti subito dopo essere scesi dall’aereo, «ipertiroidei» come eravamo, di fronte alla concezione temporale più dilatata dell’Africa. La prendemmo in parola e non andammo. Invece Lisa, come ho detto, andò più volte, anche perché si preoccupava per Bettina, che soprattutto più tardi, in Burundi, viveva in zone pericolose: andando anche lei negli stessi posti le sembrava di proteggerla. Andò, guardò, rifletté. Politicamente, rispetto a quei giovani cooperanti, era molto più disincantata nei confronti di quanto veniva dall’URSS ma, a differenza che nei Paesi dell’Est che aveva frequentato in passato, là trovava apertura, libertà e possibilità di discussione. «Si continuava a sperare – scrive – in una forma di socialismo africano meno rigido e costrittivo di quello già sperimentato. [...] Com’è noto, non andò così».
Intanto, alla fine degli anni Settanta, la crisi tra Vittorio e Lisa si approfondiva. Nel 1977 ci fu ancora un momento insieme a Londra, erano tutto il giorno a studiare alla British Library e la sera vedevano gli amici. Vittorio lavorava al suo libro sull’Inghilterra del primo Novecento, in cui avrebbe trasfuso tanto della sua riflessione sui cambiamenti in corso nella sinistra dei suoi giorni e di quelli che lo travagliavano, una sorta di prima autobiografia trasposta nel passato. Li raggiunsi a Londra per una decina di giorni. Vivevamo ad Hampstead Heath, avevamo scoperto di abitare per caso vicino a Carlo Ginzburg e a sua moglie Luisa e la sera andavamo a bere tutti insieme una Guinness. Il momento era interessante: c’era una crisi economica in atto e grandi tensioni sociali con scioperi e cortei che già preludevano al clima sotto la Thatcher.
Pochi mesi dopo i miei genitori si separarono. Vittorio aveva quasi settant’anni, Lisa cinquantacinque. Vittorio abitò qualche mese a casa mia, poi si trasferì in un piccolo appartamento nel mio stesso palazzo, a Trastevere, nell’altra scala. Lisa continuò a stare in via Metastasio, dove abitavano già da parecchi anni. Dopo via Cristoforo Colombo, che avevano venduto per comprare una casa a me e a Renzo, si erano trasferiti, in affitto, prima in una casa in via del Boschetto, e poi in via Metastasio, in un appartamento luminoso all’ultimo piano.
Vittorio passava gran parte del suo tempo a scrivere, batteva a macchina prima su una Olivetti 44, poi su una piccola macchina elettronica. Aveva sempre scritto a macchina, le lettere, non molte, che ho di lui sono tutte dattiloscritte, e anch’io avevo imparato da lui ad abbandonare la penna, tanto che ora quando scrivo a mano non riesco a decifrare la mia stessa scrittura. Aveva sempre scritto molto, articoli, saggi, proposte politiche, ma ora stava scrivendo un libro di storia, il figlio di carta che ha amato di più, tanto che pochi giorni prima di morire mi raccomandò: «Abbi cura del mio libro». La Gerusalemme rimandata. Domande di oggi agli inglesi del primo Novecento era un libro con una storia travagliata. Vittorio ci stava lavorando dal 1973, e una prima versione, che aveva dato a Rosenberg & Sellier, era pronta nel 1980. Il libro era una sorta di riflessione autobiografica sul mutamento del lavoro e della sua organizzazione attraverso la storia dei lavoratori inglesi tra 1900 e 1920. «Per me – scriveva nel 1980 in occasione di un convegno sulla storia sociale – la storiografia è autobiografia. Ho fatto l’organizzatore di sindacati e poi mi sono messo a leggere e perfino a scrivere di storia per capire meglio problemi non risolti nella mia vita di lavoro, per darmi ragione di me stesso». Ma i giovani storici della casa editrice – fra loro Giovanni Levi – lo avevano molto criticato e Vittorio lo aveva ritirato per riscriverlo e rimeditarlo. Credo non li abbia mai perdonati. Uscì infine nel 1985, senza nessun successo di pubblico e con poche recensioni. Ottaviano Del Turco gliene scrisse una in cui lo esortava a «riscrivere in italiano quella sua autobiografia».
Nonostante la difficoltà del libro, Vittorio gli era rimasto molto attaccato. Non aveva avuto molta circolazione; lui nel frattempo aveva scritto molti altri libri per Einaudi, e avrebbe voluto ripubblicarlo. Ma l’editore, Rosenberg, rifiutava di cederne i diritti. Solo dopo vent’anni, scaduti i termini di legge, poté darlo a Einaudi, l’editore di quasi tutti gli altri suoi libri, e chiese al suo vecchio amico Pino Ferraris di scriverne l’introduzione. Il libro uscì dopo la sua morte, nel 2009, e ora non c’è più nemmeno Pino.
Quando lo scriveva erano gli anni del suo silenzio, chiusosi nel 1983: una pausa di riflessione e di raccoglimento, lontano dall’attività politica, da cui uscì mutato. In quel libro, come accennato, mise tutta la sua riflessione sul suo passato e ne uscì come trasformato. Studiava una sconfitta del movimento operaio, quella del 1920, la sconfitta della «presa di possesso da parte della classe operaia del suo destino». E cercava, in quella riflessione storica, di conciliare lavoro e libertà. Era una critica durissima al marxismo, incapace di avvicinarsi alla «soggettività, alla complicata esperienza di vita e di lavoro degli operai». «Questi inglesi – scriveva per la quarta di copertina – mi hanno aiutato a capire meglio quello che nel corso di una lunga vita mi è parsa una distinzione importante: che politica non è solo comando, è anche resistenza al comando, che politica non è, come in generale si pensa, solo governo della gente, politica è aiutare la gente a governarsi da sé». Da là, sostanzialmente dalla libertà, sarebbe ripartito. Era diventato un «saggio». Secondo Pietro Marcenaro, era anche diventato buono, mentre precedentemente era più incline alla cattiveria. Ma di questo, se anche era vero, io da figlia non mi ero mai accorta. Ben presto avrebbe avuto una nuova compagna, Sesa, con cui avrebbe passato la vecchiaia, una vecchiaia che per lui sarebbe stata lunghissima e ricca di scritti e rapporti con il mondo.