Eguaglianza, aspettative e invidia
1
Tutti conosciamo i benefici arrecati dai duemila anni della civiltà occidentale: un incremento straordinario della ricchezza, delle riserve di cibo, delle conoscenze scientifiche, dei beni di consumo; siamo più protetti contro le malattie, abbiamo maggiori speranze di vita e più opportunità di miglioramento economico. Forse meno evidente, e più sconcertante, è che questi sbalorditivi progressi materiali siano stati accompagnati da un fenomeno di cui non si fa menzione nel discorso di Nixon ai sovietici: l’aumento dell’ansia da status tra la popolazione occidentale comune, cioè l’accresciuto interesse per il prestigio personale, il successo e il denaro.
Quanto più i livelli effettivi di povertà si riducono, tanto più probabilmente – e paradossalmente – perdura, o addirittura cresce, il senso di privazione e di paura. Un’umanità benedetta da ricchezze e possibilità che i nostri avi, occupati nel Medioevo a coltivare il suolo dell’Europa, nemmeno avrebbero potuto immaginare, si è dimostrata incredibilmente pronta a sentirsi insoddisfatta di ciò che è e di ciò che possiede.
2
Ma questo senso di privazione, alla luce dei meccanismi psicologici in base ai quali stabiliamo quando sentirci appagati, non è poi così sorprendente. I livelli di ricchezza e di stima ai quali aspirare non vengono mai stabiliti secondo un criterio unico e indipendente, ma a partire dal confronto tra la nostra condizione e quella di un gruppo di riferimento, che giudichiamo essere quello dei nostri pari. Non siamo in grado di apprezzare ciò che abbiamo di per sé o in rapporto a ciò che possedevano i nostri antenati nel Medioevo. Né ci fermiamo a riflettere, in un’ottica storica, sulla nostra condizione di prosperità e ci riteniamo fortunati solo quando abbiamo ciò che hanno le persone con cui siamo cresciuti, con cui lavoriamo, stringiamo amicizia e ci identifichiamo nella sfera pubblica. E meglio ancora se abbiamo qualcosa di più di loro.
Se fossimo costretti a vivere in una casupola malsana e piena di spifferi, a piegarci alla volontà di un nobile, proprietario di un enorme castello ben riscaldato, e constatassimo che tutti i nostri simili vivono nelle stesse condizioni, la nostra vita ci apparirebbe normale. Misera, certo, ma non tale da generare sensi d’invidia. Viceversa, pur avendo una bella casa e un buon lavoro, se durante una riunione a cui abbiamo incautamente deciso di partecipare nella scuola di nostro figlio apprendiamo che alcuni nostri vecchi amici (in mancanza di un gruppo di riferimento più connotato) possiedono un’abitazione più grande e hanno fatto una brillante carriera, rientriamo afflitti da un profondo senso di sventura.
La sensazione che avremmo potuto essere diversi da come siamo genera ansia e risentimento. Se siamo piccoli, vivere con chi ha la nostra stessa statura non ci preoccupa (figura 1).
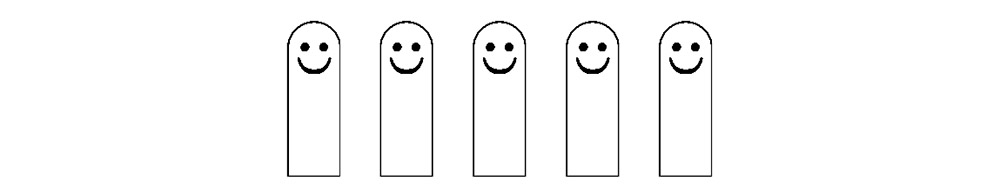
figura 1
Ma se uno o più membri del gruppo crescessero un po’, ci sentiremmo all’improvviso a disagio, scontenti e invidiosi, pur non avendo perso nemmeno un centimetro (figura 2).

figura 2
Date le disuguaglianze con cui quotidianamente ci confrontiamo, forse val la pena osservare che è impossibile invidiare chiunque: una persona baciata dalla sorte ci può lasciare totalmente indifferenti, mentre un’altra, che gode di fortune molto minori, può essere fonte di continuo tormento. Invidiamo chi riteniamo simile a noi, cioè solo i membri del nostro gruppo di riferimento. Pochi successi sono più insopportabili di quelli dei nostri pari.
3
David Hume, Trattato della natura umana (1739):
«A proposito dell’invidia che sorge da una superiorità altrui, val la pena di osservare che non è la grande sproporzione fra noi e un’altra persona a suscitarla, ma, al contrario, il nostro esserle vicini. Un soldato semplice non invidia il suo generale quanto il suo sergente o il suo caporale; e un eminente scrittore nutre gelosia non tanto per i comuni imbrattacarte quanto per gli autori che gli sono più vicini. Per la verità, si potrebbe pensare che quanto maggiore è la sproporzione, tanto maggiore sarà l’infelicità causata dal confronto. Possiamo osservare, al contrario, che una grande sproporzione spezza la relazione, e ci impedisce di metterci al confronto con ciò che è così lontano, oppure diminuisce gli effetti del confronto».
4
Ne consegue che più grande è il numero delle persone che consideriamo nostri pari e coi quali, perciò, ci confrontiamo, tanto più numerosi saranno coloro che suscitano la nostra invidia.
Se le grandi rivoluzioni verificatesi nella politica e nei consumi durante il diciottesimo e il diciannovesimo secolo hanno generato l’ansia, oltre a un miglioramento delle condizioni materiali di vita dell’umanità, ciò è dipeso dagli ideali assolutamente nuovi a cui si sono ispirate: la convinzione che gli uomini sono tutti uguali e la fede nelle capacità, che ha ognuno di noi, di realizzare qualsiasi cosa.
Gran parte della storia era stata, infatti, dominata dalla concezione opposta: l’ineguaglianza fra gli uomini e le scarse opportunità di cambiamento erano considerate un fatto non solo normale, ma anche opportuno. Solo pochi aspiravano alla ricchezza e al successo, la maggioranza della popolazione sapeva di essere condannata a una vita di sfruttamento e di rassegnazione.
«È evidente che alcuni uomini siano per natura liberi e altri per natura schiavi, e che per questi ultimi la schiavitù sia utile e giusta» afferma Aristotele nella Politica (350 a.C.), suscitando l’approvazione di quasi tutti i pensatori e i capi greci e romani. Nel mondo antico gli schiavi e gli addetti ai lavori manuali in genere erano considerati esseri privi di ragione e, pertanto, naturalmente destinati a vivere una vita squallida, proprio come le bestie da soma impiegate per l’aratura dei campi. Sostenere che avessero diritti e aspirazioni sarebbe stato, per l’élite del tempo, assurdo come interrogarsi sullo stato mentale e sul grado di felicità di un martello o di una falce.
L’idea che le disuguaglianze fra gli uomini fossero giuste o, quanto meno, immutabili era spesso condivisa anche dalle fasce oppresse della popolazione. Con la diffusione della dottrina cristiana, nel tardo Impero romano, molti furono indotti dalla religione a interpretare la discriminazione di cui erano vittime come il riflesso di un ordine naturale invariabile. Malgrado il cristianesimo predicasse il principio dell’uguaglianza, i teorici politici d’ispirazione cristiana non proposero quasi mai di riformare la struttura sociale in modo che gli individui godessero in maniera più equa delle ricchezze della terra. Gli uomini erano sì tutti uguali davanti a Dio, ma ciò non li indusse mai a perseguire l’uguaglianza nella vita pratica.
Secondo loro, dunque, una solida società cristiana doveva essere una monarchia basata su un sistema rigorosamente gerarchico che, come si sosteneva, rispecchiava l’ordine celeste: così come Dio deteneva il potere assoluto su tutto il creato, dagli angeli alle creature più umili, come i rospi, i governanti della terra reggevano società in cui Dio aveva conferito a ogni individuo – al nobile e al contadino – il suo posto. Perciò, accusare un aristocratico inglese del Medioevo di «snobismo» per il suo atteggiamento nei confronti dei sottoposti non avrebbe avuto alcun senso.
L’accezione negativa del termine «segregazione» comparve solo quando si iniziò a concepire una visione più egualitaria della società.
Sir John Fortescue, giurista inglese vissuto nel quindicesimo secolo, ribadisce un’idea profondamente radicata nella mentalità medievale quando afferma: «Dall’angelo più alto a quello più basso, non ce n’è uno che non abbia un superiore e un sottoposto; né, dall’uomo all’ultimo verme della terra, esiste una creatura che non sia per certi aspetti superiore e per altri inferiore a un’altra». Porre in dubbio la ragione per cui alcuni erano condannati a vangare la terra mentre altri banchettavano in sale sontuose equivaleva, per la concezione dominante del tempo, a sfidare la volontà del Creatore.
Con il Policratico (1159), Giovanni di Salisbury era divenuto lo scrittore cristiano più famoso per aver paragonato la società al corpo umano ed essersi avvalso di questa analogia per giustificare un sistema basato sulla disuguaglianza. A suo avviso, ogni parte dello stato era equiparabile a un organo del corpo umano: il governante alla testa, il parlamento al cuore, la corte ai fianchi. Ufficiali e giudici erano gli occhi, le orecchie e la lingua. Il ventre e l’intestino rappresentavano il tesoro, l’esercito le mani, i contadini e i lavoratori manuali i piedi. La tesi implicava, in sostanza, che nella società tutti avessero un ruolo immutabile e che per un agricoltore sarebbe stata una bizzarria pretendere di vivere in un maniero e dire la sua al governo, proprio come per un occhio lo sarebbe stato svolgere le funzioni di un piede.
5
Fu necessario attendere la metà del diciassettesimo secolo perché il pensiero politico abbracciasse una visione più egualitaria.
Nel Leviatano (1651), Thomas Hobbes sostenne che gli individui fossero comparsi molto prima delle società e che le avessero create solo a loro beneficio, accettando di rinunciare ai loro diritti naturali in cambio della protezione. Hobbes elaborò, in tal modo, un’idea fondamentale che pochi decenni dopo sarebbe stata ripresa da John Locke nei Due trattati sul governo (1689). Dio, sosteneva Locke, non ha concesso il «dominio personale» della terra a Adamo, ma «all’umanità intera», per la gioia di tutti. I governanti erano gli strumenti del popolo, e si doveva loro obbedienza proprio perché tutelavano l’interesse generale. Dal suo pensiero ebbe origine un’idea straordinariamente moderna: i governi trovano giustificazione nella capacità che hanno di favorire la prosperità e nella serenità del popolo che amministrano.
Le aspirazioni a un sistema più equo sul piano politico, economico e sociale trovarono infine, dopo un secolo e mezzo, un’espressione concreta ed eclatante nella Rivoluzione americana del 1776, che più di qualsiasi altro evento della storia occidentale, forse anche più della Rivoluzione francese, cambiò per sempre i criteri di conferimento dello status. Le società fondate su una gerarchia aristocratica ereditaria che limitava le possibilità di sviluppo e di progresso stabilendo la posizione sociale di ciascuno in funzione dell’età e del prestigio famigliare si trasformarono sulla spinta delle dinamiche economiche e cominciarono a identificare il prestigio sociale col successo – perlopiù economico – di ogni nuova generazione.
Nel 1791 il geografo Jedidiah Morse descriveva il New England come una terra «in cui ogni uomo si ritiene valido almeno tanto quanto i suoi vicini, e crede che tutti abbiano, o debbano avere, pari diritti». Il galateo americano assunse sempre più un’ottica democratica: la servitù smise di chiamare il datore di lavoro «padrone», e i titoli «Esq.» e «Eccellenza» furono banditi. Tutti gli stati americani abolirono la primogenitura, e sia le figlie sia le vedove ebbero pari diritti di proprietà. Nell’Oration on the Advantages of American Independence, tenuta il 4 luglio 1887, il medico e storico David Ramsay spiega che lo scopo della Rivoluzione era stato quello di creare una società in cui «tutte le cariche siano accessibili agli uomini meritevoli, di qualsiasi rango e condizione. Anche le redini dello stato possono essere rette dal più povero, purché possieda capacità tali da essere all’altezza della sua importante posizione». Nella sua autobiografia Thomas Jefferson afferma di aver cercato nella sua vita di «favorire l’aristocrazia della virtù e del talento», per sostituire la vecchia aristocrazia fondata sui privilegi e, in molti casi, sulla brutale stupidità.
In una prefazione a Foglie d’erba (1855), Walt Whitman attribuisce la grandezza dell’America alla diffusione dello spirito egualitario e all’assenza di atteggiamenti deferenti per i ceti delle classi sociali elevate: «Il genio degli Stati Uniti non sta esclusivamente o prevalentemente nei dirigenti o nei legislatori, negli ambasciatori, negli autori, nei college, nelle chiese o nei salotti, e nemmeno nei giornali e negli inventori [...] ma sempre e soprattutto nella gente comune [...] quell’espressione che hanno, di persone che non sanno che cosa si provi a stare di fronte a un superiore [...] nell’incredibile valore simbolico delle elezioni, il Presidente che si leva il cappello di fronte a loro, non il contrario...»
6
Eppure, persino i fautori delle rivoluzioni democratiche e del benessere per tutti non possono fare a meno di sottolineare un problema che affligge le società egualitarie moderne nato da questo spirito. Uno dei primi pensatori a occuparsene fu Alexis de Tocqueville.
Durante il suo viaggio negli Stati Uniti, attorno al 1830, il magistrato e storico francese documentò un male inaspettato, in grado di corrompere le anime dei cittadini della nuova repubblica. Gli americani possedevano molte ricchezze materiali, ma tale agiatezza non impediva loro di desiderare sempre di più né di tormentarsi se altri disponevano di beni che a loro mancavano. In un capitolo della Democrazia in America (1835), intitolato «Perché gli americani sono spesso tanto inquieti in mezzo alla loro prosperità», Tocqueville effettua un’analisi, che ancor oggi conserva una sua validità, del nesso tra insoddisfazione e aspettative elevate, tra invidia e uguaglianza:
«Quando si aboliscono tutte le prerogative legate alla nascita e alla ricchezza, quando ogni professione è accessibile a chiunque, un uomo ambizioso potrebbe ritenere che sia facile intraprendere una carriera brillante e che lo attenda un destino fuori dal comune. Questa è, tuttavia, un’illusione, che l’esperienza ben presto infrange. Quando l’ineguaglianza costituisce la regola generale di una società, le ineguaglianze più gravi non attirano alcuna attenzione. Ma quando tutto è più o meno uniforme, si nota anche la minima variazione [...] Tale è la ragione di quella strana malinconia che spesso affligge gli abitanti delle democrazie che vivono nell’agio e di quel disgusto per la vita che talora li assale anche in circostanze tranquille e serene. In Francia ci preoccupiamo dell’aumento del tasso di suicidi. In America il suicidio è raro ma, a quanto mi è stato riferito, la pazzia è più diffusa che in qualsiasi altro paese».
Esperto conoscitore dei limiti delle società aristocratiche, Tocqueville non auspicava un ritorno alla situazione precedente il 1776 o il 1789: sapeva che gli abitanti dell’Occidente godevano di uno standard di vita ben superiore a quello delle classi meno abbienti dell’Europa medievale. Tuttavia osservava che queste ultime possedevano una serenità mentale che ai loro successori sarebbe stata per sempre negata:
«Quando il potere regio, appoggiandosi sull’aristocrazia, governava in pace i popoli d’Europa, la società, pur in mezzo alle miserie, godeva di parecchi vantaggi, che oggi difficilmente si possono concepire e apprezzare. Il popolo, non immaginando regime diverso da quello esistente, accoglieva il bene e non discuteva sui diritti. Si vedeva l’ineguaglianza delle sorti, ma non se ne avvertiva la degradazione. Da un lato stavano i beni, la forza, i piaceri, il lusso, le raffinatezze, la cultura e l’arte; dall’altro il lavoro, la volgarità e l’ignoranza. Eppure, nel seno di questa folla grossolana si potevano incontrare passioni forti, sentimenti generosi e fedi profonde. Così la società godeva di stabilità, di potenza e di gloria».
Tuttavia le democrazie avevano abbattuto ogni barriera in ordine alle aspettative: tutti i membri della comunità si sentivano teoricamente uguali, persino quando non possedevano i mezzi per raggiungere l’eguaglianza materiale. «In America» scrive ancora Tocqueville «non ho mai incontrato un cittadino tanto povero che non avesse un barlume di speranza e invidiasse i ricchi per i loro diletti.» I poveri studiavano da vicino il modo di vivere dei ricchi, certi che un giorno ne avrebbero seguito le orme, e non sempre si illudevano: molti fecero fortuna dal nulla, anche se è pur sempre vero che l’eccezione non conferma la regola. L’America aveva ancora una classe disagiata che ora, tuttavia, a differenza dei ceti poveri delle società aristocratiche, considerava la sua condizione come un tradimento delle aspettative umane.
La diversa concezione di povertà nelle società aristocratiche e in quelle democratiche emergeva con particolare evidenza, secondo Tocqueville, dall’atteggiamento dei servitori nei confronti dei padroni. Nelle aristocrazie i primi accettavano spesso di buon grado il loro destino e, come sottolinea lo scrittore, avevano talora «sentimenti elevati, orgoglio e rispetto di se stessi». Nelle democrazie, viceversa, il clima creato dalla stampa e dall’opinione pubblica li incitava continuamente a credere di poter scalare i vertici della società e diventare industriali, giudici, scienziati o presidenti. La convinzione dei meno abbienti di avere possibilità illimitate favorì all’inizio un atteggiamento apparentemente cordiale, soprattutto tra i servitori giovani, e in effetti aiutò i più abili e i più fortunati a raggiungere i loro obiettivi; ma col passare del tempo, i molti che non riuscirono a elevarsi socialmente, come notò lo stesso Tocqueville, caddero in preda a un pessimismo e un’amarezza che, oltre a tarpare lo spirito, fomentarono un odio violento per i padroni e per se stessi.
Il rigido sistema gerarchico sul quale si ressero quasi tutte le società occidentali sino al diciottesimo secolo, tranne in pochi casi, negava ogni speranza di riforma sociale; il sistema tanto esaltato da Giovanni di Salisbury e John Fortescue era ingiusto per mille ragioni, ma garantiva alle classi meno fortunate una grande libertà: quella di non dover prendere come riferimento i successi di numerosi membri della comunità e, di conseguenza, di non sentirsi privi di status e d’importanza.
7
Alcuni decenni dopo Tocqueville, un altro americano, William James, studiò il problema delle società che generano aspettative illimitate, ma da un punto di vista psicologico.
A suo avviso, per sentirci appagati non bisogna avere successo in tutti gli ambiti esistenziali; non sempre, cioè, ci sentiamo umiliati dai nostri fallimenti, ma solo quando investiamo interamente il nostro amor proprio e la nostra autostima per poi constatare di non essere riusciti a raggiungere lo scopo che ci eravamo prefissi. È la natura stessa dei nostri obiettivi a stabilire che cosa sarà per noi il successo o il fallimento. James, docente di psicologia a Harvard, aveva mobilitato tutte le sue energie per diventare un illustre psicologo: di conseguenza, per sua stessa ammissione, se aveva a che fare con un collega più dotto, lui provava invidia e vergogna. Viceversa, dato che non si era mai prefisso di imparare il greco antico, se qualcuno fosse riuscito a tradurre l’intero Simposio nel tempo che a lui non bastava nemmeno per tradurre la prima riga, la cosa non l’avrebbe turbato minimamente.
«Non vi è tentativo, non vi può quindi essere insuccesso; non essendovi insuccesso, non vi può essere umiliazione. Così il sentimento di noi in questo mondo dipende interamente da ciò che ci contentiamo di essere e di fare. Esso è determinato dal rapporto fra ciò che siamo e ciò che supponiamo di poter essere:
|
Autostima |
= |
Successi |
» |
Pretese |
L’equazione di James spiega come all’aumentare delle aspettative, aumenti anche il rischio dell’umiliazione. Determinante, nel valutare le chance che abbiamo d’essere felici, è ciò che consideriamo normale per noi. Pochi tormenti sono paragonabili all’angoscia dell’attore in declino o del politico caduto in disgrazia o ancora, come sottolinea Tocqueville, dell’americano che non ha avuto successo.
L’equazione suggerisce, inoltre, due strategie efficaci per aumentare la propria autostima: da un lato, cercare di ottenere più risultati, dall’altro, ridurre il numero degli obiettivi prefissati. James ricorda, in particolare, i vantaggi del secondo approccio:
«Il diminuire le pretese è un sollievo tanto efficace quanto il soddisfarle [...] Si prova una singolare leggerezza nel cuore quando si finisce per accettare con buona pace la propria nullità in un dato ramo di attività [...] Com’è lieto quel giorno in cui abbandoniamo il tentativo di apparire giovani – o magri! [...] Grazie a Dio, diciamo, quelle illusioni se ne sono andate. Ogni cosa che s’aggiunga all’Io è un oppressore, nel tempo stesso che è una ragione d’orgoglio».
8
Purtroppo per la nostra autostima, i meccanismi della società occidentale non ci aiutano a rinunciare alle ambizioni o ad accettare i chili e gli anni in più, per non parlare della povertà e dell’anonimato, ma ci inducono a dedicarci ad attività e alla conquista di beni che per i nostri avi non erano nemmeno concepibili. Come risulta dall’equazione di James, se il livello delle nostre ambizioni aumenta eccessivamente, diventerà pressoché impossibile conservare una profonda autostima.
I pericoli del crollo delle aspettative crescono ulteriormente con l’indebolirsi della fede religiosa: chi crede che la vita terrena sia il breve preludio della vita eterna controlla i sentimenti di invidia pensando che il successo altrui non è che un particolare nel grande affresco del progetto divino.
Se, invece, credere nell’aldilà è per noi una cosa illusoria e infantile, oltre che contraria alla verità scientifica, l’ansia di successo viene inevitabilmente alimentata dall’idea che questa sia la nostra unica, breve occasione per realizzarci. I successi terreni non vengono più visti come premessa di quanto si compirà nell’altro mondo, ma come somma totale di tutto quello che siamo e che saremo.
La ferma convinzione che la vita sia necessariamente infelice è stata per secoli uno dei beni più preziosi dell’uomo, un baluardo contro l’amarezza, un punto di riferimento che le aspettative generate dalla mentalità moderna hanno seriamente incrinato. In toni consolanti, nella Città di Dio (427 d.C.) sant’Agostino parla dell’infelicità come di un dato immutabile dell’esistenza, come di una parte inseparabile della «sventura della condizione umana» e rifiuta «tutte quelle teorie di cui gli uomini si sono strenuamente avvalsi per trovare, nell’infelicità di questa vita, la gioia personale». Influenzato dalla concezione agostiniana, così scrive il poeta francese Eustache Deschamps (ca. 1338-1410):
Tempo di lutto e di tentazione.
Un’età di lacrime, d’invidia e di tormento.
Un tempo di languore e di dannazione...
Temps de doleur et de temptacion,
Aages de plour, d’envie et de tourment,
Temps de langour et de dampnacion...
Quando seppe che il figlioletto di un anno era morto, Filippo il Buono, duca di Borgogna (1396-1467), replicò con parole tipiche dell’epoca premoderna: «Se solo Dio si fosse degnato di far morire me tanto giovane, mi sarei ritenuto fortunato».
9
L’era moderna, tuttavia, non si è dimostrata altrettanto generosa e benevola nei confronti del suo pessimismo.
Dagli inizi del diciannovesimo secolo le librerie dei paesi occidentali hanno ispirato – e involontariamente afflitto – i lettori divulgando le autobiografie di eroi che si sono fatti da sé, manuali di consigli per chi desiderasse imitarli e testi d’ispirazione moraleggiante che narravano di profonde trasformazioni personali e della rapida conquista della ricchezza e della felicità.
L’Autobiografia di Benjamin Franklin (rimasta incompiuta per il sopraggiungere della morte dell’autore nel 1790) è forse la prima opera di questo genere. Vi si raccontano le vicende di un giovane squattrinato che, nato nella famiglia di un umile fabbricante di candele di Boston, padre di altri sedici figli, riesce – unicamente grazie al suo ingegno – ad accumulare una fortuna e a guadagnarsi il rispetto e l’amicizia dei personaggi più famosi del mondo. La storia della vita di Franklin, tutta ispirata all’idea che si debba sempre tendere a migliorarsi, e le massime proposte dal suo autore (come la famosa: «Presto a letto e presto alzato, fan l’uomo sano, ricco e fortunato») diedero vita a un filone letterario che puntava a edificare il lettore occidentale del diciannovesimo secolo. Per esempio: Getting On in the World (1874) di William Mathews, On the Road to Riches (1876) di William Maher, The Secret of Success in Life di Edwin T. Freedley (1881), How to Succeed (1882) di Lyman Abbott, The Law of Success (1885) di William Speer e The Problem of Success for Young Men and How to Solve It (1903) di Samuel Fallows.

Anthony Robbins, Awaken the Giant Within (Come migliorare il proprio stato mentale, fisico e finanziario), 1991
Oggi le cose non sono cambiate. «In questo preciso momento potete prendere una decisione» ci spiega Anthony Robbins (Come migliorare il proprio stato mentale, fisico e finanziario, 1991) «e tornare a scuola, imparare a ballare o a cantare, a gestire le vostre finanze, a pilotare un elicottero [...] Se decidete con convinzione, potrete fare quasi tutto. Perciò, se non vi piace il vostro attuale rapporto di coppia, prendete ora la decisione di cambiarlo. Se non vi piace il vostro lavoro, cambiatelo.»
Per corroborare la sua tesi, Robbins racconta la propria storia personale: nato in una famiglia di umili condizioni, ha un’infanzia infelice. A vent’anni trova un impiego come custode e abita in un appartamentino sporco e angusto; non ha una ragazza, passa le serate a casa, ad ascoltare Neil Diamond, e mette su ben diciassette chili di troppo. Poi, un giorno, decide all’improvviso di rivoluzionare la propria vita e scopre che ad aiutarlo c’è un «potere» nella sua mente:
«Ho usato [questo potere] per recuperare il controllo sul mio benessere fisico e per liberarmi una volta per sempre dei miei diciassette chili di grasso. È così che ho trovato la donna dei miei sogni, l’ho sposata e mi sono creato la famiglia che desideravo. Ho usato questo potere per migliorare i miei guadagni e passare dal livello di sussistenza a una cifra che supera il milione di dollari l’anno, per passare dal mio minuscolo appartamento (in cui lavavo i piatti nella vasca da bagno perché non c’era la cucina) alla casa in cui vivo oggi con la mia famiglia, il Del Mar Castle».
Non c’è ragione di non seguire il suo esempio, soprattut-to – precisa Robbins – se si vive in una società democratica e capitalistica in cui «tutti abbiamo la capacità di realizzare i nostri sogni».
10
La diffusione dei mass media ha contribuito ulteriormente ad aumentare le aspettative. Alfred Harmsworth, fondatore del «Daily Mail», spiegò candidamente, il primo giorno dell’uscita del giornale, nel 1896, che il suo lettore ideale era l’uomo della strada «che guadagnava cento sterline l’anno» ma che era disposto a sognare di diventare «l’uomo da mille sterline l’anno». In America, il «Ladies’ Home Journal» (uscito nel 1883), «Cosmopolitan» (1886), «Munsey’s» (1889) e «Vogue» (1892) fecero conoscere alle classi popolari i particolari della vita dei ricchi. I lettori di «Vogue» di fine secolo, per esempio, sapevano chi si trovava sul Nourmahal, lo yacht di John Jacob Astor, dopo la Coppa America, che cosa indossavano le ragazze più eleganti nei collegi, chi organizzava i migliori ricevimenti a Newport e Southampton e che cosa servire a cena insieme al caviale (patate e panna acida).
La possibilità di conoscere la vita delle classi superiori e di stabilire un contatto con loro venne favorita anche dall’avvento della radio, del cinema e della televisione. Negli anni trenta gli americani passavano complessivamente centocinquanta milioni di ore la settimana al cinema, e quasi un miliardo di ore ad ascoltare la radio. Nel 1946 lo 0,02 per cento delle case statunitensi aveva il televisore, nel 2000 il 98 per cento.
I nuovi media creavano nuovi bisogni anche grazie alla pubblicità che trasmettevano. Quest’ultima, nata in modo dilettantesco negli Stati Uniti verso il 1830, nel 1900 fatturava già cinquecento milioni di dollari l’anno. In quello stesso 1900 un’insegna gigantesca della Coca-Cola fu posta a lato delle cascate del Niagara, e un cartellone che reclamizzava il borotalco Mennen fu collocato proprio sopra lo strapiombo.
11
Quando i fautori della società moderna sono stati chiamati a difenderla agli occhi degli scettici, non hanno incontrato grandi difficoltà: si sono limitati a sottolineare le enormi ricchezze che è in grado di produrre per i suoi membri.
Nella sua Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni (1776) Adam Smith paragona sarcasticamente la strabiliante produttività delle società moderne con le misere risorse di quelle primitive, composte da cacciatori-raccoglitori, che vivevano in una povertà estrema. I raccolti di rado fornivano cibo sufficiente, i beni di prima necessità scarseggiavano e, nei periodi più difficili, i bambini, gli anziani e i più indigenti venivano lasciati «in pasto agli animali selvaggi». Grazie all’innovativa tecnica di produzione che Smith chiama «divisione del lavoro», le società moderne erano invece in grado di sostentare tutti i loro membri. Nessuno, a parte gli sprovveduti e i romantici, avrebbe desiderato di vivere altrove: «Un lavoratore, anche del ceto più basso e più povero, può [in questa società], purché sia oculato e operoso, godere di una fetta di beni e di comodità maggiore di quella che potrebbe assicurarsi chiunque viva in uno stato selvaggio».
12
Eppure, ventun anni prima si era levata la voce di un uomo eccentrico e solitario, ma incredibilmente persuasivo, in difesa di un personaggio inverosimile: il selvaggio. Era possibile, si chiedeva Jean-Jacques Rousseau nel Discorso sull’origine della disuguaglianza fra gli uomini (1754), che i più felici fossero proprio i selvaggi, e non – come tutti erano soliti pensare – i lavoratori dell’età moderna?
Secondo Rousseau, essere ricchi non significa possedere molto, ma ciò che si desidera. La ricchezza, in sostanza, non è assoluta, ma relativa al desiderio. Ogni volta che perseguiamo qualcosa che non possiamo avere ci impoveriamo, al di là dell’entità delle nostre risorse; e ogni volta che ci sentiamo appagati da quanto abbiamo possiamo considerarci ricchi, anche se in realtà possediamo molto poco.
Esistono due modi per rendere più ricco un uomo, sostiene Rousseau: dargli più denaro o limitarne i desideri. La società moderna si è dimostrata particolarmente abile nel primo settore, ma nutrendo incessantemente ogni ambizione finisce per ostacolare la condivisione dei successi più brillanti. Il modo più efficace per sentirci ricchi potrebbe non essere quello di fare soldi, bensì di prendere le distanze, sul piano pratico ed emozionale, da chi abbiamo sempre considerato nostro pari ma ha fatto fortuna più di noi. Invece di tentare di diventare importanti, potremmo circondarci di personaggi meno in vista, accanto ai quali non ci sentiremo a disagio.
Visto che, nel corso del tempo, hanno consentito di ottenere redditi sempre più elevati, le società avanzate sembrano arricchirci ma, in realtà, potrebbero avere l’effetto contrario: alimentando aspettative illimitate, accentuano la distanza tra quello che desideriamo e quello che possiamo permetterci, tra quello che siamo e quello che potremmo essere. Tali società ci lasciano talora più poveri dei selvaggi primitivi che, secondo la tesi rousseauiana – per la verità un po’ improbabile nei termini esasperati in cui è espressa – non desideravano altro quando avevano un tetto sopra la testa, un po’ di mele e di noci da mangiare e potevano trascorrere la serata a suonare «qualche rozzo strumento musicale» o «usare pietre acuminate per costruire una canoa da pesca».
Il confronto proposto da Rousseau tra l’uomo primitivo e quello moderno ci riporta alle riflessioni di William James sulla capacità che hanno le aspettative di influenzare la nostra felicità. Ci possiamo sentire appagati con poco se siamo abituati ad aspettarci poco, e sentirci infelici con molto se tendiamo ad aspettarci molto.
Il selvaggio rousseauiano possedeva poche cose ma, a differenza dei suoi discendenti nei loro «Taj Mahal», era quanto meno in grado di apprezzare l’enorme ricchezza che deriva dall’aspirare a molto poco.
13
Il prezzo che paghiamo per aver aspirato a essere molto di più dei nostri avi è l’ansia continua di non essere affatto ciò che potremmo essere.
