1981-1998. Dal Commodore
64 a Google
L’epoca classica
Quasi vent’anni per mettere a posto il tavolo
da gioco
Premessa inevitabile, ma
molto importante. Se vogliamo riportare la galassia di eventi che
chiamiamo RIVOLUZIONE DIGITALE
a una spina dorsale leggibile, a una catena
montuosa che ci aiuti a capire, dobbiamo forzatamente sintetizzare
e rinunciare ad alcune sfumature. Ci serve registrare dei picchi,
anche sacrificando il dettaglio di processi che magari sono durati
decenni. In queste pagine si è scelto per lo piú di rilevare gli
eventi solo quando in effetti sono saliti sulla superficie del
consumo collettivo, diventando scenari abitati da molti e non solo
da élite particolari. Lo so, è un metodo arbitrario. Ma alla fine
abbiamo troppo bisogno di una sintesi leggibile per attardarci
troppo nel culto della precisione. Quel che suggerisco è che vi
godiate la possibilità di vedere tutto dall’alto, come in una
fotografia aerea, e che per qualche capitolo accettiate
l’inevitabile inesattezza di uno sguardo sintetico. Ogni volta che
potremo, planeremo giú a guardare da vicino. Promesso.
Allora. Lasciamoci Space
Invaders alle spalle e guardiamo venire su le prime montagne
vere e proprie. Sono gli inizi degli anni ’80.
1981-1984
- Nel giro di quattro anni escono tre Personal Computer che riassumono lunghissime sperimentazioni e che riescono a sfondare sul mercato, convertendo uno strumento d’élite in un oggetto che potevi immaginare di avere a casa anche se non eri un genio o un professore alla Stanford University: il pc Ibm, il Commodore 64, e il Mac della Apple. A vederli adesso sono di una mestizia desolante, ma ai tempi dovevano sembrare perfino graziosi, e comunque passabilmente amichevoli. Dei tre, quello che ebbe meno successo commerciale fu il Mac: era però il piú geniale. Fu il primo a usare un’impostazione grafica e un’organizzazione del materiale capaci di risultare comprensibili anche a un idiota: c’era la scrivania, si aprivano delle finestre, si buttavano le cose in un cestino: gesti che la gente conosceva. Ci si muoveva sullo schermo spostando sul tavolo una strana cosa che si chiamava Topo. Si può capire che, da quel giorno, l’equazione tra intelligenza e noia iniziò a perdere colpi.
ZOOM Non si capisce l’importanza di tutto ciò se non ci si
concentra un attimo sulla P
dell’espressione PC.
Personal.
Al giorno d’oggi il fatto che ognuno abbia un
computer sembra scontato, ma non dovete dimenticare invece che la
cosa, solo quarant’anni fa, sarebbe suonata come una follia. I
computer c’erano da anni, ma erano mostri enormi e covavano dati
nei laboratori di poche istituzioni destinate per lo piú a una
qualche forma di dominio o supremazia. Pensare che finissero sulla
vostra scrivania aveva ai tempi qualcosa di realmente visionario.
Arrivo a dire che forse il vero atto geniale non fu tanto inventare
i computer, quanto immaginare che potessero diventare uno strumento
personale, individuale. Covava, in quell’idea, la singolare volontà
di concedere a qualsiasi individuo un potere che era stato creato
per essere di pochi. Incredibile. Per questo, quando uno guarda una
foto di un Commodore 64, oltre a chiedersi se proprio dovevano
adottare quel colore da malati, deve capire che lí stava
VERAMENTE girando il mondo: non un
minuto prima.
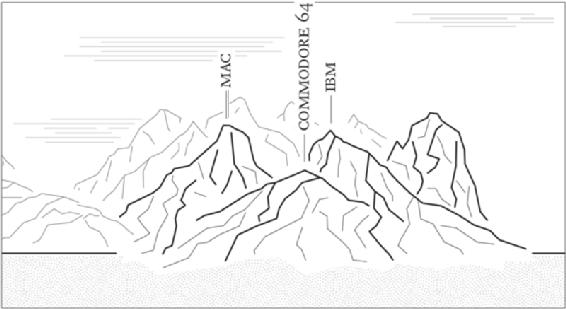
- Nel 1981 viene pubblicato SMTP, il primo protocollo di mail che, facilitando le cose, avrebbe permesso un vertiginoso diffondersi della posta elettronica [trent’anni dopo, nel 2012, noi umani avremmo mandato 144 miliardi di mail al giorno: tre su quattro sarebbero state spam]. La prima mail, per la cronaca, era partita molti anni prima: l’aveva mandata, nel 1971, Ray Tomlinson, un americano di trent’anni che aveva studiato ingegneria a New York. L’adozione della chioccioletta, per dire, è un’idea sua, ho scoperto.
IMPORTANTE
Le mail correvano da un computer all’altro
usando, per cosí dire, una rete stradale invisibile, di cui la
gente normale, ai tempi, ignorava completamente l’esistenza: quelli
che ne sapevano qualcosa la chiamavano Internet. La dovete
immaginare come una sorta di Santa Barbara sotterranea: se
resistete ancora poche righe vedrete l’immensa esplosione che, da
lí a qualche anno, avrebbe spaccato la crosta terrestre e sparato
in aria una delle piú fantastiche vette che mai la rivoluzione
digitale abbia visto nascere.
1982
- Sale in superficie, e non si può piú nascondere, l’onda di digitalizzazione che sommergerà il mondo: viene commercializzato il primo CD di musica, cioè una registrazione tradotta in formato digitale e fissata in un supporto grande come un padellino. Per lanciarla sul mercato si misero insieme Philips e Sony: quindi Olanda e Giappone. Il primo CD commercializzato conteneva, inspiegabilmente, una musica di rara bruttezza: La Sinfonia delle Alpi di Richard Strauss. [D’altronde il primo CD di musica pop lo fecero gli ABBA].
1988
- Altra tappa importante nella progressiva digitalizzazione del mondo: dopo la musica, le immagini. Nasce la prima fotocamera interamente digitale. La fa la Fuji, ovviamente giapponese.

Dicembre 1990
- Un ingegnere informatico inglese, Tim Berners-Lee, inaugura il World Wide Web, e cambia il mondo.
È, ovviamente, un
momento storico. Una buona metà del mondo in cui viviamo nasce in
questo istante, ed è una cosa che continuerei a dire anche se
dopodomani il Web fosse spazzato via e sostituito da qualcosa di
meglio [cosa che sta succedendo, peraltro]. Nell’invenzione del Web
c’è un movimento mentale che in poco tempo diventerà una mossa
abituale del cervello di miliardi di umani: insieme a un paio di
altre mosse stupefacenti, è ciò che fonda la nostra nuova civiltà.
Dunque, concentrazione. Si impone una solenne parentesi: è la volta
buona per capire bene le cose. O almeno: per me lo è
stata.
Credo che sia utile partire da una notizia che
non vi piacerà: Internet e Web sono due cose diverse. Lo so, è
seccante, ma fatevene una ragione. Internet è nato prima del Web,
molto prima. Ora provo a spiegare com’è andata.
Tutto è cominciato negli
anni della Guerra Fredda da una paranoia dei militari americani:
come fare a comunicare tra di loro senza che i sovietici potessero
ficcare il naso. Ci lavorarono su e misero in piedi, negli anni
’60, una soluzione piuttosto geniale che chiamarono
ARPANET: in
pratica riuscirono a mettere in comunicazione alcuni loro computer
che fisicamente erano molto lontani uno dall’altro, facendoli
dialogare con un sistema di impacchettamento dei dati fino ad
allora inesistente e creando cosí una specie di circuito blindato
in cui quei computer si potevano scambiare informazioni senza che i
comunisti potessero sperare di infilarsi a leggere. Il tutto
accadeva, va aggiunto, in una quantità di tempo ridicola.
Schiacciavi un tasto e il tuo messaggio arrivava all’istante
dall’altra parte. Be’, se non proprio all’istante, comunque con una
velocità stupefacente.
Ora, se solo non eri
ipnotizzato dall’ossessione dei comunisti, ti potevi accorgere
immediatamente che una soluzione del genere apriva orizzonti
incredibili, ben al di là del contesto militare. Alcune università
americane che avevano collaborato allo sviluppo di
ARPANET se ne
accorsero, affinarono quella tecnologia e la adottarono per mettere
in comunicazione i computer dei loro ricercatori. Il 29 ottobre
1969 da un computer dell’UCLA
(Los Angeles) partí un messaggio che in tempo
reale raggiunse l’Università di Stanford (San Francisco), bevendosi
550 chilometri in un amen. Il messaggio arrivò solo a metà,
d’accordo, ma corressero subito le cose e al secondo tentativo
tutto andò bene. Tanto che misero su un loro circuito e iniziarono
a usarlo per far comunicare tutti i loro computer. Si mandavano,
per dire, lettere (ora le chiamiamo e-mail). Ma anche intere
ricerche. O libri. O barzellette, immagino, non so. Comunque: una
cosa mica male.
Quel che successe fu che
molte altre università, alcune grandi aziende e perfino degli Stati
nazionali capirono l’utilità fantastica della cosa e si allestirono
ognuno un proprio circuito che metteva in comunicazione tutti i
loro computer. Chiamiamolo col suo vero nome: si allestirono un
loro network. Ognuno aveva il suo, e ciascun network aveva il suo
funzionamento, le sue regole, i suoi meccanismi. Erano vasi non
comunicanti. Come lingue diverse, ecco. Non sarebbe successo nulla,
e voi sareste ancora a leccare francobolli, se nel 1974 due
ingegneri informatici americani non avessero inventato un
protocollo che era in grado di far dialogare i formati di tutti i
vari network del mondo, mettendoli magicamente in comunicazione.
Praticamente un traduttore istantaneo planetario: ognuno parlava
nella lingua che gli pareva e quel protocollo traduceva
all’istante. Non gli diedero un bel nome [ingegneri…], ma vale la
pena lo stesso di impararlo: TCP/IP. È stata l’invenzione che
ha sciolto le barriere tra i vari network esistenti, ottenendo il
formidabile risultato di mettere sul tavolo, di fatto, un unico
grande network mondiale: qualcuno lo chiamò Internet.
Erano gli anni ’70 e –
molto importante – tutto questo riguardava una quantità piuttosto
ridicola di persone. Un’élite piccolissima, se pensiamo ai numeri
del pianeta. La stessa élite, ovviamente, che aveva accesso ai
computer. Era un gioco di nicchia. Il curling ha oggi,
probabilmente, piú praticanti. Per questo nulla di ciò compare
nella nostra spina dorsale della rivoluzione digitale, come ho
detto consacrata a registrare i passaggi in cui il terremoto è
salito in superficie modificando effettivamente la vita delle
persone. In questa storia, quel momento inizia ad arrivare solo nel
1990. Tim Berners-Lee, un inglese che lavorava al
CERN di Ginevra,
inventa una cosa che chiama Web. [Per la prima volta
vediamo apparire la vecchia Europa in questa storia, dove tutti gli
eroi – tutti – sono americani, e spesso californiani. Mi tocca
aggiungere, per completare l’informazione, che Berners-Lee il Web
lo inventò lavorando su un computer americano: si chiamava
NeXT e lo produceva una azienda californiana di cui è
interessante annotare il nome del fondatore: Steve
Jobs].
Cosa inventò,
esattamente, Berners-Lee? Non Internet, e questo adesso lo abbiamo
capito bene. E allora cosa? Ho imparato che le risposte possibili a
questa bellissima domanda sono molte, tutte fatalmente imprecise o
incomplete. Ne aggiungo una, la mia.
Qualsiasi cosa sia il Web, Berners-Lee lo
inventò facendo tre mosse precise.
La prima nasce da una
domanda: se con Internet posso mettere in comunicazione tutti i
computer del mondo, perché accontentarmi di cosí poco? Mi spiego.
Immaginate il computer sulla scrivania del professor Berners-Lee e
poi immaginatevi lo studio dove è messa quella scrivania. Bene.
Adesso guardatevi intorno, vedrete certamente dei mobili, apriteli
e concentratevi sui cassetti, molti cassetti, forse un centinaio di
cassetti, tutti pieni di roba, progetti, idee, appunti, foto delle
vacanze, lettere d’amore, ricette mediche, CD dei Beatles, annate di
fumetti Marvel, tessere del cineforum, vecchi estratti conto. E ora
chiedetevi: perché non entrare direttamente in quei cassetti?
Possibile che io possa solcare migliaia di chilometri (migliaia!) e
poi, arrivato a due metri da quel cassetto (due metri!), non ci
possa entrare perché mi fermo nel computer del professore? È
stupido. Allora ne parlo col professor Berners-Lee. Lui sta ad
ascoltare e poi, dato che ci sa fare, inventa un sistema per cui,
modificando la struttura dei cassetti, mi permette di fare quei due
metri e di andare a guardarci dentro. Non è naturalmente costretto
ad aprirmeli tutti, sceglie lui quali rendermi disponibili, ma
quando li sceglie allora si applica a dar loro una struttura tale
che io possa raggiungerli, e vederli, e girarci dentro, e perfino
portarmi via quello che mi interessa. Come fa? Duplica il contenuto
di quei cassetti in tante rappresentazioni digitali che colloca in
un posto che chiama, con sublime semplicità, posto: o per meglio
dire sito. Un sito Web. Lo immagina come un albero che si allarga
coi suoi rami nello spazio: ogni foglia è una pagina, una pagina
Web. Di cosa è fatto quell’albero? Rappresentazioni digitali, cioè
testi, immagini, suoni che, formattati in linguaggio digitale,
vengono stoccati nel computer. Una volta lí, davanti a loro si apre
l’immane rete «stradale» di Internet. È usando quella rete che i
cassetti del professor Berners-Lee, duplicati in rappresentazioni
digitali, si mettono in movimento: e raggiungono me. Il mio
computer. Dove, alla fine del processo, trovo quello che volevo: la
collezione dei fumetti Marvel del professor Berners-Lee [le ricette
mediche mi interessavano di meno].
Notevole, bisogna
ammetterlo.
Ma in fondo piuttosto
prevedibile, se non fosse che il professor Berners-Lee piazza
subito dopo una seconda mossa, questa veramente emozionante: per
rendere le cose piú semplici e spettacolari METTE IN COMUNICAZIONE TUTTI I CASSETTI TRA DI
LORO. Voglio dire che quando io entro
in uno, posso, senza nemmeno richiuderlo, entrare in un altro,
senza passare dal via. Faccio questo grazie a delle porticine che
il professor Berners-Lee mette a punto e chiama link. Sono parole speciali,
piú che parole, iperparole, in genere
compaiono in blu. Clicco sopra e finisco in un altro cassetto.
Capite che la cosa inizia a farsi divertente. Se solo un’ora prima
spedire un’e-mail mi poteva sembrare una cosa straordinaria, adesso
che sfarfallo per tutti i cassetti del professore, limitarmi a
spedire quella letterina mi sembra una afflizione inspiegabile, un
giochetto da bambini. Molto meglio mettermi a viaggiare da un
cassetto all’altro, da un sito Web all’altro. Soprattutto da quando
il professor Berners-Lee ha deciso di rendere la cosa
definitivamente divertente facendo la terza mossa.
Invece che tenerselo per
sé o provare a venderlo, il professore (col permesso del suo datore
di lavoro, il CERN di Ginevra) rende pubblico il sistema da lui inventato
per aprire i suoi cassetti e dice una cosa molto semplice: se lo
facciamo tutti, e attraverso i link colleghiamo tutti i nostri
cassetti, ci troveremo davanti a una formidabile ragnatela di
cassetti in cui chiunque potrà liberamente viaggiare a suo piacere,
guardando e prendendo quel che gli serve: otterremo un
World Wide Web,
una ragnatela grande come il mondo, percorribile da tutti, in cui
tutti i documenti del mondo, che siano testi, foto, suoni, video,
saranno a portata di mano. Poi aggiunge una cosa irresistibile: ah,
dimenticavo, sarà tutto gratis.
Wow.
Chi non vorrebbe una
cosa del genere?
Nessuno, e infatti
eccoci qua.
Nel 1991 c’era al mondo
un solo sito Web: quello di Berners-Lee.
L’anno dopo, gente di
buona volontà ne aprí altri nove.
Nel ’93 erano
130.
Nel ’94, 2 mila
738.
Nel ’95, 23 mila
500.
Nel ’96, 257 mila
601.
Oggi, mentre scrivo
questa riga, sono 1 miliardo 284 mila 792.
Come capite, le
conseguenze di una simile slavina sono state immani. A noi
interessano soprattutto quelle di tipo mentale. Le troverete
nei Commentari che seguono a questo capitolo. Per adesso mettiamo da
parte questa costola gigantesca, questa montagna che è sgorgata
dalla terra, spaccando la crosta delle abitudini di un mondo, e
alzandosi a ritmi vertiginosi, ogni anno, nel paesaggio degli
umani. È ancora lí che sale [nel tempo in cui ho scritto queste
righe sono nati 13 mila siti Web, per capirci]. [D’accordo, son
andato un attimo in bagno, ma proprio solo un attimo]. [E in ogni
caso, nel tempo di scrivere queste due parentesi ne sono nati altri
mille, cosí, per la cronaca]. [Come lo so? www.internetlivestats.com].
Dicevo. Delle
conseguenze mentali avremo modo di occuparci fra un po’. Per adesso
è già un bel risultato archiviare questa costola con la vaga
impressione di aver capito cos’è. Ce l’avete? Speriamo. E torniamo
alla spina dorsale. Eravamo arrivati al 1990.
1990
- Tim Berners-Lee inaugura il World Wide Web e cambia il mondo.

1991-1992
- Niente di davvero notevole, che io sappia. Forse si dovevano rimettere dallo shock.
1993
01
- Un gruppo di ricercatori europei inventa l’MP3. È un sistema per rendere i file audio ancora piú leggeri di prima e quindi il loro peso digitale minimo. Nasce un concetto, quello di COMPRESSIONE, che piú tardi verrà applicato alle immagini fisse (generando il jpeg) e a quelle in movimento (mpeg). L’idea è che se trovi un sistema per togliere dalla versione digitale di un suono tutte quelle sequenze numeriche che non sono strettamente necessarie (ad esempio quelle che registrano sfumature sostanzialmente inudibili dall’orecchio umano) quel che ti ritrovi in mano è un suono un po’ impoverito ma molto piú leggero, quindi ancora piú facile da trasportare, da spedire, da stoccare. Col cavolo che potreste sentire musica dal vostro cellulare senza un trucco del genere. [Inutile dire che, all’istante, il CD iniziò a sembrare il rimasuglio di una commovente civiltà passata].
- Apre Mosaic, il piú usato tra i primi browser che ti facevano navigare nel Web. Decisivo. In pratica, Berners-Lee aveva inventato un tipo di mondo digitale parallelo (il Web) ma non ci aveva messo un servizio uno, per cui per girarlo bisognava essere degli esploratori alla Indiana Jones, e comunque dei maghi dell’informatica. Il browser è l’insieme dei servizi che possono portare un fesso come me a viaggiare là dentro senza la minima fatica. Lo installo sul mio computer e lui mi mette in grado di viaggiare nel Web senza neanche sapere cos’è. [Mi son fatto l’idea che le navi da crociera siano una cosa del genere, ma applicate al Mar Mediterraneo]. Mosaic fu il primo browser di un certo successo, lo misero su due studenti dell’Università di Urbana-Champaign, Illinois. Ora non esiste piú. Ma i browser sono ancora lí, fondamentali. Hanno nomi come Safari, Google Chrome, Internet Explorer. Senza di loro il Web continuerebbe a essere una fighetteria per pochi ingegneri con del tempo da perdere.
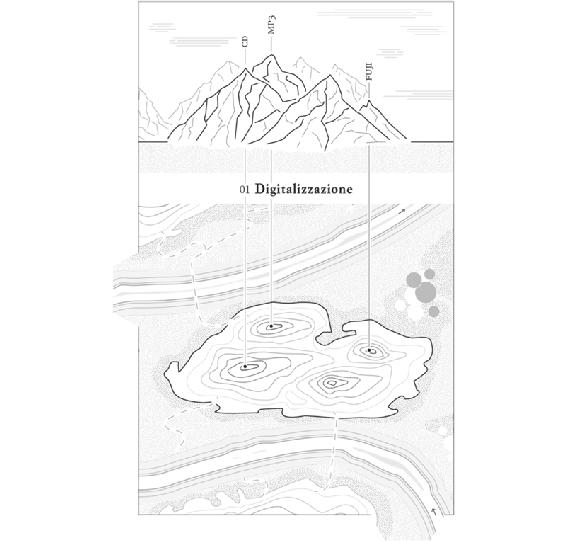
1994
- Nasce a Seattle Cadabra, che non vi dirà nulla, ma dovrebbe farlo perché è il primo nome di Amazon. L’idea era quella di mettere su una libreria on line dove si potessero comprare tutti i libri del mondo. In pratica, senza muovere il culo dalla tua scrivania, accendevi il computer, sceglievi un libro, lo pagavi, e quelli te lo portavano a casa. Era un’idea folle, ma l’uomo che la ebbe riponeva evidentemente grande fiducia in un numero che è qui utile annotare, cioè l’indice di crescita annua che il numero di utenti del Web aveva fatto registrare l’anno prima: + 2300%. Oltre a cambiare il nome del sito (un anno dopo), il fondatore Jeff Bezos capí abbastanza presto che limitarsi a vendere libri era scemo. Adesso su Amazon potete anche comprare un’automobile. O il phon.
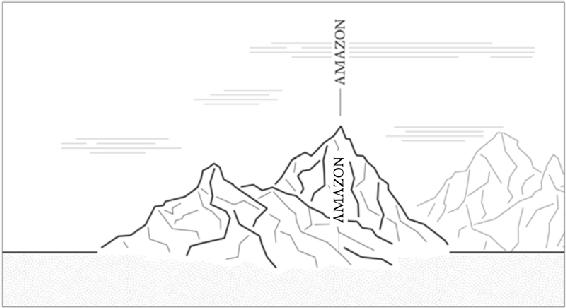
Altra parentesi,
necessaria per ricordarsi bene come andavano le cose, ai tempi.
Documenta la Storia che Jeff Bezos, dovendo trovare fondi con cui
finanziare i primi anni di Amazon, si sia recato, tra le altre
cose, dal padre. Voleva convincerlo ad affidargli i suoi risparmi:
pare che ammontassero a 300 mila dollari. Dovette spiegargli tutto
per bene, certo in modo convincente. Il padre lo stette ad
ascoltare e poi fece la seguente domanda: «Che cos’è
Internet?»
La domanda adesso vi
sembrerà comica, ma invece ci aiuta a concentrarci su che anni
erano, che poi è il senso di questa pausa: ricordarci che anni
erano.
Nel mio piccolo, ad
esempio, io piú o meno in quegli stessi anni stavo a Santa Monica,
California, a spendere i primi soldi che avevo guadagnato
concedendomi il lusso di scrivere in una stanza d’albergo un testo
teatrale che poi sarebbe risultato, con mia grande sorpresa, un
vero e proprio cesso. Ogni tanto, per sgranchirmi le gambe, giravo
per la Promenade e lí un giorno feci il bel gesto di entrare in una
libreria. Stavo probabilmente guardando le copertine dei libri
registrando l’indiscutibile supremazia dei grafici americani quando
mi imbattei – e questo lo ricordo distintamente – in un tipo
di libro di cui non capivo il senso e ignoravo l’uso possibile ma
che mi ricordò una certa cosa che un certo amico mi aveva
raccontato. A mettermi sull’avviso fu il fatto che il libro
sembrava essere un catalogo di posti, o nomi, o titoli (non capivo
bene), ma tutti con dei punti in mezzo, delle barre //, delle
sigle, forse tipo CH, EU, difficile ricordare
esattamente. Insomma, si assomigliavano tra loro e non
assomigliavano a nulla che io conoscessi. Il mio amico doveva
avermi fatto vedere qualcosa del genere. Adesso so cos’erano:
indirizzi di siti Web. Adesso so che quello era un libro
commovente, cioè una specie di elenco telefonico del Web, le Pagine
Gialle della Rete: il fatto che lo vendessero in una libreria
estremamente cool di Santa Monica la dice lunga sullo stato
neonatale della rivoluzione digitale: non sapevano neanche bene
dove stessero andando se facevano libri di carta con scritti in
ordine alfabetico tutti i siti Web, oltretutto divisi in modo
struggente per argomento: quelli di sport, quelli di gastronomia,
quelli medici. Ditemi se non è commovente. Come per il motore a
scoppio di cui si calcolava la potenza contando quanti cavalli
avrebbero spostato lo stesso peso. Sono quei momenti aurorali in
cui il genio dell’uomo convive con una forma irrimediabile di
esitazione imbecille. Momenti in cui anche se sei il padre di Jeff
Bezos puoi fare la domanda «Cos’è Internet?» senza passare per
scemo. Quanto a me, comprai il libro pensando di regalarlo al mio
amico, ma nello stesso modo in cui avrei potuto regalare una
grammatica giapponese a un amico eccentrico che stava studiando una
lingua per me inutile. Di fatto non sapevo cos’era un sito Web, e
non lo sapevo nel modo piú radicale e definitivo e vergognoso, cioè
non avevo la minima idea di che razza di oggetto, o forma, o
identità fosse. Il Web non esisteva nell’indice di ciò che
conoscevo, ma questo era il meno: non esisteva la
logica del Web,
la sua forma, la sua ARCHITETTURA
MENTALE: non solo ignoravo che
esistesse, ma non disponevo delle categorie che lo avevano
generato.
Ero laureato, mi preme
sottolineare. Filosofia. Voglio dire: non era probabilmente un mio
problema personale, eravamo tutti ignoranti, non solo io e il
signor Bezos.
Quindi adesso che con lo
sguardo ripercorriamo la spina dorsale della rivoluzione digitale,
vediamo di sentire sotto le dita le vertebre, una ad una, per
quello che veramente erano ai tempi: cartilagini ancora morbide,
provvisorie, cangianti. Erano davvero organismi nuovi, nella
concezione e nella struttura: materiali alieni.
Il mio amico adesso
scrive libri, bellissimi tra l’altro. Il padre di Bezos no, ma i
300 mila dollari li diede, al figlio. Tendo a immaginare che gli
abbiano fruttato una certa cifretta.
Bene. Torniamo alla spina dorsale. Eravamo
arrivati al 1994. Apre Amazon, ma non è la sola cosa che
accade.
1994
- L’IBM tira fuori il primo smartphone. Di cellulari ne esistevano già da tempo, ma questo è il primo telefono capace di fare cose che un telefono non dovrebbe fare. Manda mail e ha installato un videogioco, per dire. Sei mesi di vita e smisero di produrlo. Partenza falsa. Per vedere comparire uno smartphone sulla superficie dei consumi di massa bisognerà aspettare almeno altri nove anni. Non so, di preciso, perché.
- Nasce la Play Station. La fanno i giapponesi della Sony. Il rapporto coi figli non sarebbe piú stato lo stesso. E anche il rapporto con la realtà, come vedremo.
- Nasce Yahoo!, e inizia la moda dei nomi scemi. Comunque, un momento storico. Il portale, inventato da due studenti della Stanford University (California, USA), fa la cosa piú ovvia, cioè elimina la penosa necessità delle Pagine Gialle cartacee che avevo regalato al mio amico: finalmente c’è qualcuno che ti aiuta a orientarti in Internet e nel Web, e lo fa con un sito Web. Non ci voleva poi molto, apparentemente.
1995
- Dopo le foto, i film. A essere digitalizzati, questa volta, sono gli audiovisivi. Viene messo in vendita il primo DVD. Ancora la Philips, ancora con i giapponesi (Sony, Toshiba, Panasonic). Due anni e il VHS era morto. Amen.
- Bill Gates lancia Windows 95, il sistema operativo che fa di tutti i personal computer degli attrezzi amichevoli come gli Apple, ma molto meno cari. Non ci sono piú alibi per rinviare l’ingresso in casa di un computer. Se non ce l’hai, allora proprio non vuoi capire…
- Nasce eBay, e lo fa, anche lui, in California. Mercato aperto a tutti, dove poter vendere e comprare qualsiasi cosa. La prima fu un puntatore laser rotto.
1998
02
- Gran Finale. Due studenti ventiquattrenni della Stanford University (Sergej Brin e Larry Page) lanciano un motore di ricerca che chiamano con un nome imbecille: Google. Oggi è il sito Web piú visitato al mondo. Quando lo immaginarono c’erano poco piú di seicentomila siti Web: loro trovarono il modo di farti trovare, in meno di un secondo, tutti quelli che contenevano una ricetta delle lasagne, e di snocciolarteli in ordine di importanza. (Le lasagne sono solo un esempio: funzionava anche se cercavi protesi all’anca). La cosa stupefacente è che continuano a essere in grado di farlo adesso che i siti sono piú di un miliardo e duecento milioni. Volendo usare una metafora cinquecentesca, se i browser ti procuravano i velieri per viaggiare nel grande mare del Web, se i portali come Yahoo! ti suggerivano rotte e pericoli, quei due trovarono in un colpo il sistema per calcolare longitudine e latitudine, e misero al servizio di qualsiasi navigatore un mappamondo in cui c’erano tutti i porti del pianeta, ordinati per importanza, confortevolezza e vocazione commerciale. Erano in grado di dirti quelli in cui si mangiava meglio, quelli in cui il prezzo del pepe era il piú basso, e quelli in cui i bordelli erano i migliori. Non vi stupirà sapere che attualmente il loro brand, Google, è il piú influente al mondo [qualsiasi cosa voglia dire].


03
Anche qui, al di là
delle immani conseguenze economiche, assistiamo all’introduzione di
alcuni movimenti mentali che risulteranno decisivi nel profilare la
nuova civiltà che stava nascendo. Variazioni a qualsiasi logica
conosciuta, e posture mentali che non si erano mai viste: il nuovo
assoluto. Sarà interessante parlarne nei soliti Commentari di cui ho già
accennato. Per adesso fermiamoci qui e guardiamo cosa abbiamo sotto
agli occhi.
Screenshot
finale
La vedete la spina dorsale, la catena
montuosa? È l’epoca classica della rivoluzione digitale.
Space Invaders era giusto una prima
collinetta, piú che altro simbolica, queste sono montagne vere e
proprie. Piuttosto spettacolari, va detto. Vogliamo provare a
capirle in modo sintetico, cosí semplice che la capirebbe anche un
bambino [si fa per dire]? Vogliamo. E allora:
La rivoluzione digitale
nasce da tre gesti lunghi che tracciano un nuovo campo da
gioco.
|
A.
|
Digitalizzare testi, suoni e immagini: ridurre allo stato liquido il tessuto del mondo. |
È un gesto che va dal CD al DVD, passando
per l’MP3: dall’82 al ’95. Piú o meno
lo stesso arco del PC.
|
B.
|
Realizzare il Personal Computer. |
È un gesto che viene da lontano e diventa
davvero visibile a metà degli anni ’80 – con i tre PC citati – e irreversibile a metà degli anni ’90
– con l’avvento di Windows 95.
|
C.
|
Mettere in contatto tutti i computer, metterli in rete. |
È un gesto che inizia con ARPANET nel 1969 e, passando attraverso
l’invenzione del Web, arriva al traguardo nel 1998 con l’invenzione
di Google.
Sintetizziamo ulteriormente: quel che abbiamo
fatto, nell’epoca classica, è stato ridurre allo stato liquido i
dati che contenevano il mondo (A),
costruire una tubatura sconfinata in cui quel liquido potesse
scorrere a velocità vertiginosa e sgorgare in tutte le case degli
umani (C) e inventare rubinetti e
lavabi molto raffinati che potessero fare da terminali di
quell’immenso acquedotto (B). Nel 1998
il lavoro era finito. Migliorabile, ma finito. Quel che possiamo
dire senza paura di sbagliare è che un umano occidentale, seduto
davanti al suo PC, in un qualsiasi
giorno del ’98, era seduto davanti a un rubinetto abbastanza facile
da usare grazie al quale accedeva a un’immane acquedotto: è
importante notare che non solo poteva attingere acqua quando
voleva, ma poteva a sua volta infilare acqua per metterla in
circolo. O gazzosa, naturalmente. Whiskey, volendo. Abbastanza
incredibile. Come situazione era completamente nuova, e adesso è
particolarmente importante – oltreché divertente – vedere quali
esattamente furono i primi gesti che quell’umano fece quando si
trovò in quella situazione e mise le mani su quel rubinetto.
Sostanzialmente usò
l’enorme acquedotto per far circolare tre cose: delle informazioni
personali (mail, ricerche), delle merci (Amazon, eBay, videogiochi)
e le mappe dell’acquedotto (Yahoo!, Google). Naturalmente, se
tornassimo a quegli anni, in dettaglio, troveremmo una quantità
quasi infinita di utilizzi di Internet: ma se adesso dobbiamo
fissare la spina dorsale, e registrare solo le formazioni
geologiche che nacquero allora e che poi sarebbero effettivamente
diventate montagne, quello che vediamo è semplice: mappe, merci,
documenti.
Non si sarebbe potuto
dire molto di diverso dei primi navigatori che aprirono le grandi
rotte intercontinentali nel ’500. Strategia molto tradizionale,
quindi. Un’apertura classica, si direbbe nel gioco degli scacchi.
Anche nella sua mossa piú nascosta, e alla fine piú importante.
C’era un’altra cosa che i mercanti navigatori del ’500 portavano in
giro per il mondo:
dio. Missionari. Una certa
way of life. Un
certo modo di stare al mondo. Lo stesso fa la rivoluzione digitale:
inizia a sedimentare un certo modo di stare al mondo. Delle figure
mentali. Dei movimenti logici che non si conoscevano. Una
differente idea di ordine, e di presa sul reale. Non proprio una
religione, ma qualcosa che gli va vicino: UNA CIVILTÀ.
La possiamo riconoscere
se da vicino proviamo a osservare quelle prime mosse – reperti
archeologici – e a studiarle: in quei gesti c’è qualcosa che
ritorna costantemente, quasi dei tratti somatici comuni, alle volte
dei tic che si ripetono uguali. Gli indizi di una qualche
mutazione. Le orme di umani fatti in modo strano, mai
visto.
Se volete saperne di
piú, attardatevi leggendo i Commentari che seguono: è
roba affascinante. Rompe un po’ il ritmo della nostra ricostruzione
della spina dorsale digitale, ma anche aiuta a capirla
veramente.
D’altra parte, adesso
che ci penso, anche sbattere il libro nella stufa è comunque
un’opzione possibile. Lo capisco e passo, incurante, ai
Commentari. Ne
adoro il nome un po’ vintage.
