4.
L’interazione fra capitalismo e globalizzazione
Agli inizi della storia ciascuna invenzione
doveva essere rifatta
ogni giorno e in ogni località indipendentemente. [...] Solo
quando
le relazioni si sono estese su scala mondiale ed hanno per base
la grande industria, quando tutte le nazioni
sono trascinate nella lotta della concorrenza,
la durata delle forze produttive acquisite è assicurata.
Karl Marx, L’ideologia tedesca
In questo capitolo esamino il ruolo del capitale e del lavoro nella globalizzazione. La caratteristica principale che la globalizzazione conferisce a entrambi è la mobilità. La globalizzazione ha significato perlopiù movimenti transfrontalieri di capitali, ma di recente anche il lavoro è diventato più mobile, e una delle reazioni a questa crescente mobilità è stata la creazione di nuovi ostacoli alle frontiere nazionali. La mobilità dei lavoratori è una risposta alle enormi differenze di retribuzione a parità di qualità e quantità di lavoro tra le giurisdizioni nazionali. Tali divari si concretizzano in quelli che io definisco citizenship premium («premio di cittadinanza») e citizenship penalty («penalità di cittadinanza»). Il premio di cittadinanza (o rendita di cittadinanza; i termini sono usati in modo intercambiabile), come spiego di seguito, si riferisce al maggiore reddito che si percepisce per il semplice fatto di essere cittadini di un paese ricco, mentre la penalità di cittadinanza è il minore reddito derivante dall’essere cittadini di un paese povero. Il valore di questo premio (o penalità) può essere fino a cinque a uno o dieci a uno, anche dopo aver preso in considerazione i livelli di prezzo più bassi nei paesi più poveri. Questi divari di reddito sono in gran parte un’eredità dell’Otto e del Novecento, epoca in cui i paesi occidentali e alcuni altri (Giappone e, più recentemente, Corea del Sud) hanno superato il resto del mondo in termini di reddito pro capite. Sarebbe sorprendente se tali divari non creassero movimenti di lavoratori. Sarebbe strano come se una differenza tra un’attività che rende il 3 per cento e un’altra, altrettanto rischiosa, che rende il 30 per cento, non portasse i proprietari del capitale a investire in quest’ultima. La mobilità del lavoro deve quindi essere vista allo stesso modo della mobilità del capitale, e cioè come parte integrante della globalizzazione.
Inizio questo capitolo analizzando il lavoro in condizioni di globalizzazione. Passo poi al capitale, la cui mobilità, che si riflette forse meglio attraverso le cosiddette catene globali del valore, accelera la crescita dei paesi più poveri e, nel medio-lungo periodo, erode le rendite di cittadinanza che motivano le migrazioni. Pertanto, entrambi i movimenti transfrontalieri – del lavoro e del capitale – sono movimenti equilibratori il cui risultato finale, che probabilmente non si raggiungerà mai, sarebbe un mondo di minime differenze nel reddito medio pro capite fra le nazioni.
Perché scelgo le catene globali del valore come caratteristiche della globalizzazione? Lo faccio per il loro duplice impatto rivoluzionario. Innanzitutto, come spiego di seguito, rendono possibile, per la prima volta nella storia, la separazione della produzione dalla gestione e dal controllo di quella produzione, con enormi implicazioni per la distribuzione spaziale dell’attività economica. In secondo luogo, capovolgono l’opinione degli strutturalisti e dei neomarxisti secondo cui la via allo sviluppo era quella di staccarsi dal Nord globale. Per chiarire, non sono contrario all’idea che gran parte della crescita economica cinese possa essere spiegata in modo più tradizionale, ossia con la scelta dello stesso percorso di uno sviluppo orientato all’esportazione con gradi crescenti di sofisticazione intrapreso decenni fa dal Giappone e poi dalla Corea del Sud e da Taiwan. Mi concentro sulle catene globali del valore per le ragioni appena menzionate, e non come spiegazione della totalità della trasformazione della Cina.
Esaminerò poi in che modo lo stato sociale viene influenzato dalla globalizzazione, in particolare dai movimenti del capitale e del lavoro. E alla fine poso lo sguardo sulla corruzione nel mondo. A prima vista, potrebbe sembrare strano mettere la corruzione allo stesso livello del movimento dei due fattori di produzione e del destino dello stato sociale. Sarebbe strano, tuttavia, solo se considerassimo la corruzione come un’anomalia. Ma questo punto di vista è sbagliato. La corruzione è legata alla globalizzazione non meno della libera circolazione del capitale e del lavoro. È stimolata dall’ideologia del fare soldi, che è poi l’ideologia alla base della globalizzazione capitalistica, ed è resa possibile dalla mobilità del capitale, ma a questo si aggiunge il fatto che sia il capitalismo politico sia la tendenza al dominio plutocratico nel capitalismo liberale la «normalizzano». Nel capitolo 3 ho argomentato che la corruzione è una parte intrinseca del capitalismo politico. È giunto il momento di normalizzarla: dobbiamo vederla, nei due tipi di capitalismo, come l’utile (una sorta di rendita) derivante da un particolare fattore di produzione – il potere politico – che alcuni individui possiedono e altri no. La corruzione è destinata ad aumentare con la globalizzazione, il capitalismo politico e il dominio plutocratico. Gli economisti, che non sono dei moralisti, dovrebbero trattare la corruzione come un qualsiasi reddito. Ed è proprio così che la considero nell’ultima parte del capitolo.
4.1. Il lavoro: le migrazioni
4.1a. Definizione di premio o rendita di cittadinanza
Le sistematiche differenze di reddito fra soggetti con lo stesso livello di istruzione, di motivazione e di impegno, ma che sono cittadini di paesi diversi, possono essere definite «premio di cittadinanza» o «penalità di cittadinanza». Per semplicità, mi concentrerò sul primo. Ma anche se l’esistenza del premio appare chiara nei fatti, la domanda davvero importante, da un punto di vista economico, è se il premio di cittadinanza possa essere assimilato a una rendita, cioè a un reddito non strettamente necessario per la produzione. In altre parole, in un esperimento mentale, si potrebbero forse sostituire persone dotate di un determinato livello di abilità in un’economia avanzata con persone di un altro paese più povero che possiedono lo stesso livello di abilità e sono identiche per tutti gli altri aspetti legati al lavoro, pagarle di meno e alla fine ottenere la medesima produzione?1 Il quasi equivalente di questo esperimento mentale è consentire la piena libertà di circolazione dei lavoratori nei diversi paesi.
Il premio di cittadinanza è una rendita? Come dimostra il nostro esperimento concettuale, la risposta sembra essere sì. Poiché i lavoratori maggiormente retribuiti potrebbero essere sostituiti da un identico gruppo di persone disposte a lavorare per un salario inferiore, il costo di produzione sarebbe ridotto e il dividendo «nazionale» o «globale» (cioè il reddito netto) aumenterebbe. La rendita di cittadinanza esiste, in prima approssimazione, a causa del controllo degli accessi a una determinata porzione geografica del mondo da parte di chi vi risiede. La cosa, a sua volta, si associa a un flusso elevato di reddito nell’arco della vita che affonda le sue radici nelle elevate disponibilità di capitale, nella tecnologia avanzata e nelle buone istituzioni che esistono in quella regione. L’elemento essenziale è il controllo del territorio, anche se questo si traduce nel controllo su una partecipazione «ideale» alla cittadinanza. La cittadinanza conferisce al titolare un diritto di cointeressenza nella produzione di quella parte del mondo a cui si applica la cittadinanza (e, in alcuni casi, anche alla produzione realizzata altrove dai cittadini del paese)2.
Sembra quindi, a prima vista, che la rendita di cittadinanza sia simile alla rendita della terra o delle risorse naturali. Questa rassomiglianza deriva dal fatto che in entrambi i casi l’elemento che dà origine alla rendita è il controllo su un bene immobile. L’analogia, però, è corretta solo in parte. La rendita dei terreni è dovuta alla diversa produttività dei vari appezzamenti. Il prezzo del prodotto finale (olio o mais) è determinato dal costo di produzione del produttore marginale (più costoso) per la cui produzione vi sia ancora una domanda sufficiente. Di conseguenza, tutti i produttori inframarginali percepiscono una rendita. Nel caso della cittadinanza – che, come vedremo, è una categoria «ideale» e può essere «sganciata» dal territorio –, il nesso con il controllo fisico della terra è più tenue. Inoltre, tutti i cittadini (in qualità di «comproprietari») di ogni paese partecipano alla rendita di cittadinanza o, nel caso del paese più svantaggiato, non ne ricevono alcuna. La seconda differenza rispetto alla rendita della terra è che l’oggetto (la terra) che dà origine alla rendita è commerciabile, cioè può essere acquistato e venduto. Questo non vale, in linea di principio, per la cittadinanza (anche se vedremo che esistono delle eccezioni). La rendita derivante dalla cittadinanza è quindi più simile a una rendita di monopolio ottenuta da associazioni come le corporazioni che agiscono per limitare il commercio. Proprio come nelle corporazioni, la cittadinanza può essere acquisita per cooptazione o per nascita. Quest’ultima modalità è simile alla situazione delle occupazioni ereditarie che si tramandano da genitore a figlio.
La cittadinanza è una categoria «ideale»
La cittadinanza è ancora quasi sempre «legata al territorio», cioè si applica principalmente alle persone che vivono all’interno dei confini geografici di un determinato paese, con il reddito necessario per pagare la rendita di cittadinanza prodotta di solito in quel paese. Ma non solo lì. Questa situazione è facilmente comprensibile se si prende l’esempio di quei cittadini che non vivono nei loro paesi (per esempio, gli americani residenti all’estero). Queste persone hanno accesso alle prestazioni sociali dei rispettivi paesi d’origine, che fanno parte del premio di cittadinanza; le risorse utilizzate per produrre il reddito necessario per pagare queste prestazioni sono nazionali e perlopiù legate al territorio. Un cittadino statunitense che vive in Italia avrà accesso alle prestazioni della previdenza sociale Usa e di altri enti, ma il denaro per pagarle sarà stato prodotto principalmente negli Stati Uniti. Con l’avanzare della globalizzazione, tuttavia, accadrà che queste risorse si svincoleranno dal territorio: possiamo immaginare un mondo in cui una quota crescente del reddito statunitense potrebbe essere prodotta al di fuori degli Stati Uniti per poi rientrare nel paese sotto forma di profitti sul capitale investito all’estero. Una situazione simile potrebbe essere quella di un cittadino filippino residente all’estero che rivendica i benefici della cittadinanza filippina, mentre il reddito necessario per pagarli proviene dalle rimesse dei lavoratori filippini emigrati.
Dilatando queste tendenze nel futuro, potremmo immaginare una situazione in cui la cittadinanza sia completamente svincolata dal territorio: la maggior parte dei cittadini potrebbe non vivere nel proprio paese di cittadinanza, e la maggior parte del reddito di quel paese potrebbe essere prodotta da lavoro o capitale impiegato in altri paesi, eppure i benefici della cittadinanza continuerebbero a essere gestiti nello stesso modo in cui lo sono oggi.
La cittadinanza è quindi vista chiaramente come categoria «ideale». Non si tratta di un diritto di proprietà formale nello stesso senso in cui lo è la proprietà privata di un terreno. Non è nemmeno un diritto di comproprietà su una parte della superficie terrestre da parte delle persone che vi abitano. La cittadinanza è piuttosto un istituto giuridico che esiste solo nella nostra mente (ed è, in questo senso, «ideale»). In senso economico, la cittadinanza è un monopolio congiunto esercitato da un gruppo di persone che condividono una determinata caratteristica giuridica o politica che dà luogo alla rendita di cittadinanza. Avere una determinata cittadinanza è un fatto svincolato dalla necessità di vivere nel proprio paese d’origine, come abbiamo visto qui; inoltre, non è necessario che il reddito per pagare il premio di cittadinanza venga prodotto in quel determinato paese. Il denaro utilizzato per pagare i benefici legati alla cittadinanza non deve necessariamente derivare soltanto dalla produzione realizzata nel particolare luogo formalmente legato alla cittadinanza, né essere percepito da persone che vi abitino (perché il paese stesso può ospitare stranieri che, per il medesimo motivo, potrebbero ricevere una rendita di cittadinanza da un altro paese). Vediamo quindi che la cittadinanza come bene economico può essere, in linea di principio, svincolata, o smaterializzata, rispetto al territorio a cui fa riferimento.
4.1b. La cittadinanza come bene economico
Come ogni rendita percepita nel tempo, la rendita di cittadinanza può essere trasformata in un bene attualizzando i probabili rendimenti futuri. (Nel caso della cittadinanza, questo periodo dura tipicamente fino alla morte del titolare, ma in alcuni casi, come per le pensioni di reversibilità, può durare anche più a lungo). Se la cittadinanza del paese A porta x unità di reddito all’anno più della cittadinanza del paese B, allora il valore del bene (cittadinanza di A) sarà pari alla somma di tutte queste x (attualizzate al tasso appropriato) nell’arco della vita attesa del titolare. Il guadagno tratto da una determinata cittadinanza varierà in funzione della cittadinanza che una persona detiene attualmente, della sua età e di molte altre circostanze che qui ci interessano meno, come il livello di istruzione. Da un punto di vista individuale, la rendita di cittadinanza viene stimata attraverso una serie di confronti bilaterali, in cui il valore della propria cittadinanza attuale viene confrontato con tutte le altre cittadinanze esistenti3. Questo valore sarebbe positivo secondo alcuni calcoli e negativo per altri. Che la cittadinanza è un bene diventa molto chiaro se si considera l’età del potenziale detentore. Ferme restando tutte le altre condizioni (compreso il fatto di avere dei figli e preoccuparsi per loro), la cittadinanza come bene sarà più preziosa per i giovani che non per gli anziani. Il flusso di reddito differenziale che i giovani percepiscono se passano a una cittadinanza «migliore» è più elevato4.
Dobbiamo considerare ora due questioni aggiuntive che porteranno la nostra disamina più vicina al mondo reale. Innanzitutto, il bene «cittadinanza» può diventare oggetto di transazioni di mercato? E in secondo luogo, esistono differenti categorie di cittadinanza? Poiché la risposta in entrambi i casi è affermativa, il risultato sarà quello di moderare la netta dicotomia evidenziata finora tra (a) beni commerciabili e cittadinanza, e (b) cittadinanza e non cittadinanza.
La cittadinanza come bene commerciabile
Negli ultimi vent’anni la cittadinanza è diventata un bene legalmente commerciabile: i permessi di soggiorno che portano alla cittadinanza possono essere acquistati in molti paesi, fra cui Canada e Regno Unito, affrontando un consistente investimento privato. La struttura sul modello delle gilde che protegge la cittadinanza si è quindi un po’ allentata e la cittadinanza è diventata, in alcuni casi, e su scala molto modesta, una merce commerciabile. I governi hanno capito chiaramente che la cittadinanza è in effetti un bene, e il fatto di venderla può essere nell’interesse dei cittadini del paese, supponendo implicitamente che il vantaggio monetario derivante dalla vendita di quel bene vada a compensare più che abbondantemente la perdita legata al fatto di condividere la cittadinanza con una persona in più. È nell’interesse di chi è già cittadino fissare un prezzo elevato per la cittadinanza, che quindi viene offerta in vendita solo a individui ricchi. I costi per l’acquisto, diretto o previo ottenimento del permesso di soggiorno, sono elevati: si va da 250.000 euro in Grecia a 2 milioni di sterline nel Regno Unito. Ma si tratta di costi facilmente sostenibili per soggetti che possiedono grandi patrimoni (persone le cui attività finanziarie possono andare da 1 milione a 5 milioni di dollari): si stima che più o meno un terzo di questi ricchi individui, cioè circa 10 milioni di persone nel mondo, abbiano un secondo passaporto o la doppia cittadinanza (Solimano 2018, p. 16, calcolato sulla base del Credit Suisse, Global Wealth Report 2017).
La sottocittadinanza
Per affrontare il tema della cittadinanza così come si presenta nella realtà, dobbiamo riconoscere che esistono diverse categorie (livelli) di cittadinanza. La nostra preoccupazione, ovviamente, riguarda la cittadinanza come categoria economica, ossia il diritto a un flusso di reddito più elevato. Nella maggior parte dei casi, la cittadinanza è una categoria binaria (0-1) – o si è cittadini o non lo si è – ed è necessario un titolo giuridico formale di cittadinanza per accedere a determinati benefici economici. Ma altre situazioni sono più sfumate. Ci sono anche casi di quella che potremmo chiamare «sottocittadinanza», associata alla maggior parte dei benefici economici che la cittadinanza offre, ma non a tutti. Il caso più noto è quello dei soggiornanti di lungo periodo negli Stati Uniti (titolari della carta di residenza permanente, nota con il nome di green card), benché forme simili esistano anche nella maggior parte dei paesi europei. Questi soggetti hanno accesso a quasi tutti i benefici previsti per i cittadini, con la possibile eccezione di alcuni trasferimenti sociali e del diritto di voto (le eccezioni variano in Europa a seconda del paese, e negli Stati Uniti e in Canada in base allo Stato e alla provincia). Ma l’esistenza dei sottocittadini è importante perché mostra come il rigido sistema della distinzione binaria (cittadino/non cittadino) possa diventare più flessibile, soprattutto in risposta alla domanda di manodopera.
La sottocittadinanza non è limitata alle persone che emigrano per ottenere una rendita di cittadinanza e poi si trovano per qualche tempo nella posizione intermedia di sottocittadini. Fino a poco tempo fa, chi nasceva in Germania da genitori non tedeschi non aveva accesso all’intera gamma di diritti e benefici derivanti dalla cittadinanza, ed era quindi un sottocittadino. La situazione degli arabi che vivono in Israele è simile. Alcuni rimangono per tutta la vita nella condizione di residenti, senza alcuna speranza di ottenere la cittadinanza né di trasferire lo status di soggiornante di lungo periodo ai propri figli. Ma i cittadini israeliani di origine araba si trovano in una posizione ancora più insolita. Sono sollevati da alcuni doveri, come la leva. Sono quindi in una situazione paradossale: se il servizio militare è considerato un costo (cosa logica, per molte buone ragioni, tra cui il mancato guadagno durante la ferma), la loro posizione è un mix fra l’essere sottocittadini, in quanto vivono in un paese che è formalmente definito lo Stato di un altro popolo, e supercittadini, perché hanno diritto alla maggior parte dei benefici, ma vengono risparmiati loro alcuni dei costi. Esistono numerosi altri casi di cittadinanza differenziata5.
4.1c. Libera circolazione dei fattori di produzione
Nuovi atteggiamenti verso la libera circolazione dei fattori di produzione
Come promemoria storico, vale la pena di notare che le attuali posizioni dei paesi ricchi e di quelli poveri rispetto alla libera circolazione dei fattori di produzione sono l’opposto rispetto al passato. I paesi ricchi che erano tipicamente esportatori di capitali ne hanno sostenuto la libera circolazione fino a poco tempo fa, quando hanno cominciato a crescere le preoccupazioni per l’esternalizzazione. Non avevano una posizione ben definita in materia di migrazioni, in quanto i flussi di persone dopo gli sconvolgimenti provocati dalla Seconda guerra mondiale erano stati minimi6. I paesi poveri, invece, pur accogliendo a volte capitali stranieri, sono sempre stati diffidenti, per la paura di essere sfruttati o emarginati. Come vedremo nel sottoparagrafo successivo, questo atteggiamento ha subìto una svolta radicale con l’avvento delle catene globali del valore, che sono ora molto ricercate dalle economie di mercato emergenti. I paesi poveri erano a favore della libera circolazione delle persone in passato, come lo sono ancora oggi. Questo atteggiamento è stato talvolta mitigato dai timori per la fuga dei cervelli, ma nel complesso sembravano preoccupazioni minori rispetto ai vantaggi che molti paesi poveri intravedevano nella riduzione della pressione demografica e nell’aumento delle rimesse. Così, i paesi ricchi che un tempo erano indifferenti o addirittura a favore delle migrazioni (come lo è stata la Germania durante il suo Wirtschaftswunder, il «miracolo» economico degli anni Cinquanta e Sessanta) hanno oggi paura di un fenomeno che pare in aumento, mentre i paesi poveri che un tempo diffidavano del capitale straniero oggi lo corteggiano assiduamente7.
Da un punto di vista economico, impedire ai lavoratori di spostarsi da un paese all’altro è senza dubbio inefficiente. La mobilità di ciascun fattore di produzione è considerata superiore all’immobilità perché ogni fattore di produzione tenderà naturalmente a fluire verso l’area geografica o il ramo di attività in cui il suo rendimento è più elevato, e il suo rendimento è più elevato perché il suo contributo (il valore della produzione realizzata) è maggiore che altrove. Questa proposizione generale si applica in egual misura al capitale e al lavoro.
È importante essere chiari su cosa la proposizione implica e cosa no. Implica che il fattore che si sposta altrove migliora la propria condizione rispetto a dove si trovava prima. Ciò deriva semplicemente dal fatto di avere due possibilità – rimanere o andare via – e scegliere quest’ultima. La proposizione implica inoltre che la produzione totale sarebbe maggiore con l’opzione della mobilità che senza di essa. Ma non implica che tutto il resto andrebbe meglio. La circolazione dei lavoratori o dei capitali dalla loro attuale ubicazione a un’altra potrebbe perturbare o sostituire il lavoro e il capitale, oppure peggiorarne le condizioni rispetto al luogo di origine. In particolare, i lavoratori potrebbero trovarsi ad affrontare condizioni più sfavorevoli e quest’ultimo elemento è uno dei principali motivi di attrito oltre che, probabilmente, una delle ragioni essenziali per cui la mobilità internazionale del lavoro è limitata. In ambito politico, questa è spesso la motivazione che i paesi ricchi adducono contro l’immigrazione.
Le migrazioni al tempo della globalizzazione
Che cosa sono le migrazioni? Per i nostri scopi (cioè, in condizioni di globalizzazione), definiremo le migrazioni come il movimento di un fattore di produzione (il lavoro) quando la globalizzazione avviene in condizioni di reddito medio disuguali tra i paesi. Può sembrare una definizione complicata, ma ogni sua parte è essenziale. Innanzitutto, il lavoro (da una prospettiva strettamente economica) è solo uno dei fattori di produzione, non diverso dal capitale. In linea di principio, non dovremmo trattare un fattore di produzione in modo diverso dall’altro. Per questo motivo, la definizione evidenzia, in prima approssimazione, che il lavoro non ha nulla di speciale.
In secondo luogo, il movimento delle persone (di nuovo, come il movimento dei capitali) è reso possibile dalla globalizzazione. Se il mondo non fosse globalizzato e se le economie fossero autarchiche, con forti controlli sul deflusso e l’afflusso di capitali e manodopera, né l’uno né l’altro fattore si muoverebbero attraverso i confini.
Terzo, se la globalizzazione esistesse, ma avesse luogo in condizioni in cui i redditi nelle diverse parti del mondo non fossero troppo diversi, il lavoro non avrebbe alcun incentivo sistematico a spostarsi. Ci sarebbero sicuramente delle migrazioni, dal momento che le persone si sposterebbero alla ricerca di opportunità migliori per le competenze specifiche in loro possesso, oppure nella speranza di trovare un clima più gradevole o una cultura più congeniale, ma questi movimenti sarebbero di modesta entità e di carattere individuale. Tali flussi di persone sono quelli che osserviamo negli Stati Uniti, dove, per esempio, gli ingegneri informatici hanno maggiori probabilità di trasferirsi nella Silicon Valley e i minatori nel South Dakota, oppure, nell’ambito dell’Ue a 15 (i quindici membri dell’Unione europea prima del 2004), dove i pensionati inglesi si trasferiscono in Spagna alla ricerca di condizioni meteorologiche più favorevoli, o i tedeschi comprano ville in Toscana. Ma questi flussi sono diversi dai movimenti sistematici che esistono a tutti i livelli, cioè quando persone di tutte le età e professioni che vivono in un paese più povero possono aspirare a un miglioramento del loro reddito trasferendosi in un paese più ricco.
Se consideriamo le migrazioni nel contesto della globalizzazione attuale, possiamo facilmente comprendere l’origine e la logica dei movimenti delle persone. Risulta anche evidente che se esistono (a) la globalizzazione e (b) grandi differenze di reddito fra le diverse parti del mondo, i lavoratori non rimarranno là dove sono nati. Crederlo sarebbe contrario al teorema economico elementare secondo cui le persone aspirano a migliorare il loro tenore di vita. Se crediamo, tuttavia, che le persone non dovrebbero spostarsi da un paese all’altro (una sorta di comandamento), possiamo logicamente sostenere che si dovrebbe invertire la globalizzazione (ossia che si dovrebbero introdurre ostacoli alla libera circolazione dei capitali e del lavoro) o che si dovrebbe compiere un grande sforzo per accelerare la convergenza dei redditi fra paesi poveri e paesi ricchi. Mentre il primo approccio ridurrebbe immediatamente le migrazioni, il secondo richiederebbe decenni per rallentarle, ma alla fine raggiungerebbe lo scopo8.
Il fatto che gli approcci possibili siano solo due, e soltanto uno di essi funzioni rapidamente, spiega perché chi si oppone alle migrazioni ha una sola proposta coerente da un punto di vista logico, e cioè rendere i paesi meno globalizzati erigendo barriere alla circolazione dei capitali e dei lavoratori. Pur essendo coerente, la proposta va incontro a diversi problemi. Una così drastica inversione di tendenza della globalizzazione è possibile da immaginare, ma è improbabile che si realizzi a causa della struttura organizzativa estremamente complessa a sostegno della globalizzazione stessa che è stata costruita negli ultimi settant’anni. Anche se alcuni paesi facessero un passo indietro, la maggioranza non andrebbe in quella direzione. Ulteriori ostacoli alla libera circolazione dei capitali e del lavoro porterebbero anche alla riduzione dei redditi a livello globale, anche nei paesi che avessero scelto di «uscire» dalla globalizzazione. La prova può giungere da un’argomentazione contraria: se si sostiene che il reddito nazionale non sarebbe influenzato dalle barriere di confine, allora si dovrebbe anche sostenere che il reddito non sarebbe influenzato da barriere interne alla circolazione dei capitali e del lavoro. Si dovrebbe quindi argomentare che non importa se le persone o i capitali si spostano oppure no, per esempio, tra New York e la California o tra due località qualsiasi degli Stati Uniti. Proseguendo il ragionamento fino a unità geografiche sempre più piccole, si giungerebbe presto alla conclusione che la mobilità del lavoro (geograficamente o per occupazione) non ha alcun effetto sul reddito totale, e questa è una proposizione evidentemente falsa9. L’assurdità di tale posizione rivela che la stessa, se assunta rispetto alla libera circolazione delle persone da un paese all’altro, è altrettanto assurda.
L’inadeguatezza di questo argomento mette gli oppositori delle migrazioni in un vicolo cieco in cui hanno bisogno di difendere le politiche anti-immigrazione nonostante gli effetti negativi di queste politiche sul benessere globale e su quello del paese che sostengono di voler proteggere. Si tratta in effetti di una posizione molto difficile da sostenere, e pochissime persone che hanno intrapreso l’esercizio logico delineato sopra la assumerebbero.
Sembra quindi che, per quanto riguarda gli scambi di merci o la circolazione transfrontaliera dei capitali, la migliore politica in materia di lavoro sarebbe la libera circolazione delle persone da un paese all’altro. Laddove gli effetti su specifici gruppi di lavoratori fossero negativi, questi dovrebbero essere affrontati mediante politiche specifiche rivolte a tali gruppi, così come si fa di solito (almeno in teoria) per mitigare gli effetti deleteri delle importazioni su determinate categorie di lavoratori nazionali.
E allora, siamo venuti a capo del problema delle migrazioni? Purtroppo no.
Perché il lavoro è diverso dal capitale
Il motivo per cui non abbiamo ancora risolto questo problema è che chi vi si oppone ha una carta in più da giocare che finora abbiamo ignorato. È la convinzione che il lavoro e il capitale, benché entrambi fattori di produzione e quindi in senso astratto uguali, siano fondamentalmente diversi. Il capitale, in questa prospettiva, può entrare nelle società senza produrre cambiamenti radicali al loro interno, mentre nel caso del lavoro questo non è possibile. I fautori di tale visione potrebbero sostenere che un’impresa straniera può investire in un paese, introdurre un nuovo modo di organizzare il lavoro, e magari anche sostituire alcuni tipi di lavoratori impiegandone altri, senza però disturbare – indipendentemente dal numero di tali imprese straniere che giungano nel paese – le caratteristiche culturali o istituzionali chiave della società. Questa posizione, tuttavia, può essere contestata. L’impatto delle nuove tecnologie è spesso dirompente da un punto di vista sociale: non solo alcune competenze diventano superflue, ma anche quello che può sembrare un cambiamento in meglio avrà molti effetti collaterali, alcuni dei quali negativi. Per esempio, le aziende straniere possono essere meno gerarchizzate o più aperte ad assumere le donne o gli omosessuali e a non discriminarli. Mentre molti considerano tali sviluppi auspicabili, la popolazione autoctona potrebbe giudicarli un fattore di disturbo per il proprio modo di vita e i propri valori. La cosa importante da ricordare a coloro che attribuiscono effetti di disturbo sociale solo ai lavoratori migranti è che effetti di disturbo analoghi possono derivare dall’afflusso di capitali dall’estero.
Ma potrebbe ancora essere vero che la circolazione dei lavoratori crea disturbi maggiori. È questa, infatti, l’argomentazione finale e decisiva di cui si fanno scudo coloro che si oppongono alle migrazioni. Un grande afflusso di lavoratori stranieri diversi per cultura, lingua, comportamenti, valori e modalità di interazione con gli altri può creare, per esempio, insoddisfazione in entrambe le parti (i nativi e gli immigrati), oltre che portare a conflitti sociali, perdita di fiducia e, infine, addirittura alla guerra civile.
George Borjas (2015) sostiene che i migranti dai paesi poveri si portano dietro i sistemi di valori dei loro luoghi di provenienza. Nel complesso, questi sistemi di valori sono in contrasto con lo sviluppo (ecco perché i paesi sono poveri) e, entrando in un paese più ricco e portando con sé questi loro comportamenti, i migranti minano le istituzioni del paese ricco che sono necessarie alla crescita. I migranti, in questo senso, sono come le termiti: distruggono strutture stabili e robuste, e sarebbe quindi ragionevole impedirglielo. Si noti che la posizione di Borjas contraddice radicalmente l’esperienza storica americana, sia nei fatti sia nello spirito dei celebri versi «Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free»10. Secondo la logica di Borjas, queste masse «stanche e povere» dovevano aver sovvertito già da tempo la prosperità americana.
Vi sono, tuttavia, esempi storici che sostengono il punto di vista di persone come Borjas. Quando i Goti si trovarono a subire l’assalto furioso degli Unni all’inizio del iv secolo, implorarono i Romani di permettere loro di attraversare il limes, la frontiera militare, sul Danubio per stabilirsi negli attuali Balcani. Dopo attenta valutazione, i Romani si dissero d’accordo, ma pur permettendo loro l’ingresso, vollero approfittare dell’impotenza dei Goti e commisero una serie di oltraggi: portarono via i loro figli, rapirono le donne e ridussero in schiavitù gli uomini. Quella che ai governanti del centro dell’Impero era sembrata una mossa saggia e generosa si trasformò sul campo nel suo contrario. Il risultato fu che i Goti «salvati», a cui era stato concesso di entrare in quei territori, cominciarono a nutrire un odio implacabile verso l’Impero romano che portò in principio alla loro ribellione e poi a numerose battaglie – tra cui quella che vide morire, per la prima volta, un imperatore romano sul campo di battaglia – e infine al sacco di Roma condotto nel 410 dai Goti di Alarico (anche se Roma non era ormai più la capitale). In questo caso, le migrazioni su vasta scala e il mescolarsi delle popolazioni si sono rivelati disastrosi. Si potrebbero addurre esempi simili praticamente all’infinito, soprattutto se consideriamo (come sarebbe doveroso fare) la conquista europea delle Americhe alla stregua di una migrazione, cioè un movimento di persone in cerca di una vita migliore. La conquista è stata una catastrofe per le popolazioni indigene, che nei loro primi incontri con i migranti europei si erano dimostrate, in molti casi, estremamente accoglienti.
Questo genere di argomentazioni contro le migrazioni ha un qualche fondamento. Il mescolarsi su vasta scala di popoli di culture diverse potrebbe, anziché portare a un reddito più alto per ognuno, produrre scontri e guerre deleteri per tutti. Una visione molto pessimistica della natura umana in cui la sovrapposizione culturale del proprio gruppo sia ritenuta fondamentale e spesso incompatibile con la sovrapposizione culturale di un altro gruppo di persone sarebbe quindi a favore di migrazioni limitate o pari a zero, anche se, in senso puramente economico, le migrazioni porterebbero a un risultato netto positivo per la popolazione autoctona. Ma, nel lungo periodo, secondo tali punti di vista, permettere le migrazioni potrebbe rivelarsi disastroso.
4.1d. Conciliare le preoccupazioni dei nativi con i desideri dei migranti
Poiché intravedo un fondo di verità nell’affermazione secondo cui le migrazioni sono culturalmente dirompenti o – volendo precisare meglio il concetto – poiché prendo atto che questo punto di vista, valido o meno che sia, è sostenuto implicitamente o esplicitamente da molte persone, propongo un approccio alternativo (e sicuramente controverso) alle migrazioni là dove – è bene ripeterlo – queste avvengano in un ambiente caratterizzato da redditi medi disuguali nei diversi paesi e, quindi, da premi di cittadinanza significativi di cui godono le persone che vivono nei paesi ricchi.
Una proposta in materia di migrazioni
Il tratto distintivo principale del mio approccio, in base al quale si regge o si sgretola, è la proposizione seguente: è più probabile che una popolazione autoctona accetti i migranti se è meno probabile che questi rimangano permanentemente nel paese sfruttando tutti i vantaggi della cittadinanza. Questa proposizione introduce una relazione negativa fra (a) la disponibilità ad accettare i migranti e (b) l’estensione dei diritti di questi ultimi. Esaminiamola più in dettaglio, considerando prima di tutto il suo contrario. Una relazione positiva fra (a) e (b) è improbabile. Ciò implicherebbe che quanti più sono i diritti concessi ai migranti – i quali alla fine sarebbero interamente equiparati in termini di status al resto della cittadinanza – tanto più i nativi sarebbero disposti ad accoglierne altri. Non è impossibile credere che i nativi possano essere desiderosi di integrare al massimo gli stranieri, ma è piuttosto improbabile, a mio avviso, che nel momento in cui concedessero pieni diritti ai migranti, i nativi vorrebbero farne entrare un numero ancora maggiore. Si può pensare che questa condizione sussista solo là dove ci fosse disperatamente bisogno di una popolazione più numerosa, per esempio a causa di una minaccia esterna, o dove i migranti provenissero da un gruppo che la classe dirigente ritenga utile per l’espansione. (Quest’ultimo è stato il caso di alcuni paesi dell’America Latina e dei Caraibi che hanno incoraggiato i migranti provenienti dall’Europa per ridurre la quota di popolazioni indigene o nere.) Ma, nel complesso, una relazione positiva fra le due sembra molto improbabile e, fatta eccezione per alcuni casi specifici in cui un determinato tipo di migrante svolge un ruolo preassegnato, questa non è mai stata osservata, nemmeno nei paesi più aperti. Il caso migliore in cui sperare è quindi che i nativi abbiano semplicemente le idee chiare su quanti migranti intendono accettare, a prescindere dai diritti loro concessi. In tal caso, i fattori (a) e (b) sarebbero ortogonali l’uno rispetto all’altro; sarebbe la situazione della «quota forfettaria»: un numero fisso di migranti – se del caso, pari anche a zero – che i nativi sono disposti ad accettare, a qualsiasi condizione.
Ma senza voler assolutamente appoggiare il punto di vista della «quota forfettaria» dei migranti (dove nessun incentivo può modificare il punto di vista dei nativi sulle migrazioni), sembra ragionevole ritenere che esista una sorta di curva della domanda per i migranti, in cui la domanda è minore quando il costo dei migranti, in termini di diritti e di condivisione del premio di cittadinanza a cui possono ambire, è maggiore. Questa relazione è illustrata nella figura 4.1.
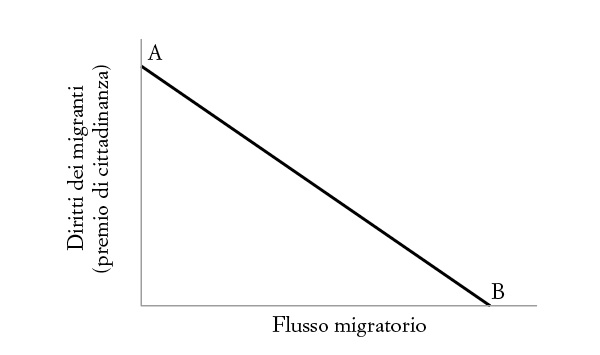
Figura 4.1. Compromesso fra numero di
migranti e diritti garantiti agli stranieri.
Il grafico mostra che se i diritti concessi ai migranti sono molto
pochi, i nativi potrebbero essere più disposti ad accettarne un
numero maggiore.
Consideriamo ora i due casi opposti di quella relazione. In uno, a tutti i migranti vengono attribuiti, al loro arrivo, esattamente gli stessi diritti e doveri dei cittadini. Immaginiamo che vengano forniti loro documento d’identità e passaporto, accesso alle prestazioni e ai trasferimenti sociali, tutela del posto di lavoro, diritto di voto, assistenza sanitaria, alloggio e istruzione gratuita non appena mettono piede sul suolo del nuovo paese. Possiamo supporre, se la politica fosse questa, che i nativi tenderebbero ad accettare pochissimi migranti. Questo è il motivo per cui a una posizione di migrazione desiderata prossima allo zero da parte dei nativi corrisponde la posizione di diritti ampi ed estesi (figura 4.1, punto A). L’estremo opposto è quello in cui vengono concessi ai migranti pochissimi diritti: possono non avere accesso all’istruzione gratuita, al welfare e alla previdenza sociale, così come possono vedersi negare il diritto al ricongiungimento con la famiglia, o addirittura, come suggerito da Richard Freeman (2006), essere soggetti a un’imposizione fiscale più elevata rispetto ai nativi (per via degli evidenti benefici che traggono dalla migrazione). Presuppongo che a questo estremo i nativi sarebbero disposti ad accettare più migranti che non nel primo caso estremo, ossia che il valore sull’asse orizzontale della figura 4.1 (punto B) sarebbe maggiore.
Questi due casi illustrano la mia idea di una relazione negativa fra la disponibilità ad accettare i migranti e l’estensione dei loro diritti. I due estremi (A e B) sono, in effetti, sufficienti per la presenza di una relazione negativa (supponendo che la relazione sia continua e monotòna). Possiamo semplicemente tracciare una linea (la curva della «domanda») che collega i due punti. A seconda delle condizioni di un singolo paese, dell’ampiezza della combinazione di diritti che offre, dei suoi precedenti nei rapporti con i migranti o della generosità della popolazione locale, la curva discendente che collega i due punti può assumere forme diverse. Può essere più ripida o più piatta; può essere quasi piatta in alcune parti e scendere repentinamente in altre. Ma la relazione cruciale della pendenza negativa è consolidata, e sarebbe compito di ogni paese individuare il punto della curva della domanda in cui desidera collocarsi.
La relazione qui proposta può dare spazio a un’ampia varietà di risultati misurati in termini di trattamento dei migranti e dei loro afflussi. Con il trattamento meno vantaggioso per i migranti, si potrebbe immaginare un sistema di migrazione circolare in cui autorizzare una persona a rimanere nel paese di destinazione solo per un periodo, per esempio, di quattro o cinque anni, senza famiglia al seguito, con la possibilità di lavorare per un unico datore di lavoro. Tutti i diritti dei migranti in materia di lavoro sarebbero gli stessi dei lavoratori nazionali (retribuzione, assicurazione contro gli infortuni e la malattia, iscrizione al sindacato e simili), ma non godrebbero di altri diritti civili. Non riceverebbero prestazioni sociali se non quelle legate al lavoro e non avrebbero diritto di voto. In breve, riceverebbero un premio di cittadinanza molto diluito. In questa che è l’ipotesi peggiore per i migranti, il sistema sarebbe simile, senza maltrattamenti e minacce di violenza, a quello attualmente esistente nei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo e a Singapore, e al regime a cui sono sottoposti i titolari di determinati tipi di visto nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Si potrebbe anche muoversi lungo la curva della domanda e offrire più diritti; all’estremo opposto, l’offerta sarebbe di piena uguaglianza con la cittadinanza nazionale.
Vantaggi della proposta
Il vantaggio di pensare alle migrazioni in un tale contesto non è solo quello di consentire flessibilità nella scelta della migliore strategia al riguardo, ma, cosa più importante, di prevenire, attraverso la flessibilità, la scelta dell’opzione peggiore, ossia migrazioni zero. Descrivo a ragion veduta quella delle migrazioni zero come l’opzione peggiore poiché, rispetto a qualsiasi altra alternativa, sarebbe la più svantaggiosa per i migranti, per ampi segmenti della popolazione autoctona (coloro le cui competenze sono complementari a quelle dei migranti o che beneficerebbero dei costi inferiori di produzione di beni e servizi prodotti dai migranti), e per la povertà e la disuguaglianza a livello globale. Accordare diritti differenziati a categorie diverse di residenti è un modo per combattere l’ipotesi peggiore. Non è una soluzione ideale. Se il mondo fosse organizzato diversamente (per esempio, non in Stati-nazione), o se le culture dei popoli fossero omogenee, o ancora se il divario fra i redditi medi dei paesi fosse contenuto, o se le persone fossero sempre buone e pacifiche, le cose potrebbero senza dubbio migliorare. Ma poiché nulla di tutto ciò è vero, abbiamo bisogno di un approccio realistico che prenda le opinioni del mondo e delle persone per quelle che sono e, entro tali limiti, elabori una soluzione praticabile.
Trattare in modo differente categorie diverse di residenti è già, come ho detto prima, una realtà in molti paesi. I permessi di soggiorno consentono alle persone di vivere e lavorare nei paesi di destinazione senza godere di tutta una serie di diritti civili. Negli Stati Uniti, il sistema dei diritti e dei doveri è già segmentato. I sottocittadini come i migranti privi di documenti – il cui numero è stimato in oltre 10 milioni, vale a dire circa il 3-4 per cento della popolazione statunitense – non hanno diritto a prestazioni sociali e spesso sono ostacolati nell’accesso all’istruzione gratuita o se la vedono semplicemente negare in certi Stati o in alcune scuole statali; la loro scelta in materia di posti di lavoro è molto limitata (possono accedere solo a quelli per i quali non è richiesta la documentazione completa) e vivono sotto la continua minaccia della deportazione. Non possono viaggiare al di fuori degli Stati Uniti, e questo rende la loro posizione simile a quella dei cittadini dei paesi dell’ex blocco sovietico. Tuttavia, accettano queste gravi limitazioni dei loro diritti e delle loro libertà, nonché uno status sociale inferiore rispetto alla popolazione nativa, in virtù dei guadagni più elevati, della minore violenza e di un trattamento migliore rispetto a quello che riceverebbero nel loro paese d’origine, e anche nell’aspettativa che i diritti dei loro figli non saranno limitati quanto i loro. Le categorie superiori a quella degli immigrati privi di documenti includono persone con diversi tipi di visti temporanei, che possono rimanere negli Stati Uniti solo per un certo numero di anni e lavorare per uno specifico datore di lavoro. I titolari di carta verde sono, in termini di possibilità di lavoro e anche di tassazione, equivalenti ai cittadini, ma non hanno diritto di voto (e quindi non hanno voce in capitolo in materia di imposizione fiscale o qualsiasi altra politica nazionale). Vediamo quindi in questo esempio che esistono già condizioni variabili, alcune delle quali si sono fatte strada a poco a poco in maniera surrettizia, e gradi di appartenenza in un’area che, teoricamente, dovrebbe ammettere solo una distinzione binaria fra cittadini e non cittadini. Molti di questi approcci rappresentano aggiustamenti rispetto alla globalizzazione e al mondo della non autarchia, dove quel genere di divisione netta tra cittadini e non cittadini che esisteva nel Novecento oggi non è più sostenibile.
Flessibilità nella scelta del punto sulla curva della domanda non significa flessibilità nell’applicazione delle regole. È vero il contrario. Affinché il sistema di migrazione circolare funzioni, è necessario consentire dei flussi legali. Allo stesso tempo, però, occorre chiudere tutti i canali di immigrazione clandestina. In caso contrario, la scelta ponderata del punto ottimale sulla curva della domanda diventerà irrilevante e il livello effettivo delle migrazioni potrà superare di gran lunga quello ottimale scelto; in tal caso, il pericolo di un contraccolpo negativo sarebbe grave. Se si dimostra che un paese non è in grado di applicare le regole, gli elettori nazionali potrebbero decidere che l’unica soluzione ragionevole è quella di azzerare le migrazioni. Affinché il sistema funzioni, la flessibilità nella scelta dei livelli ottimali di migrazione deve coesistere, a volte, con un giro di vite spietato sulle migrazioni in eccesso.
Svantaggi della proposta
Ma tali proposte che invocano un trattamento discriminatorio de facto dei migranti hanno anche i loro svantaggi. Il più grave è probabilmente la creazione di una sottoclasse la quale, benché non sempre composta dagli stessi individui (nel caso della migrazione circolare), esisterebbe senza mai essere assorbita dalla comunità indigena. Si può pensare che questo porterebbe alla creazione di ghetti locali, a un tasso elevato di criminalità e a un generale senso di alienazione dalla popolazione autoctona (e viceversa). Il problema della ghettizzazione può essere meno grave di quanto non sembri a prima vista, in quanto migranti più qualificati e ben retribuiti si mescolerebbero più facilmente con le popolazioni autoctone, ma è improbabile che lo stigma e i problemi di esclusione verrebbero mai completamente eliminati. Occorrerebbe anche applicare con rigore, e magari anche con la coercizione, le norme sull’obbligo di espatrio al termine dei periodi di tempo concessi, e avviare grandi cambiamenti nei paesi che non hanno carte d’identità nazionali.
Questa preoccupazione solleva il problema di come garantire la stabilità sociale in una società così diversificata e in parte disarticolata, in cui i migranti potrebbero costituire una classe a sé. Nella misura in cui i migranti fossero maggiormente diversificati in termini di istruzione e reddito, avrebbero minori probabilità di essere percepiti come una classe a parte, un po’ come i titolari della carta verde negli Stati Uniti di oggi, che non sono visti come un gruppo distinto proprio in quanto individui con diversi livelli di istruzione, competenze e culture. Le differenze di competenze, di tipo di lavoro e di reddito faranno sì che non vivano in aree geografiche separate (lontane dai nativi) e le differenze nelle origini etniche non permetteranno di classificarli come gruppo fisicamente riconoscibile o con molte cose in comune tra loro.
Inoltre, quando ponderiamo gli svantaggi della soluzione proposta, non dobbiamo limitarci a considerarne la somma. Dobbiamo soppesarli rispetto alle alternative, per esempio che un maggiore aiuto da parte dei paesi ricchi potrebbe essere un modo per arginare le migrazioni. Ma per contro, bisogna dire che gli aiuti hanno dato finora pochissimi frutti e, anche se la situazione dovesse cambiare, ci vorrebbe molto tempo prima che questo approccio risolva il problema essenziale delle enormi disparità di reddito che costituiscono un incentivo inarrestabile all’emigrazione11. Pertanto, l’alternativa al menù flessibile dei diritti di cittadinanza si rivelerebbe di nuovo una soluzione di migrazioni zero, il che significherebbe Fortezza Europa e Fortezza America e molti altri morti lungo i confini tra queste due regioni ricche e i loro vicini meridionali più poveri. Non certo un risultato auspicabile.
Passiamo ora ad analizzare la mobilità dei capitali in condizioni di globalizzazione.
4.2. Il capitale: le catene del valore globali
La catena del valore globale – un modo di organizzare la produzione in cui le varie fasi del processo si svolgono in paesi diversi – è probabilmente l’innovazione organizzativa più importante in quest’epoca di globalizzazione. Le catene del valore globali sono state rese possibili sia dalla capacità tecnologica di controllare efficacemente i processi produttivi a distanza sia dal rispetto globale dei diritti di proprietà.
In passato, la mancanza di questi due elementi ha limitato l’espansione del capitale straniero. Quasi duecentocinquanta anni fa Adam Smith aveva osservato che i detentori di capitali preferiscono investire vicino a dove vivono per tenere d’occhio la produzione e il modo in cui viene gestita l’azienda (La ricchezza delle nazioni, libro IV, cap. 2). Fino a quando la rivoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Ict) non ha consentito a persone distanti migliaia di chilometri di mantenere uno stretto controllo sul processo di produzione, è rimasta valida la tesi di Smith, ossia che non potesse esistere capitale globalizzato.
La protezione globale dei diritti di proprietà è il secondo cambiamento importante. La prima era della globalizzazione, databile indicativamente dal 1870 al 1914, fu ostacolata dalla mancanza di garanzie che le proprietà all’estero sarebbero state al riparo da abusi o nazionalizzazioni. La «soluzione» fu trovata nell’imperialismo e nel colonialismo. Le nazioni esportatrici di capitali andarono alla conquista di altri territori o fecero in modo di garantirsi il controllo della politica economica delle quasi colonie affinché paesi come la Cina, l’Egitto, la Tunisia e il Venezuela non avessero altra scelta se non quella di tutelare i diritti di proprietà degli stranieri12. Lo stesso ruolo che il colonialismo ha svolto allora, in maniera più brutale, è quello assunto oggi dal Fondo monetario internazionale (Fmi), dall’Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (Miga), da centinaia di trattati bilaterali di investimento e da altri organismi di governance globale: sono i custodi contro le nazionalizzazioni e l’abuso delle proprietà estere. In questo senso, la globalizzazione ha creato una sua propria struttura di governance.
Le catene del valore globali hanno ridefinito lo sviluppo economico. In passato si sosteneva che la partecipazione dei paesi in via di sviluppo alla divisione internazionale del lavoro fosse negativa ai fini della loro affermazione per almeno tre motivi e che avrebbe portato allo «sviluppo del sottosviluppo», come lo definì André Gunder Frank in un autorevole articolo pubblicato nel 1966.
Innanzitutto, secondo la scuola di pensiero della dependencia (teoria della dipendenza), i rapporti con il Nord del mondo coinvolgevano solo un numero limitato di settori di esportazione e non erano riusciti a sviluppare collegamenti interni avanti o indietro tali da spingere i paesi del Terzo Mondo sulla strada dello sviluppo sostenibile.
Questo punto di vista era integrato da un secondo argomento, definito «pessimismo verso le esportazioni», secondo cui il Sud del mondo sarebbe rimasto indefinitamente un esportatore di materie prime, con un deterioramento delle ragioni di scambio nel lungo periodo.
Infine, Robert Allen (2011) ha recentemente sostenuto che il progresso tecnologico avviene sempre in base al rapporto capitale-lavoro del paese più sviluppato in quel momento. Per esempio, la Gran Bretagna – che nel 1870 era l’economia più avanzata – aveva interesse a introdurre nuove modalità di produzione secondo il rapporto capitale-lavoro (K/L) che la caratterizzava allora; allo stesso modo, gli Stati Uniti, in quanto economia più avanzata di oggi, sono incentivati a innovare in quelle tecniche di produzione che utilizzano rapporti K/L molto elevati. In generale, le economie avanzate non hanno interesse a innovare ai rapporti K/L a cui non producono. (Per esempio, nessuno negli Stati Uniti sarebbe disposto a spendere allo scopo di trovare un modo migliore per costruire un’automobile usando il lavoro manuale anziché i robot). L’implicazione è che oggi i paesi poveri si trovano di fronte alla stessa funzione produttiva, tecnologicamente arretrata e vecchia di due secoli, perché nessuno nel mondo ricco ha interesse a migliorare l’efficienza della produzione al rapporto K/L che esiste da loro. In altre parole, i paesi tecnologicamente avanzati non hanno nessun incentivo a trovare metodi di produzione più efficienti a rapporti K/L diversi dai propri, e i paesi poveri non possiedono il know-how per farlo. Questi ultimi restano quindi invischiati nella trappola della povertà: per svilupparsi hanno bisogno di migliorare la loro produzione, ma le tecnologie esistenti al loro rapporto K/L sono antiquate e inefficienti.
Tutto questo pessimismo verso il Sud del mondo è stato ribaltato dall’aumento delle catene globali del valore. Oggi, perché un paese si possa sviluppare, deve essere incluso nelle filiere occidentali piuttosto che cercare di staccarsi dal mondo ricco. Una delle ragioni principali è che gli investitori stranieri vedono le catene globali del valore come parte integrante dei propri processi produttivi: non occorre più «supplicarli» affinché introducano le tecnologie più avanzate o più appropriate, perché oggi hanno l’incentivo a introdurre lo sviluppo tecnologico al livello dei salari e del rapporto K/L dei paesi poveri, eliminando così la trappola della povertà indicata da Allen. L’importanza di questo cambiamento – sia per la vita reale sia per quanto ci dice a proposito della giustificazione ideologica della globalizzazione come via per lo sviluppo dei paesi più poveri – è davvero fondamentale.
La globalizzazione come spacchettamento
Tali questioni sono analizzate con grande competenza nel libro di Richard Baldwin La grande convergenza (2018). Secondo l’autore, gli unici ad aver accelerato il loro sviluppo sono i paesi che sono stati in grado di inserirsi nelle catene globali di approvvigionamento (o catene del valore), ossia Cina, Corea del Sud, India, Indonesia, Thailandia e Polonia; alcuni altri (Bangladesh, Etiopia, Myanmar, Vietnam, Romania) si potrebbero aggiungere all’elenco. Tuttavia, per capire come mai abbiano tratto tali e tanti vantaggi dalla globalizzazione, dobbiamo comprendere gli aspetti tecnici che differenziano la globalizzazione di oggi da quella precedente, oltre alla migliore tutela dei diritti di proprietà (grazie ai trattati internazionali e ai meccanismi di applicazione). Sono queste nuove e specifiche caratteristiche della globalizzazione ad aver conferito così grande importanza alle catene globali del valore.
Baldwin individua nella globalizzazione tre epoche che si caratterizzano per la riduzione dei costi di trasporto, prima delle merci, poi delle informazioni e infine delle persone. Le prime due epoche corrispondono alle due globalizzazioni che ho già menzionato, mentre la terza è nel futuro. Il ragionamento è il seguente: quando il trasporto delle merci era pericoloso e costoso, la produzione e il consumo dovevano coincidere geograficamente e le comunità consumavano ciò che producevano. Anche nelle società premoderne più sviluppate, come la Roma antica, la maggior parte dei commerci riguardava beni di lusso e grano. Ma Roma era un’eccezione; nella maggior parte delle società premoderne, il commercio era minimo.
Poi venne la rivoluzione industriale, che abbassò i costi di trasporto delle merci. Questo rendeva possibile la spedizione di prodotti verso destinazioni lontane e diede origine alla prima globalizzazione, o primo «spacchettamento» (unbundling), come lo definisce Baldwin: le merci si producevano «qui» e si consumavano «là». Questo fenomeno ha anche fornito all’economia praticamente tutti i concetti e gli strumenti intellettuali che usiamo ancora oggi. Il primo spacchettamento creò una nuova preoccupazione per la bilancia commerciale nazionale, introducendo così il mercantilismo. Portò inoltre a focalizzarsi sulla produzione nazionale dei beni in tutte le loro fasi e a una visione del commercio inteso come la nazione A che esporta un bene verso la nazione B (ma non l’azienda A che vende beni all’azienda B, o l’azienda A che vende beni alla propria controllata, che poi li vende all’azienda B). In ultimo, ci ha fornito una teoria della crescita che vede passare le nazioni dalla produzione di cibo alla produzione di manufatti e in seguito di servizi. Praticamente tutti gli strumenti dell’economia moderna sono ancora radicati nel modo in cui è avvenuto il primo spacchettamento13, le cui principali caratteristiche sono state (a) il commercio di beni, (b) gli investimenti esteri diretti (che, in assenza di altri mezzi per garantire i diritti di proprietà in luoghi lontani, hanno portato al colonialismo) e (c) gli Stati-nazione.
La seconda globalizzazione
Oggi, in quello che Baldwin identifica come il secondo spacchettamento (e la seconda globalizzazione), tutti e tre gli attori principali sono cambiati. Ora, il controllo e il coordinamento della produzione si fanno «qui», ma la produzione effettiva delle merci avviene «là». Notiamo la differenza: prima si spacchettano la produzione e il consumo, poi la produzione stessa14. Lo spacchettamento della produzione è stato reso possibile dalla rivoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che ha permesso alle aziende di progettare e controllare i processi dal centro e di estendere la produzione a centinaia di unità o a subappaltatori sparsi in tutto il mondo. I costi minimi del trasporto delle informazioni (in sostanza, la capacità di coordinare e controllare indipendentemente dalla distanza) hanno rappresentato per il secondo spacchettamento ciò che il basso costo del trasporto marittimo ha significato per il primo. Ora, i principali attori sono (a) l’informazione e il controllo (invece dei beni), (b) le istituzioni coercitive globali (invece del colonialismo), e (c) le aziende (invece delle nazioni).
Un altro paio di aspetti caratterizzano il secondo spacchettamento. Innanzitutto, è aumentata l’importanza delle istituzioni. Quando la globalizzazione riguardava solo le esportazioni di beni, le istituzioni del paese verso cui le merci venivano esportate non avevano grande importanza; che fossero buone o cattive, gli esportatori venivano pagati più o meno allo stesso modo15. Non è così per il secondo spacchettamento. Quando la produzione viene delocalizzata, la qualità delle istituzioni, delle infrastrutture e della politica nel paese ricevente riveste la massima importanza per il centro. Se i progetti vengono rubati, le merci confiscate, o gli spostamenti delle persone tra il centro e la sede delocalizzata all’estero diventano difficoltosi, l’intera struttura produttiva dell’azienda crolla. Per il centro, la qualità delle istituzioni nella sede estera diventa importante quasi quanto la qualità delle istituzioni a livello locale. Ciò significa che le istituzioni della periferia devono essere il più lontane possibile dalle istituzioni esistenti nel centro o essere il più possibile integrate, il che è esattamente l’opposto di quanto insegnava la scuola della dependencia.
In secondo luogo, il progresso tecnologico nelle sedi all’estero assume oggi sfumature completamente diverse rispetto al passato. Mentre un tempo i paesi in via di sviluppo dovevano cercare di indurre gli investitori stranieri a condividere il loro know-how, ora un’azienda con sede nel centro (la casa madre) ha tutto l’interesse a far sì che la migliore tecnologia sia utilizzata nella sede offshore, che è diventata parte integrante della catena di produzione del centro stesso. Si tratta di un cambiamento enorme: non sono più i paesi poveri che cercano di incentivare le società straniere a trasferire le tecnologie, perché ora sono coloro che le possiedono a volerle trasferire il più possibile verso le sedi delocalizzate.
La situazione, in un certo senso, si è capovolta: ora è la nazione in cui si trova la casa madre che cerca di impedire all’azienda di trasferire le sue migliori tecnologie verso la periferia. Le rendite da innovazione, percepite da chi detiene posizioni di leadership a livello tecnologico, vengono disperse lontano dal centro. Questo è uno dei principali motivi per cui la gente nel mondo ricco si lamenta spesso dell’esternalizzazione (o delocalizzazione). Il fenomeno attira critiche non solo in quanto dannoso per l’occupazione nazionale, ma anche perché le rendite da innovazione vengono condivise più spesso con i lavoratori stranieri che non con quelli nazionali. I guadagni derivanti dalle nuove tecnologie vanno agli imprenditori e ai capitalisti del centro, ma anche ai lavoratori delle aree meno sviluppate in cui viene esternalizzata la produzione. Un’indicazione di questo processo è che la delocalizzazione è stata particolarmente forte nelle industrie ad alta tecnologia. In uno studio su otto economie avanzate (Danimarca, Finlandia, Germania, Giappone, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti), Bournakis, Vecchi e Venturini (2018) hanno rilevato che la delocalizzazione in ambito high-tech è passata dal 14 per cento del valore aggiunto alla fine degli anni Novanta (il livello a cui era dall’inizio di quel decennio) a circa il 18 per cento del 2006. La delocalizzazione nelle industrie a bassa tecnologia è rimasta stabile intorno all’8 per cento del valore aggiunto. Le persone escluse dai benefici sono i lavoratori dei paesi ricchi. Questo cambiamento è anche una delle ragioni principali per cui la globalizzazione di oggi è accompagnata dalla perdita di potere contrattuale dei lavoratori nei paesi ricchi e dalla stagnazione dei salari dei lavoratori meno qualificati (o almeno di quelli che possono essere facilmente sostituiti da stranieri). Questo spiega anche i recenti tentativi di mettere un freno alla globalizzazione nel mondo sviluppato. E, soprattutto, è all’origine di una tacita coalizione che si è formata, a livello globale, fra i ricchi dei paesi ricchi e i poveri dei paesi poveri.
La seconda globalizzazione introduce il capitalismo globale
Il secondo spacchettamento muta anche radicalmente il nostro punto di vista secondo cui lo sviluppo passerebbe attraverso fasi ordinate e predeterminate. Secondo la vecchia concezione – elaborata sul modello dei percorsi di sviluppo seguiti dall’Inghilterra, e più tardi dagli Stati Uniti e dal Giappone –, i paesi passavano attraverso una fase di sostituzione delle importazioni con una protezione tariffaria significativa, quindi sviluppavano le esportazioni di manufatti semplici, per poi passare gradualmente a prodotti più sofisticati e a più alto valore aggiunto. È stata questa l’idea alla base della maggior parte delle politiche di sviluppo tra gli anni Cinquanta e Ottanta. La Corea del Sud, il Brasile e la Turchia sono gli esempi più rappresentativi di paesi che hanno seguito questo percorso. Negli anni Novanta, con la seconda globalizzazione, le cose sono cambiate. L’elemento essenziale per il successo dei paesi in via di sviluppo non è più seguire un percorso attraverso diverse fasi prestabilite applicando politiche economiche proprie, bensì entrare a far parte delle catene globali di fornitura organizzate dal centro (il Nord del mondo). E inoltre, non solo entrare in fasi a più alto valore aggiunto copiando i paesi più ricchi, ma, come sta facendo oggi la Cina, diventare essi stessi leader tecnologici. Il secondo spacchettamento ha permesso di saltare le fasi che prima si ritenevano necessarie. Recentemente, negli anni Ottanta, era impensabile che paesi prevalentemente rurali e poveri, come l’India e la Cina, potessero diventare leader tecnologici nel giro di due o tre generazioni, o che in determinati settori si potessero avvicinare alla frontiera delle possibilità di produzione. Grazie al loro inserimento nelle catene di fornitura globali, questa è ora la realtà.
Il modo di interpretare il successo dell’Asia nell’era attuale non è quello di vedere la Cina, l’India, l’Indonesia, la Thailandia e via elencando come nuove versioni della Corea del Sud. Sono i battistrada di una nuova via allo sviluppo che, attraverso l’integrazione delle rispettive economie nel mondo industrializzato, fanno un balzo in avanti saltando diverse fasi tecnologiche e istituzionali. I paesi di maggior successo nella seconda globalizzazione sono quelli che, per fattori istituzionali, competenze e costo del lavoro, oltre che per la loro vicinanza geografica con il Nord del mondo, sono in grado di diventare parte integrante dell’economia di quest’ultimo. Questo modello inverte il vecchio paradigma della dependencia, secondo cui la chiave dello sviluppo era quella del distacco. Al contrario, legarsi è ciò che ha permesso all’Asia di percorrere la strada dalla povertà assoluta a una condizione di reddito medio in un arco di tempo molto breve. Questo legame tecnologico e istituzionale è all’origine della diffusione del capitalismo nel resto del mondo e del suo attuale dominio universale. La seconda globalizzazione e il dominio del capitalismo vanno quindi di pari passo.
Quale sarà la terza globalizzazione, secondo Baldwin? Lo spacchettamento definitivo (almeno dal punto di vista odierno) arriverà con la capacità del lavoro di muoversi senza soluzione di continuità. Ciò avverrà quando i costi di spostamento della manodopera o del telelavoro scenderanno. Per le operazioni che richiedono la presenza fisica di una persona, il costo del suo spostamento temporaneo in un luogo diverso è ancora elevato. Ma se la necessità della presenza fisica di un lavoratore viene risolta attraverso il controllo da postazione remota, come già accade con i medici che eseguono interventi chirurgici a distanza utilizzando dei robot, allora anche il lavoro si potrà globalizzare. Il terzo spacchettamento, quello della manodopera (come fattore nel processo produttivo) dalla sua collocazione fisica, ci farà pensare alle migrazioni e ai mercati del lavoro in modo molto diverso: se compiti che oggi richiedono la presenza fisica di un lavoratore potranno essere svolti a distanza da una persona in un qualsiasi punto del globo, allora la migrazione dei lavoratori diventerà molto meno importante. Come risultato del terzo spacchettamento, potremmo arrivare ad avere un mercato del lavoro globale che riprodurrà l’aspetto del mondo se le migrazioni fossero completamente libere, ma senza alcun movimento effettivo di persone16.
Forse l’intuizione più importante fornita dalla visione di Baldwin della globalizzazione come spacchettamenti successivi è che ci permette di vedere il progresso economico degli ultimi due secoli come un continuum guidato dalle progressive facilitazioni della circolazione delle merci, dell’informazione e, in ultima analisi, delle persone. Fornisce anche uno scorcio di un’utopia (o forse una distopia) in cui tutto potrebbe essere spostato quasi istantaneamente e senza soluzione di continuità in tutto il mondo. Sarebbe la vittoria decisiva sulle costrizioni del tempo e dello spazio.
Ma il terzo grande spacchettamento non è ancora arrivato, e così continuiamo a vivere in un mondo in cui la manodopera si deve spostare fisicamente nel luogo in cui il lavoro viene eseguito, e gli utili della stessa unità produttiva subiscono variazioni significative a seconda di dove si svolge il lavoro. In altre parole, abbiamo tutt’oggi a che fare con un mondo in cui, come spiegato nel paragrafo precedente, gli incentivi alla migrazione sono enormi e le migrazioni dei lavoratori rappresentano un grande problema.
Esamineremo ora le implicazioni dei movimenti di capitali e della circolazione dei lavoratori per la sopravvivenza dello stato sociale, ampliando così l’analisi cominciata nel capitolo 2.
4.3. La sopravvivenza dello stato sociale
L’esistenza della rendita di cittadinanza, e di conseguenza il fatto che la cittadinanza è un bene, deriva da tre vantaggi economici essenziali che offre a chi la possiede: (a) un insieme molto più ampio di opportunità economiche, che si riflette principalmente in salari più elevati e posti di lavoro più interessanti, (b) il diritto a importanti prestazioni sociali e (c) alcuni diritti di natura non economica legati alle istituzioni esistenti (per esempio, il diritto al giusto processo e alla non discriminazione). L’elemento (a) non è nuovo, anche se oggi ha assunto una maggiore rilevanza. Fin dagli albori della storia scritta, le comunità hanno offerto ai loro cittadini retribuzioni e opportunità diverse. Per esempio, Roma e Alessandria d’Egitto pullulavano di stranieri che vi erano confluiti alla ricerca di lavori più remunerativi e migliori prospettive di mobilità verso l’alto. Tuttavia, il divario tra le società ricche e quelle povere non è mai stato così profondo come lo è oggi. Anche l’elemento (c) non è nuovo: minacciato di flagellazione, l’apostolo cristiano Paolo rivendicò il proprio status di cittadino romano affermando «civis Romanus sum», condizione che in linea di principio avrebbe dovuto metterlo al riparo da tale trattamento, come in effetti avvenne.
Ma l’elemento (b) – vantaggi economici derivanti dall’esistenza dello stato sociale – è nuovo, perché lo stato sociale stesso è un concetto moderno. Poiché lo stato sociale è imperniato esplicitamente attorno all’idea di cittadinanza, in parte come modo per andare oltre il conflitto interno fra capitale e lavoro, è del tutto normale che la cittadinanza sia diventata il criterio essenziale per ricevere i trasferimenti sociali erogati dallo Stato. Lo Stato-nazione, lo stato sociale e la cittadinanza sono quindi legati indissolubilmente. Inoltre, lo stato sociale, soprattutto in Scandinavia, è stato costruito sulla premessa dell’omogeneità culturale e spesso etnica. Questa aveva due funzioni: garantiva che le norme di comportamento, essenziali per la sostenibilità dello stato sociale, sarebbero state le stesse nella maggior parte dei settori della popolazione, e sottolineava l’idea di unità nazionale smussando così gli spigoli del conflitto di classe.
In questa nostra era globalizzata, si è delineato un chiaro conflitto fra lo stato sociale, l’accesso al quale si basa sulla cittadinanza, e la libera circolazione dei lavoratori. Il fatto che esista uno stato sociale con prestazioni riservate ai soli cittadini, e quindi facenti parte della loro rendita di cittadinanza (in alcuni casi una parte sostanziale), non può che essere in tensione rispetto alla libera circolazione dei lavoratori. Se ai migranti viene concessa più o meno automaticamente la cittadinanza, ciò implica una diluizione della rendita percepita dagli attuali cittadini. Nel lungo periodo, l’esistenza dello stato sociale non è compatibile con una globalizzazione su vasta scala che includa la libera circolazione dei lavoratori. Come abbiamo visto, la rendita di cittadinanza scaturisce da una limitazione de facto della migrazione esercitata dagli attuali cittadini (analoga alla limitazione del commercio esercitata dal monopolista). Questa limitazione viene imposta per preservare l’elemento (a) della rendita (salari più elevati), ma anche l’elemento (b) delle prestazioni sociali. Trattandosi di un bene pubblico, dal punto di vista dei cittadini già residenti, l’elemento (c) è forse meno importante perché può essere condiviso con altri a costi relativamente contenuti.
Le grandi differenze tra le nazioni in tutti e tre gli elementi (a, b e c) portano a premi o penalità di cittadinanza elevati e, di conseguenza, a politiche più restrittive in materia di libera circolazione dei lavoratori. La divergenza dei redditi medi nei diversi paesi per la maggior parte del xx secolo (cioè quando i paesi ricchi crescevano, su base pro capite, più velocemente dei paesi poveri) e l’esistenza dello stato sociale sono entrambi responsabili di atteggiamenti molto meno tolleranti nei confronti della mobilità del lavoro nei paesi ospiti. Un premio di cittadinanza elevato e politiche anti-immigrazione sono due facce della stessa medaglia. L’uno non esiste senza le altre. Questo ci porta alla conclusione già discussa nel paragrafo 4.1: perché la globalizzazione del lavoro perda le sue connotazioni politiche, o si riducono i divari fra i redditi nazionali (con il recupero, da parte dei paesi più poveri, del ritardo rispetto a quelli ricchi), o gli stati sociali esistenti nel mondo ricco vengono seriamente ridotti o smantellati, o i migranti devono avere molti meno diritti dei nativi. Se consideriamo che la libera circolazione dei lavoratori è auspicabile perché aumenta il reddito globale e i redditi dei migranti, riducendo così la povertà nel mondo, dobbiamo concludere, seguendo lo stesso ragionamento, che uno dei maggiori ostacoli a questi sviluppi favorevoli è lo stato sociale nei paesi ricchi. Ma, per proseguire ulteriormente nel ragionamento, se è improbabile che lo stato sociale venga ridotto o smantellato, per via delle resistenze politiche che si andrebbero a creare – in quanto verrebbe meno la gran parte del progresso sociale realizzato dai cittadini e dai lavoratori dei paesi ricchi –, ci si orienta verso la proposta che limita i diritti economici dei migranti17.
I partiti di sinistra e lo stato sociale
Una delle conseguenze politiche dello stretto legame fra stato sociale e cittadinanza è la posizione antiglobalizzazione di alcuni partiti di sinistra (come La France Insoumise in Francia e i socialdemocratici in Danimarca, Austria, Paesi Bassi e Svezia). Questi partiti sono contrari sia ai deflussi di capitali (perché l’esternalizzazione e gli investimenti nei paesi più poveri distruggono posti di lavoro in quelli ricchi, anche se potrebbero crearne molti di più altrove) sia alle migrazioni. Questi partiti di sinistra, che hanno svolto un ruolo cruciale nella creazione dello stato sociale, si trovano così nella posizione apparentemente paradossale di essere al tempo stesso nazionalisti e anti-internazionalisti, rompendo con una lunga tradizione di socialismo internazionalista. Questo mutato atteggiamento deriva da un cambiamento intervenuto nelle condizioni economiche di base negli ultimi centocinquant’anni: un allontanamento dall’uniformità delle condizioni economiche tra i poveri, indipendentemente dalla nazione, e la costruzione di stati sociali complessi e completi nel mondo ricco. Il nuovo orientamento politico dei partiti di sinistra non è quindi casuale, bensì costituisce una risposta a tendenze di lungo periodo. I partiti di sinistra o socialdemocratici hanno un elettorato relativamente ben definito, composto da persone occupate nel settore industriale e pubblico, i cui posti di lavoro sono minacciati dalla libera circolazione dei capitali e dei lavoratori. Abbandonando di fatto la tradizione dell’internazionalismo, questi partiti sono diventati più simili, e politicamente più vicini, ai partiti di destra con cui spesso (come in Francia) condividono oggi lo spazio politico e gli elettori. Un residuo di internazionalismo è ancora visibile, tuttavia, nelle politiche antidiscriminatorie dei partiti di sinistra, i cui principali beneficiari sono i migranti già insediati nei paesi di accoglienza. Gli elettori di questi partiti assumono quindi un atteggiamento piuttosto schizofrenico: da una parte sostengono i diritti dei migranti che sono riusciti a entrare nel paese, ma al tempo stesso sono contrari a che ne arrivino di nuovi, così come si oppongono al deflusso di ulteriori capitali finalizzati alla creazione di posti di lavoro destinati a persone più povere di loro.
Mancanza di pari opportunità nel mondo
Concludo questo paragrafo con un problema più filosofico che sta alla base del dibattito sulle migrazioni. L’esistenza della rendita di cittadinanza implica un’evidente mancanza di pari opportunità su scala globale: due individui identici, uno nato in un paese povero e uno in un paese ricco, avranno diritto a flussi di reddito molto disuguali nel corso della loro vita. Si tratta di un fatto ovvio, ma le sue implicazioni non sono state del tutto sviscerate. Se contrapponiamo la situazione di questi due individui nati in due paesi diversi con due individui identici nati da genitori poveri o ricchi nello stesso paese, notiamo che in quest’ultimo caso si nutrirebbe qualche preoccupazione per il divario di opportunità nella convinzione, spesso condivisa dalla maggior parte dei cittadini del paese, che tali disuguaglianze di partenza dovrebbero essere livellate. Nel primo caso non sembrano invece sussistere remore di questo tipo. Il lavoro di John Rawls fornisce un esempio perfetto di questa discrepanza, o incongruenza. Nel suo libro Una teoria della giustizia, egli attribuisce la massima importanza alle disuguaglianze all’interno della nazione e sostiene che le disparità fra persone nate da genitori ricchi e poveri debbano essere ridotte o eliminate. Ma quando passa alla riflessione in ambito internazionale, nel Diritto dei popoli ignora del tutto le disuguaglianze fra persone nate nei paesi ricchi o in quelli poveri, a differenza di quanto espresso da Josiah Stamp (1926) quasi un secolo fa: «Sebbene ci possiamo concentrare sull’eredità individuale, essa non può essere completamente dissociata dagli aspetti della comunità. Quando viene al mondo, una persona deve, in quanto unità economica, rapportarsi a due tipi di aiuto, ossia ciò che eredita individualmente dai propri genitori, e ciò che eredita socialmente dalla società precedente, e in entrambi è presente il principio dell’eredità individuale».
Il divario globale di opportunità non è generalmente considerato un problema, tanto meno un problema che necessiti di una soluzione. All’interno degli Stati-nazione, molte persone ritengono discutibile la trasmissione intergenerazionale della ricchezza acquisita dalla famiglia; ma tra le nazioni, la trasmissione intergenerazionale della ricchezza acquisita collettivamente non è considerata motivo di preoccupazione. La cosa è interessante, perché i legami degli individui con la loro famiglia sono più stretti di quelli con un’intera comunità, e si tenderebbe a pensare che la trasmissione del patrimonio familiare attraverso le generazioni potrebbe essere considerata meno discutibile della trasmissione del patrimonio sociale attraverso generazioni di individui non imparentati. Il fatto che non lo sia sembra risiedere in una differenza essenziale, vale a dire che nel primo caso, in cui la trasmissione intergenerazionale della ricchezza avviene all’interno della stessa comunità, gli individui possono facilmente confrontare le rispettive posizioni e si risentono di fronte all’ingiustizia; nell’altro, la disuguaglianza è internazionale, e gli individui non hanno la possibilità di confrontarsi facilmente o forse non si preoccupano di farlo (o almeno i ricchi non lo fanno). La distanza, come osservava Aristotele, rende spesso le persone indifferenti alla sorte degli altri, forse perché non li vedono come loro pari con cui confrontare il reddito o la ricchezza18. L’appartenenza formale a una comunità (cittadinanza) è la chiave per spiegare queste differenze. La questione di base è stata definita con la massima chiarezza da Adam Smith nella Teoria dei sentimenti morali: «Nella grande società umana, perciò, la prosperità della Francia [per via del maggior numero di abitanti] dovrebbe sembrare un obiettivo molto più importante di quella della Gran Bretagna. Tuttavia, un britannico che non preferisse in ogni situazione la prosperità della Gran Bretagna a quella della Francia non sarebbe ritenuto un buon cittadino» (parte VI, cap. 2).
Con la nostra lunga consuetudine di «nazionalismo metodologico», in cui studiamo essenzialmente alcuni fenomeni all’interno dei confini di una nazione, siamo portati alla posizione per cui le pari opportunità sembrano doversi applicare, ed essere studiate, solo all’interno dello Stato nazionale. Il divario globale di opportunità viene dimenticato o ignorato. Questa, filosoficamente e nella pratica, può essere stata una posizione ragionevole in passato, quando la conoscenza delle differenze tra le nazioni era vaga e del divario di opportunità non si parlava nemmeno in patria. Ma potrebbe non essere una posizione ragionevole ora. I cosmopoliti e gli statalisti avranno senza dubbio opinioni diverse su tale questione, ma dobbiamo metterla sul tavolo anche in termini economici e discuterne in relazione alle migrazioni, che sono la sua manifestazione più visibile.
4.4. La corruzione nel mondo
A mio avviso, in generale, nella maggior parte dei paesi si percepisce una corruzione più grave rispetto a trent’anni fa19. Tuttavia, se misuriamo la corruzione in base al numero di casi di cui si è venuti a conoscenza, questa impressione potrebbe rivelarsi fuorviante. Può darsi che ad aumentare sia la capacità di controllare la corruzione e punire i criminali, e non la corruzione in quanto tale. Oppure, in alternativa, la nostra percezione di un fenomeno in aumento a livello globale potrebbe essere determinata dal fatto che oggi, molto più che in passato, disponiamo di informazioni sulla corruzione non solo locale, ma anche nelle altre parti del mondo. Nessuna delle due possibilità può essere facilmente esclusa. Per quanto riguarda la prima, non disponiamo di dati affidabili nel tempo sull’applicazione della legge e, anche se ne avessimo, un aumento del numero di casi di corruzione perseguiti non potrebbe dirci nulla sull’entità della corruzione o sul rigore con cui si applicano le norme. Questo perché l’entità della corruzione (il denominatore che vogliamo avere nel giudicare se l’applicazione delle norme sia migliorata oppure no) è per definizione sconosciuta. Conosciamo solo i casi di corruzione che arrivano in tribunale, non la vera portata del fenomeno.
A questa mancanza di conoscenza si può porre rimedio in qualche misura attraverso indicatori basati su indagini che chiedono il parere di vari esperti sulla diffusione della corruzione, come il Corruption Perceptions Index elaborato da Transparency International e i Worldwide Governance Indicators della Banca mondiale. Non si tratta di indagini sulla corruzione in quanto tale, ma piuttosto su come il fenomeno viene percepito20. Queste, però, sono cominciate solo a metà degli anni Novanta, quando la globalizzazione era già in pieno svolgimento. Cosa ancora più importante, tali indicatori consentono solo confronti relativi (la Russia è stata più corrotta della Danimarca in un determinato anno?), e non l’evoluzione della corruzione nel tempo (la Russia è più corrotta nel 2018 rispetto al 2010?) né confronti cardinali (rispetto alla Danimarca, la Russia è più corrotta quest’anno di quanto non fosse l’anno scorso?). Questo perché gli indicatori classificano semplicemente i paesi anno per anno, ma non confrontano i valori da un anno all’altro. Non possiamo nemmeno dire molto sul fatto che le percezioni delle persone stesse possano o meno essere influenzate dal maggior numero di casi di corruzione denunciati, da mezzi di comunicazione più aperti e da una conoscenza più approfondita della corruzione al di fuori delle loro cerchie ristrette.
Per maggiori informazioni, possiamo fare riferimento alle recenti stime sull’ammontare dei fondi che prendono il largo verso i paradisi fiscali. Il ricorso a questi rifugi non è un chiaro indicatore di corruzione, ma un collegamento c’è. Naturalmente, il denaro ricavato dalla corruzione non deve stare necessariamente nei paradisi fiscali; può essere «convertito» in attività legittime o, per esempio, essere utilizzato per acquistare proprietà immobiliari a Londra o a New York. Pertanto, limitandosi a valutare l’entità dei soli paradisi fiscali si potrebbe sottostimare la corruzione, ma anche sopravvalutarla, poiché chi fa confluire nei paradisi fiscali il denaro guadagnato legalmente può anche agire al solo scopo di sottrarlo all’imposizione fiscale. In entrambi i casi, tuttavia, la gran parte del denaro depositato nei paradisi fiscali è di provenienza illegale in quanto corrotto o in origine o nelle intenzioni (evadere il fisco)21. Utilizzando i dati sulle anomalie delle posizioni patrimoniali in vari paesi, Gabriel Zucman (2013, p. 1322) ha stimato che nel 2008 circa 5900 miliardi di dollari – ossia l’8 per cento della ricchezza finanziaria globale delle famiglie, equivalente al 10 per cento del Pil globale – si trovavano in paradisi fiscali (tre quarti dei quali non registrati). La cifra è rimasta stabile dal 2000, anno delle prime stime di Zucman, fino al 201522. Per definizione, include solo la ricchezza finanziaria e non tiene conto delle molte altre forme (beni immobili, gioielli, opere d’arte) che può assumere il denaro rubato oppure anche quello acquisito legalmente, ma sottratto alla tassazione.
Un altro modo per valutare la corruzione è quello di considerare a livello globale errori e omissioni, una particolare voce della bilancia dei pagamenti di ciascun paese che riflette in parte errori reali e in parte la fuga di capitali che può essere correlata ad attività di corruzione interna come la sottofatturazione delle esportazioni o la sovrafatturazione delle importazioni (così da tenere all’estero la differenza risultante), e altre transazioni illecite. I dati del Fondo monetario internazionale mostrano che il valore globale netto di errori e omissioni, che prima della crisi finanziaria globale del 2008 non era mai andato oltre i 100 miliardi di dollari annui, ha invece superato una media di 200 miliardi di dollari all’anno nel quinquennio per il quale vi sono dati disponibili23.
Un altro approccio alla quantificazione della corruzione – o, più esattamente, alla quantificazione di un dato indiretto per la ricchezza acquisita attraverso le aderenze politiche – è quello adottato da Caroline Freund nel suo pionieristico libro Rich People Poor Countries: The Rise of Emerging-Market Tycoons and Their Mega Firms (2016). Freund ha classificato miliardari di tutto il mondo a seconda che la fonte principale della loro ricchezza sia frutto di un’attività individuale oppure di un’eredità. All’interno della prima categoria, Freund ha isolato un gruppo di miliardari la cui ricchezza deriva da risorse naturali, privatizzazioni o altri rapporti con il governo24. La figura 4.2 mostra la percentuale di miliardari (non la percentuale della loro ricchezza totale) stimata come rientrante in quel gruppo. Nelle economie avanzate, la quota è di circa il 4 per cento (con un aumento per i paesi anglosassoni e l’Europa occidentale tra il 2001 e il 2014). Nelle economie di mercato emergenti, la quota è compresa tra il 10 e il 20 per cento, con l’eccezione di una quota straordinariamente elevata nel gruppo composto da Europa dell’Est, Russia e Asia centrale, guidato da miliardari provenienti dalle repubbliche dell’ex Unione Sovietica. Tranne che in quest’ultima regione (che può essere considerata di gran lunga la più corrotta) e in America Latina, la percentuale di miliardari che devono la loro ricchezza alle aderenze politiche è in crescita in tutte le regioni. L’aumento è particolarmente significativo nell’Africa subsahariana e nell’Asia meridionale (soprattutto a causa dell’India). La quota mondiale della ricchezza totale dei miliardari, che si stima sia stata acquisita attraverso agganci con il governo, è aumentata dal 3,8 per cento nel 2001 al 10,2 per cento nel 2014, con, prevedibilmente, la quota più alta in Est Europa, Russia e Asia centrale (73 per cento), Medio Oriente e Nord Africa (22 per cento) e America Latina (15 per cento)25.
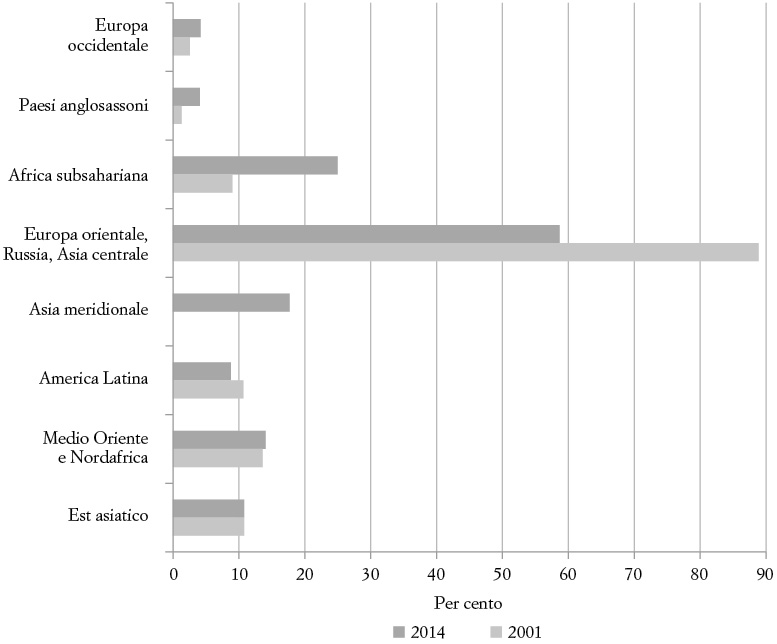
Figura 4.2. Percentuale di miliardari la cui
ricchezza è stimata come derivante da risorse naturali,
privatizzazioni o altri legami con il governo, 2001 e 2014.
I paesi anglosassoni sono l’Australia, il Canada, la Nuova Zelanda
e gli Stati Uniti. L’Est asiatico sviluppato è stato omesso in
quanto il valore in entrambi gli anni è pari a zero.
Fonte: Dati tratti da
Freund (2016, tabella 2.4, pp. 37-38).
4.4a. Tre motivi di corruzione nell’era della globalizzazione
Malgrado l’impossibilità di misurare direttamente la corruzione e la necessità di affidarsi a dati indiretti, esistono solide basi teoriche per ritenere che la corruzione a livello mondiale sia maggiore ora di quanto non fosse venti o trent’anni fa, e che probabilmente continuerà ad aumentare. I motivi, a mio modo di vedere, sono almeno tre: (a) il capitalismo ipercommercializzato e globalizzato, che misura il successo nella vita solo ed esclusivamente in funzione del successo economico (argomento che analizzeremo in maggiore dettaglio nel capitolo 5); (b) l’apertura dei conti capitale, che facilita il trasferimento del denaro tra le giurisdizioni e il riciclaggio di quest’ultimo quando si tratti di somme rubate o di evadere il fisco; e (c) l’effetto dimostrativo della globalizzazione, per cui le persone (specie i burocrati) nei paesi a medio reddito e in quelli poveri ritengono di meritare i livelli di consumo alla portata delle persone che detengono posizioni simili nei paesi ricchi, un livello che essi, con le loro misere retribuzioni ufficiali, possono raggiungere solo se arrotondano con le tangenti. Il punto (a) è fondamentalmente ideologico e generale (vale a dire, si applica ovunque nel mondo e in linea di principio a tutti); il punto (c) è più ristretto e si applica solo a gruppi selezionati di persone; e il punto (b) è una condizione necessaria, un fattore che facilita la corruzione mondiale.
Vado ad analizzare brevemente questi punti uno per uno.
Limiti alla corruzione dei paesi non integrati nell’economia mondiale capitalista
Do qui per scontato un argomento che elaboro più diffusamente nel capitolo 5: l’iperglobalizzazione richiede come sovrastruttura intellettuale un’ideologia che giustifichi il fare soldi (in qualsiasi modo) e in cui il successo economico sia preponderante rispetto a tutti gli altri obiettivi, con il risultato di creare una società sostanzialmente amorale. L’amoralità implica che la società e gli individui sono indifferenti riguardo al modo in cui la ricchezza viene acquisita fintanto che si fanno le cose sull’orlo della legalità (anche se non in maniera etica), oppure oltre la legalità ma senza essere scoperti, o in un modo che è illegale in una giurisdizione ma che può essere presentato come legale in un’altra. In queste condizioni, ne consegue direttamente che vi saranno forti incentivi ad adottare comportamenti corrotti26. L’obiettivo sarà quello di praticare una corruzione «ottimale» o «intelligente» che può essere eticamente inaccettabile, ma che è difficile da individuare o addirittura da classificare come tale. Anche se queste attività fossero considerate corrotte dai più, ciò non significa che sarebbero legalmente classificate come tali e perseguite dalle autorità, come per esempio negli Stati Uniti, dove il lobbismo è sempre in bilico fra legalità e illegalità27. La corruzione viene inoltre favorita dalla creazione di un imponente apparato di avvocati il cui scopo è quello di consigliare ai clienti come raggiungere al meglio i loro obiettivi in materia di corruzione senza infrangere apertamente la legge, oppure violandola in modo minimo. A Londra, per esempio, è attivo un settore legale che si è adoperato abilmente per consentire a individui corrotti provenienti da Russia, Cina, Nigeria e molti altri paesi di riciclare il loro denaro in Inghilterra o di utilizzare Londra come centro di smistamento per riciclarlo altrove.
La diffusione della globalizzazione in tutte le parti del mondo ha avuto un ruolo decisivo nel facilitare la corruzione. Nei suoi libri essenziali sulla corruzione in Cina, Minxin Pei spiega come mai il fenomeno fosse pressoché inesistente nella Cina maoista (Pei 2006, pp. 147-148) e individua diverse ragioni: la capacità delle persone di monitorare i modelli di spesa dei funzionari locali, che vivevano vicini ai loro elettori ed erano esposti a periodiche epurazioni (se sospettati di corruzione28 o slealtà); la povertà e la mancanza di merci attraenti che limitavano fortemente ciò che i funzionari corrotti potevano acquistare con il loro denaro; e l’isolamento della Cina dal resto del mondo, che rendeva impossibile ai funzionari il trasferimento del denaro all’estero. L’ultimo elemento era probabilmente il più decisivo.
Il modo in cui un diverso sistema economico così come l’autarchia o l’isolamento dal capitalismo hanno limitato la corruzione è effettivamente più visibile nel caso dei paesi comunisti. La maggior parte delle transazioni monetarie in questi paesi avveniva tra aziende statali e non sfiorava minimamente i flussi di denaro delle famiglie. Tali somme aziendali erano spesso solo unità contabili che circolavano all’interno dell’impresa e non potevano essere utilizzate per gli acquisti delle famiglie. Forse il modo più semplice per farsene un’idea è immaginare una situazione in cui tutte le transazioni commerciali tra aziende vengono condotte in una moneta elettronica che non può essere utilizzata per pagare i salari o per i beni acquistati privatamente29. Un’azienda produttrice di arredi può vendere mobili in cambio di moneta elettronica solo a un’altra azienda statale. Ora, il dirigente di quest’ultima azienda potrebbe rubare fisicamente i mobili consegnati. Sarebbe però una cosa non soltanto difficile (i mobili sarebbero registrati nei libri contabili) ma anche evidente e goffa. In altre parole, ci sarebbe solo una minima possibilità che i beni acquistati attraverso il denaro aziendale possano finire illegalmente nelle mani di singoli individui.
Vantaggi speciali e premi ricevuti da alti funzionari statali e di partito o dirigenti d’azienda erano quasi sempre in natura: l’uso di auto di proprietà dello Stato, o l’accesso a merci esclusive o appartamenti più grandi. Non erano vantaggi che si potessero monetizzare, mettere da parte o trasmettere alla generazione successiva. Inoltre, potevano essere revocati in qualsiasi momento, per esempio quando il funzionario in questione perdeva il posto di lavoro a cui determinati privilegi erano associati. Erano infatti prerogative strettamente di diritto che non venivano concesse a caso, bensì per garantire l’obbedienza, proprio perché potevano essere ritirate così facilmente. Un privilegio che può essere monetizzato, trasmesso ai propri eredi, o inalienabile in generale, crea una sfera di indipendenza per l’individuo. La concessione di tale indipendenza è incompatibile con i regimi autoritari o totalitari. Ma c’è di buono che questa mancanza di indipendenza ha limitato la corruzione.
Un altro fattore importante che limitava la corruzione è stato la mancanza di una piena integrazione nell’economia internazionale (capitalistica). Ciò valeva anche per i paesi capitalisti ricchi, in molti dei quali – negli anni Sessanta e Settanta – vigevano controlli valutari finalizzati a limitare la quantità di denaro contante che si poteva portare all’estero, sia in vacanza sia nei viaggi d’affari30. I vincoli erano ancora maggiori nei paesi in via di sviluppo con valute non convertibili, e la massima severità era quella applicata nei paesi socialisti o pseudosocialisti (come l’Unione Sovietica, i paesi dell’Europa dell’Est, la Cina, l’India, l’Algeria, il Vietnam e la Tanzania) che non erano integrati nell’economia mondiale. Anche se i funzionari fossero riusciti in qualche modo a procurarsi del denaro (e ammesso e non concesso che ce la facessero a convertirlo in valuta estera), non avrebbero saputo come trasferirlo all’estero. Affidarsi all’aiuto di altri, capaci di condurre operazioni del genere, avrebbe esposto un funzionario all’accusa non solo di corruzione ma anche di tradimento, poiché la maggior parte di coloro che conoscevano il funzionamento delle economie capitaliste e sapevano come investire erano in genere persone emigrate dai paesi comunisti e quindi considerate nemici del popolo.
Ricordo un caso della metà degli anni Ottanta, quando i regimi comunisti in Europa erano già in fase di disintegrazione, il controllo dei partiti si stava notevolmente indebolendo e l’idea di funzionari che rubavano denaro e lo nascondevano all’estero cominciava a essere vista come una possibilità, anche se penso che all’epoca non fosse quasi mai una realtà. (Lo sarebbe poi diventata con il crollo dei regimi comunisti e la privatizzazione dei beni di proprietà dello Stato.) Correva voce che il primo ministro iugoslavo avesse comprato un appartamento a Parigi. Parlandone con i miei amici, avevo sostenuto che ben difficilmente poteva essere vero. Innanzitutto – osservai –, era difficile capire dove si fosse procurato così tanti soldi in valuta estera senza essere notato dalla polizia segreta. Forse, nella sua ascesa ai vertici, aveva aiutato un’azienda straniera a ottenere un contratto particolarmente vantaggioso, forse l’unica attività con cui poteva sperare di «guadagnare» una notevole quantità di denaro. Ma già allora non era chiaro come potesse essere stato pagato per questo «servizio». Possedere conti all’estero era illegale, e aprire un conto, a nome proprio o di un parente, era una mossa estremamente pericolosa che, se scoperta, avrebbe posto fine alla sua carriera ben prima che diventasse primo ministro. L’apertura di un conto estero in seguito, quando ormai occupava una posizione di preminenza, sarebbe stata altrettanto pericolosa e difficile. Quando andavano in visita all’estero, i funzionari di così alto rango non venivano mai lasciati soli. Era inconcepibile che il primo ministro potesse entrare nella filiale di una banca a Parigi e aprire un conto corrente. (Ma a prescindere da questo, in quegli anni in cui esistevano controlli sui capitali anche nelle principali economie di mercato, gli sarebbe stato difficile fare una cosa del genere, dal momento che non sarebbe stato in grado di fornire un indirizzo locale né un documento d’identità.) Anche incaricare qualcun altro di provvedere al posto suo sarebbe stato pericoloso, in quanto lo avrebbe esposto a possibili ricatti ma anche al pericolo di cadere in disgrazia politicamente se tale attività fosse giunta all’attenzione degli «organi competenti». Infine, proseguendo nella mia argomentazione, osservai che se pure avesse in qualche modo aggirato tutti questi ostacoli, non riuscivo proprio a immaginare in che modo avrebbe potuto tecnicamente acquistare un immobile all’estero, dato che di sicuro non sapeva nulla su dove ottenere informazioni circa gli appartamenti in vendita, i prezzi, o come sbrigare le necessarie pratiche legali. (E di certo non avrebbe potuto affidarsi a un avvocato del posto.) Si noti come anche i funzionari dei paesi non comunisti che non erano parte integrante del mondo capitalista (India, Turchia) spesso non avevano conoscenze e contatti per trasferire denaro all’estero.
L’impossibilità di fare qualcosa di significativo con il denaro guadagnato illegalmente rendeva certo meno attraente la prospettiva di un coinvolgimento in attività corrotte. Quindi non solo le opportunità di fare soldi attraverso la corruzione erano minori nei paesi meno «integrati», ma – cosa forse altrettanto importante –, la possibilità di utilizzare il denaro ottenuto illegalmente per procurarsi cose desiderabili era molto più limitata. Non è chiaro che cosa dei funzionari corrotti di un paese non integrato avrebbero potuto fare con questi soldi. Abbiamo visto che non sarebbero stati in grado di acquistare un appartamento all’estero, e nemmeno di trasferire denaro oltre frontiera. Di certo non potevano sognare nemmeno lontanamente di ritirarsi in Costa Azzurra né di utilizzare questi fondi neri per far studiare i figli all’estero. Anche quest’ultima ipotesi non era praticabile, perché mandare i figli a studiare nei paesi capitalisti era ritenuto un tradimento del socialismo e dell’educazione socialista. Qualsiasi funzionario di un paese comunista i cui figli fossero andati a studiare negli Stati Uniti (a parte nel caso di un incarico ufficiale all’estero) sarebbe stato immediatamente retrocesso e indagato sull’origine dei fondi. In altre parole, avrebbe dovuto essere disposto ad andare in prigione. Non sorprende quindi che gli unici a poter prendere anche solo lontanamente in considerazione di mandare i figli a studiare in un altro paese fossero gli imprenditori privati (che dovevano essere sufficientemente ricchi), o le persone in qualche modo indipendenti dal potere politico (per esempio, medici o ingegneri) con dei parenti all’estero.
Questa differenza tra i paesi che erano integrati nel sistema capitalistico e quelli che non lo erano (così come tra i milionari e le persone «normali») mi ha molto colpito quando ho letto un articolo autobiografico di José Piñera, figlio di uno degli uomini più ricchi del Cile, divenuto poi ministro del Lavoro e della Previdenza sociale sotto Augusto Pinochet31. Piñera menzionava con una certa nonchalance di aver frequentato Harvard. Avevo trovato questa disinvoltura – la stessa che ho avuto modo di osservare in molti ricchi, specie latinoamericani – davvero straordinaria. Trascurando per un momento l’aspetto di come chi non sia figlio di una persona molto ricca possa riuscire a entrare in una delle scuole secondarie d’élite (le cosiddette prep schools) che fungono da vivaio per i giovani più promettenti destinati alle migliori università, praticare sport costosi, o trovare il tempo per svolgere le attività insolite (paracadutismo, suonare in un’orchestra) utili ad acquisire i titoli richiesti per entrare a Harvard o in un’università di pari livello, resta comunque il fatto che il denaro necessario per pagare le tasse scolastiche e affrontare le spese di tutti i giorni è talmente tanto che nessun cittadino di un paese non anglofono con un livello di reddito medio e una disuguaglianza moderata, e senza moneta convertibile, potrebbe nemmeno accarezzare l’idea di studiare a Harvard. Naturalmente, mi riferisco qui alla situazione degli anni Sessanta e Settanta (quando Piñera ha studiato all’estero).
In un mondo non integrato – che in seguito, dopo la sua integrazione, avrebbe prodotto attraverso la Russia e la Cina la maggior parte della corruzione internazionale – il fenomeno era quindi limitato in modo sistemico.
Facilitatori della corruzione mondiale nei paesi riceventi
Il secondo motivo per cui si ritiene che la corruzione sia in aumento è legato al quadro generale. L’ho già accennato evidenziando come i controlli valutari – che erano comuni in tutto il mondo, comprese le economie avanzate –, e le valute non convertibili limitassero la possibilità di trasferire denaro all’estero. Inoltre, non esisteva un quadro di riferimento per consentire la corruzione in paesi che potenzialmente potevano ricevere denaro.
La crescita delle banche specializzate in soggetti ad alto potenziale di investimento e degli uffici legali il cui ruolo è essenzialmente quello di facilitare i trasferimenti di denaro acquisito illegalmente è avvenuta in concomitanza con la globalizzazione. Maggiori opportunità di corruzione – o, in questo caso, una maggiore «offerta» di parti interessate a nascondere o investire il proprio denaro all’estero – hanno comportato una maggiore «domanda» di tali fondi, come dimostra la creazione di nuove figure professionali la cui occupazione è quella di contribuire a trovare una nuova collocazione al denaro acquisito illegalmente. Non è quindi un caso che l’offerta e la domanda siano aumentate di pari passo e che la crescita del settore bancario e di quello legale che rendono possibile tutto questo sia stata stimolata dalla fuga di capitali dalla Russia e dalla Cina. Secondo Novokmet, Piketty e Zucman (2017), circa la metà dei capitali russi sono detenuti all’estero, per gentile concessione di facilitatori stranieri, e gran parte di essi viene utilizzata per investire in azioni di società russe. Questo dato evidenzia uno dei nuovi aspetti della globalizzazione, in cui il capitale nazionale viene tenuto all’estero per beneficiare di un’imposizione fiscale più leggera e di una maggiore tutela della proprietà, ma viene poi impiegato nel paese di origine sotto forma di investimento estero per beneficiare delle migliori condizioni offerte agli investitori stranieri e anche per sfruttare gli agganci locali e i vantaggi legati alla conoscenza del territorio, fra cui la lingua, i costumi, chi corrompere e come. Il caso russo è solo un esempio estremo di questo fenomeno generale; un altro esempio è che circa il 40 per cento degli investimenti esteri indiani proviene da Mauritius (il principale investitore in India!) e da Singapore32. Questi, naturalmente, non sono nient’altro che fondi indiani camuffati, molti dei quali acquisiti illegalmente a livello nazionale e poi trasferiti all’estero, da dove ritornano in India in qualità di «investimenti esteri»; una cosa che sarebbe stata difficile da immaginare nell’India degli anni Settanta così come nell’Unione Sovietica della stessa epoca, ma che è diventata una tecnica se vogliamo anche un po’ banale nell’era della globalizzazione.
Qui occorre considerare con maggiore attenzione il ruolo svolto dai centri finanziari globali e dai paradisi fiscali. Questi ultimi – in particolare Svizzera e Lussemburgo – sono stati analizzati nel dettaglio da Gabriel Zucman nel suo libro La ricchezza nascosta delle nazioni (2017). Il ruolo dei paradisi fiscali è stato anche ampiamente documentato dalla pubblicazione dei Panama Papers e dei Paradise Papers, e nel libro di Brooke Harrington Capital without Borders (2016). Ma il ruolo dei grandi centri finanziari come Londra, New York e Singapore ha suscitato minore attenzione. Senza la creazione di un sistema articolato di servizi bancari e legali che si mettano al suo servizio e la favoriscano, la corruzione su scala globale non sarebbe stata possibile. Il furto interno di denaro ha senso solo se i fondi possono essere riciclati a livello internazionale, e ciò richiede il sostegno dei grandi centri finanziari globali. Questi ultimi si sono quindi adoperati direttamente contro la creazione, o il rafforzamento, dello Stato di diritto in Russia, Cina, Ucraina, Angola, Nigeria e altrove, per la semplice ragione che sono i principali beneficiari dell’illegalità di tali nazioni, a cui garantiscono un rifugio sicuro per tutti i beni rubati. Ironia della sorte, paesi caratterizzati da un solido Stato di diritto (e, naturalmente, in cui si chiude un occhio su come il denaro straniero sia stato acquisito) hanno svolto un ruolo chiave nel favorire la corruzione a livello mondiale dimostrandosi determinanti per riciclare le somme sottratte illegalmente a tassi molto più elevati rispetto a quelli di qualsiasi attività tradizionale di riciclaggio (come l’apertura di un ristorante o di una sala cinematografica in perdita).
Accanto a quell’apparato di banche e studi legali, operano università, think tank, Ong, gallerie d’arte e altre nobili cause. Mentre le banche agiscono sul fronte del riciclaggio di denaro vero e proprio, queste organizzazioni offrono quello che potremmo definire riciclaggio «morale». Lo fanno fornendo rifugi sicuri dove gli individui corrotti, donando una piccola parte dei loro beni rubati, possono presentarsi nella veste di imprenditori socialmente responsabili, instaurare contatti importanti, e introdursi negli ambienti più esclusivi dei paesi in cui hanno trasferito il loro denaro33. Un esempio significativo è quello dell’uomo d’affari russo Michail Chodorkovskij, che, grazie ai propri agganci politici in Russia, ha acquistato beni per una frazione del loro valore – a quanto pare si è appropriato indebitamente di circa 4,4 miliardi di dollari di denaro pubblico – e poi ha distrutto le prove affondandole in un fiume a bordo del camion che le trasportava34. Chodorkovskij e altri come lui sono ora ricomparsi in Occidente in veste di «donatori responsabili». Chodorkovskij merita una menzione speciale perché è stato un innovatore nell’arte del riciclaggio morale. Già all’inizio del xxi secolo aveva capito che per agevolare i propri affari in tutto il mondo e in Russia, l’investimento più redditizio che potesse fare sarebbe stato quello di offrire contributi alle campagne elettorali dei politici americani e donazioni ai think tank di Washington. Da allora, questo approccio si è diffuso sempre di più.
Anche se per Chodorkovskij la cosa non ha funzionato (è stato arrestato e incarcerato da Putin), nell’era della globalizzazione, dove molte grandi decisioni si prendono in centri politici come Washington o Bruxelles, questa strategia è probabilmente quella giusta nel lungo periodo. Altre imprese straniere, non ultime quelle saudite, hanno adottato lo stesso approccio. Alcuni oligarchi – per esempio, Leonid Blavatnik, che ha fatto fortuna durante gli anni della privatizzazione nella Russia del «Selvaggio Est» degli anni Novanta – pensavano che investire in una business school o in una galleria d’arte che portasse il loro nome fosse un’idea migliore che non dare contributi alle campagne elettorali come mezzo di riciclaggio morale35. In una comunicazione privata, un amministratore di un’università indiana mi ha detto che è molto difficile ottenere donazioni da parte dei super-ricchi indiani, che invece elargiscono decine di milioni di dollari alle università della Ivy League. Questo avviene, ha affermato, perché vogliono sembrare buoni cittadini negli Stati Uniti quando i legislatori cominciano a porre domande scomode sul numero di lavoratori indiani muniti di visto che impiegano nelle loro aziende anziché assumere degli americani. Non otterrebbero un beneficio paragonabile se destinassero le loro donazioni a un’università indiana.
Imitazione del modello di consumo dei paesi ricchi
La terza ragione dell’aumento della corruzione nell’era della globalizzazione è l’effetto dimostrativo, altrimenti noto come «non voler essere da meno dei vicini». Ora, l’effetto dimostrativo non è un fenomeno nuovo. Gli strutturalisti dell’America Latina sostengono fin dagli anni Sessanta che uno dei motivi per cui la propensione al risparmio nei paesi latinoamericani è bassa è che i ricchi non sono disposti a fare economia per paura di rimanere indietro, dal punto di vista del modello di consumo, rispetto ai loro omologhi nordamericani (più ricchi). Thorstein Veblen ha fatto un’osservazione simile nei propri scritti sul cospicuo consumo di beni di lusso, sottolineando che il consumismo ha deviato i fondi da usi più produttivi, ma che lo spreco stesso era l’obiettivo che veniva perseguito36. Molto tempo prima, Machiavelli aveva elaborato la stessa idea, su come i rapporti con i vicini più ricchi stimolino la corruzione:
La quale bontà è tanto più da ammirare in questi tempi, quanto ella è più rada: anzi si vede essere rimasa solo in quella provincia [la Germania Magna]. Il che nasce da dua cose: l’una, non avere avute conversazioni grandi con i vicini; perché né quelli sono iti a casa loro, né essi sono iti a casa altrui, perché sono stati contenti di quelli beni, vivere di quelli cibi, vestire di quelle lane, che dà il paese; d’onde è stata tolta via la cagione d’ogni conversazione, ed il principio d’ogni corruttela; perché non hanno possuto pigliare i costumi, né franciosi, né spagnuoli, né italiani; le quali nazioni tutte insieme sono la corruttela del mondo (2001, libro I, cap. 55, pp. 135-136).
Il contributo degli strutturalisti è stato quello di vedere l’imitazione dei modelli di consumo dei ricchi attraversare i confini nazionali. In questo senso, sono stati i precursori dell’effetto dimostrativo durante la globalizzazione. Ma oggi, a mio avviso, l’effetto dimostrativo non solo alimenta un maggiore consumo, ma motiva anche la corruzione, ovvero, in altre parole, suscita la necessità di un reddito più elevato a prescindere dalla sua legalità.
Un aspetto importante della globalizzazione è che le persone hanno una conoscenza molto più dettagliata rispetto al passato degli stili di vita in luoghi lontani. Un altro è la maggiore frequenza di interazioni e collaborazioni di lavoro con persone di paesi diversi. Quando individui con livelli di istruzione e capacità simili lavorano insieme, ma provengono da paesi diversi e, a parità di competenze, percepiscono redditi differenti, il risultato – che si parli di invidia, di gelosia, di giusto compenso o di un motivato risentimento di fronte alle disuguaglianze la sostanza non cambia – è che le persone dei paesi poveri, non a torto, si sentono ingannate e pensano di meritare lo stesso reddito. Questa presa di coscienza è particolarmente forte là dove le persone lavorano a stretto contatto e sono in grado di valutare direttamente le competenze e anche i diversi livelli a cui vengono retribuite. Questo aspetto è particolarmente ovvio nel caso di funzionari statali di paesi poveri o a medio reddito, che spesso sono malpagati e tuttavia, nell’esercizio delle loro varie funzioni ministeriali (sviluppo, finanze, energia, ecc.), interagiscono con ricchi imprenditori e burocrati stranieri37.
Quella che gli individui dei paesi più poveri percepiscono come un’ingiustizia fornisce loro una giustificazione interiore al fatto di accettare tangenti, che vengono viste solo ed esclusivamente come compensazione di fronte a un salario ingiustamente basso, o anche all’iniqua sorte di essere nati in un paese povero e di doverci lavorare. Accettare con rassegnazione le grandi differenze di reddito è davvero molto difficile per chi, pagato solo qualche centinaio di dollari al mese, deve prendere decisioni su contratti del valore di decine o centinaia di milioni di dollari e interagire con persone che ne guadagnano diverse migliaia al giorno. Non c’è nulla di strano che in una situazione del genere la corruzione sia vista come un modo per livellare le ingiustizie della vita. (Qualcuno potrebbe obiettare che i funzionari pubblici dovrebbero confrontarsi con chi, nel loro paese, è molto più povero di loro. Ma non è realistico: tendiamo tutti a confrontare la nostra posizione con quella dei nostri pari, e in questo caso gli omologhi – con cui spesso interagiscono – sono stranieri.)
Il fatto, a parità di lavoro, di avere le retribuzioni così diverse (con le conseguenze che questo produce sulla corruzione) sussiste anche nel caso di cittadini nativi dei paesi più poveri che lavorano in patria per le organizzazioni internazionali. Che assumano cariche governative (sovvenzionate da donatori stranieri) o lavorino in università, think tank o Ong, i loro stipendi superano di un ordine di grandezza quelli dei loro concittadini che vengono pagati in base ai livelli di retribuzione nazionali. Non sorprende che tali burocrati e accademici, pagati all’estero ma originari del luogo, raramente siano coinvolti in episodi di corruzione: sono pagati molto bene e hanno una reputazione internazionale da difendere. Ma non sorprende neppure che le loro retribuzioni, molto più elevate rispetto a quelle di chi svolge un lavoro analogo, siano motivo di rabbia e scoramento per i dipendenti pubblici i cui stipendi sono allineati ai livelli nazionali, e che questi possano cercare di integrare il loro reddito attraverso la corruzione.
Se si trascura questo aspetto (fare lo stesso lavoro insieme a persone che sono pagate molto di più), è molto facile attribuire la colpa della corruzione alla cultura locale. La realtà è più complessa: la corruzione viene vista, in un certo senso, come un reddito dovuto nei confronti di chi nasce con una penalità di cittadinanza. La migrazione è, come abbiamo osservato, uno dei modi per convertire la propria penalità di cittadinanza in premio; la corruzione è solo un altro modo di fare la stessa cosa38.
4.4b. Perché non si farà quasi nulla per arginare la corruzione
Come affrontare la corruzione in questa fase di capitalismo globale ipercommercializzato? Vale la pena di tornare alle tre ragioni alla base dell’aumento della corruzione che ho individuato all’inizio di questo paragrafo. La prima, ideologica, deriva dalla natura stessa del sistema che pone il fare soldi, in qualsiasi modo, alla base dei propri valori. Gli incentivi alla corruzione sono insiti nel sistema, e non c’è nulla che si possa fare, a parte cambiare il sistema di valori, per modificare questo stato di cose.
La seconda ragione, ossia la possibilità concreta di praticare la corruzione, è legata all’apertura dei conti capitale e all’articolato sistema di servizi disponibile nei paesi ricchi o nei paradisi fiscali, il cui obiettivo principale è quello di attirare i ladri dai paesi più poveri o gli evasori fiscali dai paesi ricchi promettendo loro, rispettivamente, l’immunità dai procedimenti giudiziari se portano i loro soldi nei paesi dove vige lo Stato di diritto, o di metterli al riparo dalle tasse. E qui si può fare molto. Contrastare i paradisi fiscali sarebbe relativamente facile se solo i paesi importanti che perdono volumi significativi di gettito fiscale a causa dei loro cittadini evasori lo volessero. Alcuni esempi recenti dimostrano che i grandi paesi, se e quando decidono di agire, hanno la forza di colpire duramente la corruzione: gli Stati Uniti hanno sfidato con successo le leggi svizzere sul segreto bancario, l’Unione europea ha vietato l’aliquota zero dell’imposta sulle società in Irlanda e Lussemburgo, la Germania ha adottato misure drastiche contro l’evasione fiscale favorita dal Liechtenstein, e il parlamento britannico ha chiesto l’introduzione di registri patrimoniali nei paradisi fiscali britannici come le Isole Cayman e le Isole Vergini britanniche. Ma questo tipo di iniziative può tenere a freno solo una parte della corruzione, ossia quella che colpisce gli stessi paesi ricchi, danneggiati dall’evasione fiscale dei loro cittadini.
È molto più difficile affrontare l’altro aspetto della corruzione, quello in cui i paesi ricchi ne sono i diretti beneficiari, vale a dire dove i sistemi bancari e giudiziari incoraggiano la corruzione nei paesi poveri promettendo l’immunità dall’azione penale. In questo caso, le politiche dei paesi ricchi dovranno essere dirette contro i forti interessi costituiti all’interno di ogni nazione: banchieri e avvocati che traggono diretto profitto dalla corruzione; agenti e società immobiliari che fanno soldi grazie a stranieri corrotti; e politici, università, Ong e think tank che partecipano al riciclaggio morale. Un semplice elenco di tutti i gruppi che hanno interesse a che la corruzione nel Terzo Mondo continui è sufficiente per farci riflettere sull’effettiva probabilità che vengano adottate misure serie in proposito.
La situazione di questo tipo di corruzione è simile a quella del traffico di droga e della prostituzione. I tentativi di porre rimedio alla corruzione e di ridurre il consumo di droga e la prostituzione hanno come unico obiettivo quello di colpire l’offerta: si dice a paesi come l’Ucraina e la Nigeria di controllare la corruzione, alla Colombia e all’Afghanistan di ridurre la produzione di cocaina, o alle professioniste del sesso di cambiare lavoro. In nessuno di questi ambiti la politica concentra l’attenzione sulla domanda, andando a colpire i beneficiari della corruzione nei paesi ricchi, i consumatori di droghe in Europa e negli Stati Uniti, o gli utenti dei servizi delle lavoratrici del sesso. Se ciò non accade non è perché contrastare l’offerta sia più efficiente; anzi, ci sono validi motivi per ritenere vero il contrario. La ragione è che contrastare la domanda è politicamente molto più difficile. È quindi improbabile che questo calcolo politico, in materia di corruzione, possa cambiare presto.
L’ultima ragione che spiega la corruzione legata alla globalizzazione è l’effetto dimostrativo. Anche in questo caso è molto difficile immaginare come ciò possa cambiare, dato che nel prossimo futuro persisteranno le ben note e profonde differenze di reddito tra i paesi (e quindi l’esistenza di ingenti premi o penalità di cittadinanza), mentre le collaborazioni tra persone di paesi diversi che, a parità di lavoro, ricevono retribuzioni differenti diventeranno sempre più comuni. Casomai, possiamo aspettarci un incremento di questo tipo di corruzione autoassolutoria.
La lotta contro il tipo di corruzione che colpisce direttamente i paesi potenti attraverso la perdita di gettito fiscale dovrebbe raccogliere un sostegno politico sufficiente, e forse tale corruzione potrebbe diminuire. Tutte le altre forme di corruzione sono legate al tipo di globalizzazione che abbiamo; dobbiamo abituarci all’aumento della corruzione e considerarla come una fonte di reddito logica (quasi normale) nell’era della globalizzazione. Per sua stessa natura non diventerà mai legale – salvo forse in alcune delle sue manifestazioni come il lobbismo politico – ma si è già normalizzata, e lo sarà sempre di più. Dobbiamo anche riconoscere la nostra ipocrisia e smetterla di moraleggiare sulla corruzione, oltre che di intimidire i paesi poveri: molte persone nei paesi ricchi traggono vantaggio da questo fenomeno, e il tipo di globalizzazione con cui abbiamo a che fare lo rende inevitabile.
1 Una definizione di rendita lievemente diversa ma ugualmente appropriata è quella di Marx: «[Essa ha] come caratteristica particolare che il suo ammontare non è affatto determinato da quello che fa il suo beneficiario, ma dallo sviluppo, indipendentemente dal suo concorso, del lavoro sociale, a cui egli non prende parte» (Il Capitale, libro III, sezione VI, cap. 37: http://www.criticamente.com/marxismo/capitale/capitale_3/Marx_Karl_-_Il_Capitale_-_Libro_III_-_37.htm).
2 Più, in alcuni casi, il profitto tratto da ciò che viene prodotto altrove utilizzando capitali di proprietà di persone con la stessa cittadinanza.
3 Vedi Milanovic (2015), dove il valore della cittadinanza di ciascun paese viene confrontato non solo per tutte le diadi nazionali ma per tutte le combinazioni di paesi e decili di reddito (per esempio, il valore della cittadinanza svedese per un brasiliano è diverso a seconda che si trovi in basso o in alto nella distribuzione del reddito brasiliano).
4 A volte, tuttavia, una cittadinanza «migliore» può essere più urgentemente necessaria per gli anziani quando, per esempio, dà diritto all’assistenza sanitaria gratuita o al soggiorno in una casa di riposo.
5 Anche gli schiavi erano dei sottocittadini. Nella Roma imperiale la schiavitù era una categoria giuridica, non economica (vedi Veyne 2001), ma i diritti degli schiavi – persino quando erano ricchi – risultavano limitati rispetto a quelli dei liberi cittadini. Anche i diritti dei liberti non erano uguali sotto tutti gli aspetti a quelli dei nati liberi.
6 Il Regno Unito costituisce un’eccezione a questa generale mancanza di preoccupazione, per ovvie ragioni, in quanto controllava un’enorme quantità di territorio popolato da persone con redditi molto più bassi. Nel 1948, confermò la libera circolazione delle persone all’interno del Commonwealth (che in linea di principio esisteva già anche prima della Prima guerra mondiale), per poi revocarla vent’anni dopo con il Commonwealth Immigration Act. Avner Offer (1989) ha sottolineato l’atteggiamento spesso problematico e ambivalente della Gran Bretagna nei confronti della popolazione di colore («coloured») nei paesi in condizione di «autogoverno» come l’Australia e il Canada, che erano nominalmente uguali all’India, ma spesso rifiutavano la libera circolazione dei lavoratori. I territori autonomi erano i più preoccupati di accettare il lavoro non bianco, forse perché l’afflusso massiccio di persone dall’India avrebbe sbilanciato l’equilibrio del potere politico a sfavore della popolazione bianca.
7 Zygmunt Bauman (in Le coût humain de la mondialisation [trad. it. Dentro la globalizzazione: le conseguenze sulle persone, Laterza, Roma-Bari 2001] citato in Wihtol de Wenden [2010, p. 70]) osserva correttamente che il diritto alla mobilità è un nuovo bene superiore. Le persone provenienti dai paesi ricchi possono circolare liberamente, mentre quelle dei paesi poveri non si possono muovere da dove sono.
8 In un primo momento, tuttavia, potrebbe incrementare le migrazioni eliminando la mancanza di denaro come vincolo a trasferirsi all’estero.
9 È stato calcolato che l’eliminazione delle attuali barriere alla libera circolazione del lavoro internazionale porterebbe più che a raddoppiare il reddito mondiale (Kennan 2014). Secondo Borjas (2015, tabella 1), il guadagno nello scenario intermedio (né ottimistico né pessimistico) è pari a quasi il 60 per cento del Pil mondiale. In tutti questi calcoli, i guadagni derivano dall’aumento del prodotto marginale di lavoratori migranti che, una volta in un paese più ricco, possono avvalersi di infrastrutture molto migliori e di un capitale più elevato.
10 Lett.: «Date a me le vostre stanche e povere masse accalcate, anelanti a respirare libere». Il verso è tratto dal sonetto The New Colossus della poetessa newyorkese Emma Lazarus (1849-1887), inciso su una targa di bronzo collocata all’interno del piedistallo della Statua della Libertà (N.d.T.).
11 Gli studi sui prestiti della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale evidenziano sempre un effetto netto vicino allo zero sulla crescita dei paesi beneficiari (Rajan e Subramanian 2005). Questo nonostante il fatto che i tassi di rendimento dei singoli progetti finanziati dagli aiuti economici internazionali o con prestiti agevolati siano spesso positivi (Dalgaard e Hansen 2001).
12 Si veda, per esempio, un’analisi sulla diminuzione del premio di rischio, il cosiddetto effetto impero, in Ferguson e Schularick (2006).
13 Alcuni di questi strumenti potrebbero essere anacronistici (per esempio, la bilancia nazionale dei pagamenti e soprattutto i bilanci nazionali bilaterali) perché la globalizzazione di oggi è sostanzialmente diversa dalla prima. Molti dei nostri modi di pensare l’economia derivano ancora dalla globalizzazione così com’era in passato.
14 È questo il motivo per cui viene anche usato il termine «frammentazione globale» della produzione (Los, Timmer e De Vries 2015).
15 Le istituzioni contavano, invece, per gli esportatori di capitali.
16 La presenza fisica del lavoro potrà essere ancora necessaria per determinate occupazioni, ma il punto essenziale è che ci sarebbero meno occupazioni di questo tipo.
17 Partiamo dal presupposto, come in precedenza, che ridurre significativamente i divari di reddito tra le nazioni non sia un’opzione realistica a breve o medio termine.
18 Aristotele, Etica nicomachea, libro VIII. Il filosofo sostiene che all’interno di ogni comunità c’è una philía (affezione, disposizione affettiva), ma che la philía diminuisce, come in cerchi concentrici, a mano a mano che ci si allontana da una comunità molto ristretta.
19 Non esistono, purtroppo, studi empirici sul nesso tra globalizzazione e corruzione. Quello che più si avvicina, a quanto mi risulta, è un articolo del 2013 in cui Benno Torgler e Marco Piatti hanno evidenziato, a seguito di uno studio transnazionale, che sia un indice della globalizzazione di un paese sia un indice della corruzione di un paese sono positivamente correlati con il numero di miliardari.
20 Queste indagini sono diverse da quelle sulla «corruzione vissuta», a mio parere migliori, ma ancor meno disponibili.
21 I risultati di un esperimento naturale hanno rivelato il motivo per cui viene detenuta la maggior parte dei conti nei paradisi fiscali (Johannesen 2014). Nel 2005, quando l’Unione europea convinse il governo svizzero a imporre una ritenuta fiscale sugli interessi maturati dai residenti dell’Ue titolari di conti bancari svizzeri, nel giro di soli quattro mesi il numero di tali conti diminuì di circa il 40 per cento.
22 Altre stime del denaro depositato nei paradisi fiscali risultano leggermente più alte: Becerra et al. (2009), per esempio, hanno stimato 6700 miliardi di dollari contro i 5900 miliardi di dollari di Zucman. Per le stime fino al 2015, vedi Alstadsaeter, Johannesen e Zucman (2017).
23 Fondo monetario internazionale, Balance of Payment Statistics Yearbook 2017, tabella A-1; IMF Committee on Balance of Payments Statistics, Annual Report 2010, tabella 2.
24 Freund classifica i miliardari come persone con aderenze politiche «se si hanno notizie che ne collegano la ricchezza a cariche pubbliche ricoperte in passato, a parenti stretti con incarichi di governo o a licenze discutibili» (2016, p. 24). Il gruppo comprende anche miliardari le cui imprese sono aziende di Stato privatizzate (per l’ovvia necessità che il governo acconsenta a tali trasferimenti) e quelli la cui ricchezza proviene da petrolio, gas naturale, carbone e altre risorse naturali. Anche in questo caso, il controllo sull’area geografica in cui si trovano le risorse dipende spesso da concessioni governative.
25 Calcoli effettuati sulla base dei dati gentilmente forniti da Caroline Freund e Sarah Oliver.
26 Questa è l’opinione di Machiavelli. Se da una parte la libertà porta alla ricchezza («perché si vede per esperienza le cittadi non avere mai ampliato né di dominio né di ricchezza, se non mentre sono state in libertà», come afferma nei Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, libro II, cap. 2 [citazione tratta da Wootton 2018, p. 40]), dall’altra la ricchezza è la fonte della corruzione. Ecco perché la libertà repubblicana (che chiameremmo democrazia) si trova solo nelle società agricole povere come la Repubblica romana e le città medievali tedesche, ma non in una società commerciale come la Firenze di Machiavelli.
27 Jack Abramoff è un famigerato lobbista che, a causa di molteplici loschi affari e servizi resi a clienti discutibili, alla fine è stato giudicato colpevole e condannato a sei anni di reclusione. Ma, a quanto mi dicono persone che hanno lavorato nello stesso «settore», ciò che ha fatto Abramoff non è stato eccezionale, ma forse solo più sfacciato.
28 Questo tipo di corruzione, limitata a pochi leader di alto livello, non può essere considerata una corruzione generalizzata. Inoltre, questi vantaggi non erano trasferibili alla generazione successiva.
29 In un libro sulla corruzione in Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala (2018) porta l’esempio delle transazioni elettroniche tra diversi ministeri come una delle misure introdotte per combattere la corruzione.
30 I controlli sui movimenti di capitale esercitati in Gran Bretagna negli anni Sessanta e Settanta sono ritenuti responsabili della creazione di aree finanziarie offshore come le Isole del Canale, dove i controlli valutari potevano essere elusi.
31 Piñera (2016).
32 Vedi Mauritius Largest Source of FDI in India, Says RBI, in «The Economic Times», 19 gennaio 2018: https://economictimes.indiatimes.com/articleshow/62571323.cms.
33 In una recensione del libro di Oliver Bullough, Moneyland: Why Thieves and Crooks Now Rule the World and How to Take It Back (2018), Vadim Nikitin («London Review of Books», 21 febbraio 2019) cita una parte del testo in cui un addetto alle pubbliche relazioni londinese spiega come lo scopo che si prefigge per i propri clienti corrotti sia quello di renderli «invincibili» trasformandoli in «filantropi» e fare in modo che nessuno possa scrivere nulla sul loro conto, a meno che non voglia trovarsi ridotto sul lastrico a seguito di costose azioni legali per calunnia. Il metodo funziona bene.
34 Black, Kraakman e Tarassova (2000, p. 26) scrivono: «Dopo il default di Bank Menatep a metà del 1998, Chodorkovskij trasferì tutte le attività buone in una nuova banca, la Menatep-St. Petersburg, lasciando depositanti e creditori a scannarsi per quel poco che restava della carcassa della vecchia banca. Per far sì che le transazioni non potessero essere tracciate, Chodorkovskij fece caricare gran parte dei documenti della banca Menatep degli ultimi anni su un camion che, andato fuori strada su un ponte, cadde nel fiume Dubna. Dove presumibilmente questi documenti rimarranno». Parlano anche dell’acquisto di azioni Yukos e di come, secondo alcune stime, circa 4,4 miliardi di dollari di fondi pubblici gestiti dalla banca di Chodorkovskij non siano «mai arrivati a destinazione» (p. 14).
35 Nel 2018, Leonid Blavatnik era la terza persona più ricca del Regno Unito; è stato nominato cavaliere per le sue attività filantropiche.
36 La teoria del reddito relativo proposta da James Duesenberry nel 1949 si basava su un ragionamento simile: che il nostro consumo risponde a quello che percepiamo come consumo normale o desiderabile all’interno della comunità di appartenenza.
37 Un amico serbo che ha lavorato in un’impresa di ristorazione per le forze americane in Iraq mi ha raccontato, forse con un po’ di esagerazione, quello che dicevano gli appaltatori: per lo stesso lavoro, un americano sarebbe stato pagato 100 dollari, un europeo dell’Est 10 dollari e un africano 1 dollaro.
38 Una volta, poco prima di una finale dei mondiali di calcio, ho comprato – pagandolo un sacco di soldi – un biglietto da un ufficiale di gara di una nazione africana che probabilmente l’aveva avuto gratis e faceva bagarinaggio. Lui non si è sentito minimamente in imbarazzo a venderlo, né io a comprarlo. Ho pensato che con ogni probabilità aveva (legittimamente) paragonato il suo modesto salario a quello di un identico arbitro svizzero, giungendo alla conclusione che fosse nel suo pieno diritto trovare un modo per arrotondare. E così è stato.