2.
Il capitalismo liberal-meritocratico
[La democrazia] non è divinamente piacevole sul momento?
Platone, La Repubblica
Definizione di capitalismo liberal-meritocratico
La definizione di capitalismo liberal-meritocratico è piuttosto semplice. Definisco il capitalismo alla maniera di Karl Marx e Max Weber, come il sistema in cui la maggior parte della produzione viene realizzata con mezzi privati, il capitale assume salariati legalmente liberi e il coordinamento è decentralizzato. Inoltre, per aggiungere un requisito evidenziato da Joseph Schumpeter, le decisioni di investimento vengono prese perlopiù da aziende private o da singoli imprenditori1.
I termini «meritocratico» e «liberale» derivano dalle definizioni di diverse forme di uguaglianza che John Rawls espone in Una teoria della giustizia (1971). L’«eguaglianza meritocratica» è un sistema di «libertà naturale», in cui le carriere sono «aperte ai talenti» – ossia non vi sono ostacoli giuridici che impediscano agli individui di raggiungere una determinata posizione nella società – e che accetta pienamente l’eredità della proprietà. L’«eguaglianza liberale» è più egualitaria perché compensa, in parte, l’eredità della proprietà imponendo tasse di successione elevate e include l’istruzione gratuita come mezzo per ridurre la trasmissione intergenerazionale dei vantaggi. Il termine «capitalismo liberal-meritocratico» si riferisce quindi a come vengono prodotti e scambiati beni e servizi («capitalismo»), a come vengono distribuiti tra gli individui («meritocratico»), e a quanta mobilità sociale c’è («liberale»).
In questo capitolo, mi concentro su come le forze sistemiche all’interno del capitalismo liberal-meritocratico plasmano la distribuzione del reddito e portano alla formazione di un’élite altoborghese. Nel capitolo 3 prenderò in esame questioni simili nel contesto del capitalismo politico. In entrambi, focalizzo l’attenzione sulla distribuzione del reddito, sulle disparità di reddito e di capitale e sulla formazione delle classi, non sulla produzione.
2.1. Principali caratteristiche del capitalismo liberal-meritocratico
2.1a. Capitalismi storici
Il capitalismo liberal-meritocratico può essere meglio compreso mettendone i tratti distintivi a confronto con quelli del capitalismo classico ottocentesco e con il capitalismo socialdemocratico esistito più o meno tra la fine della Seconda guerra mondiale e gli inizi degli anni Ottanta nell’Europa occidentale e in Nord America. Parliamo qui di caratteristiche «ideali-tipiche» dei sistemi, ignorando particolari specifici che sono variati da un paese all’altro e nel tempo. Ma nei paragrafi successivi, in cui mi concentro unicamente sul capitalismo liberal-meritocratico, analizzo dettagliatamente queste caratteristiche per un paese che può essere considerato prototipo, ossia gli Stati Uniti.
La tabella 2.1 riepiloga le differenze fra i tre tipi storici di capitalismo attraverso i quali sono passate le economie occidentali. Per semplicità, prendo il Regno Unito prima del 1914 come rappresentativo del capitalismo classico, l’Europa occidentale e gli Stati Uniti dalla fine della Seconda guerra mondiale fino ai primi anni Ottanta come caratteristici del capitalismo socialdemocratico, e gli Stati Uniti del xxi secolo come emblematici del capitalismo liberal-meritocratico2. Poiché negli Stati Uniti, negli ultimi trent’anni, le due caratteristiche essenziali che differenziano il capitalismo liberale da quello meritocratico – ossia l’imposta sulle successioni e l’istruzione pubblica aperta a tutti – si sono indebolite, il paese potrebbe essersi spostato verso un modello di capitalismo più «meritocratico» e meno «liberale». Tuttavia, poiché utilizzo gli Stati Uniti come esempio di tutti i paesi capitalisti ricchi, ritengo sia ancora accettabile parlare di capitalismo liberal-meritocratico come modello unico.
|
Forma |
Capitalismo |
Capitalismo |
Capitalismo |
|
Economia |
Regno Unito |
Stati Uniti, Europa |
Stati Uniti ai primi |
|
1. Aumento della quota dei redditi da capitale nel prodotto netto |
Sì |
No |
Sì |
|
2. Elevata concentrazione della proprietà del capitale |
Sì |
Sì |
Sì |
|
3. Gli individui con abbondanza di capitali sono ricchi |
Sì |
Sì |
Sì |
|
4. Chi è ricco in termini di redditi da capitale è ricco anche sotto il profilo dei redditi da lavoro |
No |
No |
Sì |
|
5. I ricchi (o potenzialmente ricchi) si sposano fra loro (omogamia) |
Sì (in parte) |
No |
Sì |
|
6. Elevata correlazione del reddito fra genitori e figli (trasmissione di vantaggi) |
Sì |
Sì, ma debole in alcuni casi |
Sì |
Tabella 2.1. Caratteristiche principali del capitalismo classico, socialdemocratico e liberal-meritocratico.
N.B.: «Ricco» senza ulteriori indicazioni significa che una persona ha grandi redditi.
Divisione del prodotto netto fra possidenti e lavoratori
Partiamo dalla caratteristica essenziale di ogni sistema capitalistico, ossia la divisione del reddito netto fra i due fattori della produzione: il capitale (possidenti in genere) e il lavoro. Questa divisione non deve necessariamente coincidere con due distinte classi di individui. Sarà così solo quando una classe di individui produrrà reddito solo dal capitale, e un’altra solo dal lavoro3. Come vedremo, il fatto che queste classi si sovrappongano o meno è ciò che distingue i diversi tipi di capitalismo.
Non disponiamo di dati precisi sulla ripartizione del reddito netto totale fra capitale e lavoro per il periodo antecedente al 1914, poiché le prime stime per il Regno Unito, elaborate dall’economista Arthur Bowley, risalgono a non prima del 1920. Sulla base di questo studio, è stato argomentato che le quote distributive dei salari e dei profitti nel reddito sono più o meno costanti, secondo una tendenza che ha assunto la denominazione di legge di Bowley. I dati elaborati da Thomas Piketty (2014, grafici 6.1 e 6.2) per il Regno Unito e la Francia hanno gettato seri dubbi su questa conclusione, anche per il passato. Per il Regno Unito nel periodo 1770-2010, Piketty ha rilevato oscillazioni della quota del capitale fra il 20 e il 40 per cento del reddito nazionale. In Francia, tra il 1820 e il 2010, le variazioni sono state ancora più ampie: da oltre il 45 per cento nel 1860 a meno del 15 per cento nel 1940. Le percentuali, tuttavia, si sono stabilizzate dopo la Seconda guerra mondiale, rafforzando la fiducia nella legge di Bowley. Paul Samuelson, per esempio, nella sua autorevole Economia, ha incluso la legge di Bowley fra le sei tendenze di base dello sviluppo economico nei paesi avanzati (forse con lievi segnali di crescita della quota del lavoro) (Samuelson 1976, p. 740). Tuttavia, dalla fine del xx secolo, la quota dei redditi da capitale sul reddito totale è aumentata. Questa tendenza si è mostrata piuttosto decisa negli Stati Uniti, ma è stata documentata anche nella maggior parte dei paesi sviluppati, oltre che in quelli in via di sviluppo, sebbene sia opportuno prendere i dati relativi a questi ultimi con una buona dose di cautela (Karabarbounis e Neiman 2013).
Una quota crescente del reddito da capitale sul reddito totale implica che il capitale e i capitalisti stanno diventando più importanti del lavoro e dei lavoratori, e per questo acquisiscono un maggior potere economico e politico. Questa tendenza si è manifestata sia nel capitalismo classico sia in quello liberal-meritocratico, ma non nella varietà socialdemocratica (tabella 2.1). L’aumento della quota del capitale sul reddito totale incide anche sulla distribuzione interpersonale del reddito in quanto, in genere, (1) le persone che traggono una quota elevata del reddito dal capitale sono ricche e (2) il reddito da capitale si concentra nelle mani di pochi. Questi due fattori determinano quasi automaticamente una maggiore disparità di reddito fra gli individui.
Per capire come mai sia (1) sia (2) sono indispensabili per la conversione automatica di una maggiore quota del capitale in una maggiore disuguaglianza interpersonale basta compiere un piccolo esperimento mentale: supponiamo che la quota del capitale nel reddito netto aumenti, ma che ogni individuo tragga dal capitale e dal lavoro la stessa quota di reddito di ogni altro individuo4. Una quota aggregata crescente del reddito da capitale farà aumentare ogni singolo reddito nella medesima proporzione, ma la disuguaglianza non cambia. (Le misure di disuguaglianza sono relative.) In altre parole, in mancanza di un’elevata correlazione positiva fra il disporre di capitali in abbondanza (ossia la condizione di coloro, i cosiddetti capital-abundant, che traggono una percentuale significativa del loro reddito dal capitale) e l’essere ricchi, una quota aggregata crescente di capitale non porta a una maggiore disuguaglianza interpersonale. Si noti che in questo esempio ci sono ancora ricchi e poveri, ma non c’è correlazione fra la percentuale di reddito che una persona trae dal capitale e la posizione di quella persona nella distribuzione complessiva del reddito.
Immaginiamo ora una situazione in cui i poveri traggano dal capitale una percentuale di reddito maggiore rispetto ai ricchi. Come prima, lasciamo che la quota complessiva del capitale rispetto al reddito netto aumenti. Questa volta, tuttavia, la quota crescente di capitale ridurrà le disuguaglianze di reddito perché farà aumentare proporzionalmente di più i redditi delle persone nel segmento inferiore della distribuzione del reddito.
Ma nessuno di questi due esercizi mentali riflette ciò che realmente accade nelle società capitaliste, dove esiste invece una forte associazione positiva tra il disporre di ingenti capitali e l’essere ricchi. Più una persona è ricca, più è probabile che tragga una quota elevata del proprio reddito dal capitale5. È così in tutti i tipi di capitalismo (vedi tabella 2.1, righe 2 e 3). Questa particolare caratteristica – che le persone con ingenti capitali siano anche ricche – può essere considerata una prerogativa immutabile del capitalismo, almeno nelle forme finora conosciute6.
Ricchezza di capitali e di lavoro nelle persone
La prossima caratteristica da considerare è il nesso fra l’essere benestanti in termini di capitale (cioè disporre di un reddito da capitale elevato all’interno della distribuzione dei redditi da capitale) e l’essere benestanti in termini di retribuzione (ossia avere un reddito da lavoro cospicuo all’interno della distribuzione dei redditi da lavoro). Si potrebbe pensare che le persone con capitali importanti difficilmente saranno ricche in termini di reddito da lavoro, ma non è affatto così. Un semplice esempio con due gruppi di persone, i «poveri» e i «ricchi», lo dimostra chiaramente. I poveri hanno un reddito complessivamente basso, la maggior parte del quale proveniente dal lavoro; per i ricchi è il contrario. Consideriamo la situazione 1: i poveri hanno 4 unità di reddito da lavoro e 1 unità di reddito da capitale; i ricchi hanno 4 unità di reddito da lavoro e 16 unità di reddito da capitale. Qui i capital-abundant sono davvero ricchi, ma l’entità del loro reddito da lavoro è uguale a quella dei poveri. Ora consideriamo la situazione 2: tutto rimane uguale al caso 1, con l’unica differenza che il reddito da lavoro dei ricchi sale a 8 unità. Dispongono ancora di capitali in abbondanza, poiché traggono una quota maggiore del loro reddito totale dal capitale (16 unità su 24 = 2/3) rispetto ai poveri, ma ora sono ricchi anche in termini di reddito da lavoro (8 unità contro soltanto 4 dei poveri).
La situazione 2 si verifica quando gli individui con abbondanza di capitali non sono soltanto ricchi, ma anche relativamente benestanti dal punto di vista del reddito da lavoro. Fermi restando tutti gli altri parametri, la situazione 2 evidenzia una maggiore disuguaglianza rispetto al caso 1. Questa è infatti una delle grandi differenze fra, da un lato, il capitalismo classico e socialdemocratico e, dall’altro, il capitalismo liberal-meritocratico (vedi tabella 2.1, riga 4). La percezione, e la realtà, del capitalismo classico era che i capitalisti (quelli che definisco qui individui capital-abundant) erano tutti molto ricchi, ma in genere non traevano quote significative di reddito dal lavoro; nei casi estremi, non ne producevano alcuno. Non a caso, Thorstein Veblen li aveva etichettati come la «classe agiata». Per converso, i lavoratori non ricavavano dal capitale alcun reddito, il quale proveniva interamente dal lavoro7. In questo caso c’era una suddivisione perfetta della società fra capitalisti e lavoratori, e nessuna delle parti percepiva alcun reddito dall’altro fattore di produzione. (Se aggiungiamo i proprietari terrieri, che traevano il 100 per cento del loro reddito dai beni fondiari, giungiamo alla classificazione tripartita introdotta da Adam Smith.) In società così frammentate, la disuguaglianza era elevata perché i capitalisti disponevano in genere di ingenti capitali che (spesso) garantivano un rendimento consistente, ma non veniva aggravata dal fatto che questi stessi individui avessero anche dei redditi da lavoro elevati.
La situazione è diversa nel capitalismo liberal-meritocratico, così come lo si trova attualmente negli Stati Uniti. Le persone con ingenti capitali tendono a essere ricche anche in termini di lavoro (o, come si dice oggi, sono in genere individui con un «capitale umano» elevato). Mentre i soggetti ai vertici della distribuzione del reddito nel capitalismo classico erano finanzieri, persone che vivevano di rendita e grandi industriali (che nessuno assume, e pertanto non hanno redditi da lavoro), oggi una percentuale significativa delle persone ai più alti livelli della scala sociale è costituita da manager, web designer, medici, banchieri d’investimento e altri professionisti appartenenti alle élites. Sono persone con uno stipendio, che devono lavorare per percepire le loro ingenti retribuzioni8. Ma queste stesse persone, o perché le hanno ricevute in eredità o perché nella loro vita lavorativa sono riuscite a mettere da parte abbastanza denaro, possiedono anche grandi risorse finanziarie e ne traggono un reddito significativo.
La quota crescente del reddito da lavoro nell’1 per cento della popolazione costituito dalle persone più facoltose, ossia il cosiddetto «top 1 percent» (o in gruppi ancora più ristretti, come lo 0,1 per cento dei super-ricchi), è stata ben documentata da Thomas Piketty nel saggio Il capitale nel xxi secolo (2014) e da altri autori9. Torneremo su questo argomento più avanti nel capitolo. Qui è importante capire che la presenza di un reddito da lavoro elevato nella parte alta della distribuzione del reddito, se associato a un alto reddito da capitale percepito dagli stessi individui, aggrava la disuguaglianza. Questa è una peculiarità del capitalismo liberal-meritocratico; una cosa che, a questi livelli, non si era mai vista prima d’ora.
Modelli matrimoniali
Passiamo ora alla questione dei modelli matrimoniali sotto diverse forme di capitalismo (tabella 2.1, riga 5). Quando gli economisti studiano le disparità di ricchezza o di reddito, l’unità di osservazione utilizzata è la famiglia, per la quale è molto importante se tutti i membri, presi singolarmente, siano benestanti oppure no. Poiché molte famiglie si formano attraverso il matrimonio, è essenziale osservare in che modo le persone si accoppiano. Come nel caso del reddito da capitale e da lavoro, il capitalismo liberal-meritocratico si differenzia ancora una volta dalle altre due forme di capitalismo.
Per illustrare la differenza, confrontiamo i modelli matrimoniali negli Stati Uniti negli anni Cinquanta del Novecento e nel xxi secolo. Dopo la Seconda guerra mondiale, gli uomini tendevano a sposare donne dello stesso ceto, ma più ricco era il marito, meno probabilità c’erano che la moglie lavorasse e avesse entrate proprie. Oggi, gli uomini più ricchi e più istruiti tendono a sposare donne più ricche e più istruite. Possiamo dimostrare con un semplice esempio le conseguenze che si producono in termini di disuguaglianza in queste due situazioni. Prendiamo due uomini, uno che guadagna 50 unità e un altro 100, e due donne, una che guadagna 10 unità e l’altra 20. Ora, supponiamo che ci sia un qualche accoppiamento assortativo (detto anche omogamia), cioè una correlazione positiva tra i guadagni dei mariti e quelli delle mogli: l’uomo che guadagna 100 sposa quindi la donna che guadagna 20, e l’uomo più povero sposa la donna più povera. Ma immaginiamo poi che la moglie ricca lasci il lavoro (come accadeva negli anni Cinquanta), mentre nell’altra coppia entrambi continuano a lavorare. Il rapporto fra i due redditi familiari sarà di 100 a 60. Lasciamo ora invariato l’accoppiamento assortativo, ma supponiamo che entrambe le donne (come accade oggi) continuino a lavorare: il rapporto fra i due redditi familiari diventa di 120 a 60, cioè la disuguaglianza aumenta.
L’esempio dimostra che in condizioni di accoppiamento assortativo, la disuguaglianza cresce se aumenta la partecipazione delle donne alla forza lavoro. Salirà ancora di più se prima l’accoppiamento era casuale o disassortativo (con uomini più ricchi che sposano donne più povere). Secondo alcuni, l’accoppiamento assortativo è ora molto più diffuso nel capitalismo liberal-meritocratico perché le norme sociali sono cambiate e questo fa sì che un maggior numero di donne raggiunga un livello elevato di istruzione (in effetti la percentuale di donne laureate è maggiore rispetto a quella degli uomini) e le lavoratrici siano molte di più rispetto a un tempo. È inoltre possibile (ma è solo una congettura) che le preferenze delle persone siano cambiate e che oggi tanto gli uomini quanto le donne preferiscano unirsi a chi è simile a loro. Quali che siano le ragioni, l’incremento dell’omogamia è un altro fattore che farà aumentare le disparità di reddito, ma questo accadrà solo durante il periodo di transizione dall’accoppiamento non assortativo (o accoppiamento assortativo senza partecipazione delle mogli al mondo del lavoro) a quello assortativo. Una volta che le percentuali di accoppiamento assortativo e di partecipazione al mondo del lavoro avranno raggiunto i rispettivi limiti, verrà meno l’effetto di aumentare la disuguaglianza. La disuguaglianza si stabilizza, anche se a livelli elevati.
Trasmissione intergenerazionale della disuguaglianza
L’ultima caratteristica del capitalismo che andremo a esaminare è la trasmissione da una generazione all’altra dei vantaggi acquisiti, in particolare la ricchezza e il «capitale umano», spesso misurati dalla correlazione fra i redditi dei genitori e quelli dei figli (tabella 2.1, riga 6). Anche se mancano i dati relativi ai periodi precedenti, è ragionevole ritenere che tale trasmissione sia stata rilevante sotto tutte le forme di capitalismo. Nei periodi successivi, per i quali disponiamo di dati più precisi, sappiamo che è molto più debole nelle società contemporanee caratterizzate da una maggiore equità, in cui l’accesso all’istruzione è facile, il costo dell’istruzione è a carico dei contribuenti e le imposte di successione sono elevate. Le società nordiche sono caratterizzate da una correlazione intergenerazionale dei redditi particolarmente bassa ed è probabile che lo fosse anche durante il periodo aureo del capitalismo socialdemocratico, specie nell’Europa occidentale10. Per contro, gli Stati Uniti di oggi evidenziano sia un’elevata trasmissione intergenerazionale delle disuguaglianze sia un’elevata disparità di reddito. Studi che mettono a confronto diversi paesi evidenziano una relazione relativamente forte tra le due, quindi la cosa non sorprende (Corak 2013, p. 11; Brunori, Ferreira e Peragine 2013, p. 27). Ci aspetteremmo che anche negli Stati Uniti, con tutte le loro disuguaglianze, sia presente un’elevata trasmissione delle disparità intergenerazionali.
Natura complessa del capitalismo liberal-meritocratico
Che cosa scopriamo, quindi, nel complesso, quando confrontiamo le disuguaglianze nelle diverse versioni del capitalismo? In tutti e sei gli aspetti qui esaminati, il capitalismo liberal-meritocratico mostra caratteristiche che aumentano la disuguaglianza. Si differenzia dal capitalismo classico soprattutto per il fatto che gli individui con ingenti capitali sono anche ricchi in termini di redditi da lavoro, e probabilmente anche per la maggiore tendenza all’accoppiamento assortativo. Si distingue in maniera significativa dal capitalismo socialdemocratico per diversi aspetti: presenta una quota aggregata crescente di capitale nel reddito netto, ha capitalisti con redditi da lavoro elevati, presenta quasi certamente una maggiore prevalenza di accoppiamenti assortativi, e molto probabilmente è caratterizzato da una più spiccata trasmissione intergenerazionale della disuguaglianza.
Tuttavia, prima di passare a un’analisi più dettagliata di ciascuna di queste sei caratteristiche, si rendono necessarie tre osservazioni. Il fatto che il capitalismo liberal-meritocratico abbia un «sì» su tutte e sei non implica necessariamente che debba essere più ingiusto delle altre forme di capitalismo. E infatti non lo è certamente più del capitalismo classico (Milanovic 2016, cap. 2). Non ho incluso qui le forze di ridistribuzione, attraverso imposte dirette e trasferimenti, che il capitalismo liberale ha «ereditato» dal capitalismo socialdemocratico e che mancavano nel capitalismo classico. Queste forze riducono la disuguaglianza al di sotto del livello determinato dal solo reddito di mercato.
In secondo luogo, un «sì» su una singola caratteristica non ci dice quanto quella caratteristica faccia aumentare la disuguaglianza. Per esempio, mentre sia il capitalismo classico sia quello liberale sono caratterizzati da un’elevata concentrazione di redditi da capitale, il livello di concentrazione era molto maggiore nella forma classica. Intorno al 1914, il 70 per cento della ricchezza britannica era nelle mani dell’1 per cento più benestante; quel numero oggi è di circa il 20 per cento (Alvaredo, Atkinson e Morelli 2018). La ricchezza è ancora altamente concentrata, ma molto meno di prima.
In terzo luogo, alcune delle caratteristiche distintive del capitalismo liberal-meritocratico possono essere moralmente accettabili e, in alcuni casi, persino auspicabili. Sì, la disuguaglianza è più accentuata là dove esiste una percentuale maggiore di capitalisti con redditi da lavoro elevati, ma non è forse un bene che le persone possano arricchirsi lavorando? Non è meglio se le persone percepiscono redditi elevati sia dal lavoro sia dalla proprietà, anziché solo da quest’ultima? E, sì, l’omogamia aumenta la disuguaglianza, ma non è forse una cosa auspicabile, alla luce del fatto che riflette un coinvolgimento molto maggiore delle donne nel mercato del lavoro, norme sociali che valorizzano il lavoro retribuito, e una preferenza per partner che sono simili a noi? È questa profonda ambivalenza tra gli effetti sperequanti di alcune caratteristiche del capitalismo moderno e il fatto che la maggior parte delle persone le possano ritenere socialmente desiderabili (a parte le conseguenze sulla disuguaglianza) che dovremo tenere presente quando andremo a esaminare in maggiore dettaglio le caratteristiche del capitalismo liberal-meritocratico e ad analizzare i rimedi per le profonde disuguaglianze che affliggono queste società.
2.1b. Cause sistemiche e non sistemiche di aumento delle disuguaglianze nel capitalismo liberal-meritocratico
Nell’analizzare le forze che determinano la disuguaglianza nel capitalismo liberal-meritocratico, ci siamo concentrati finora su fattori sistemici, o fondamentali. Questi, effettivamente, sembrano essere i fattori dominanti che determinano la distribuzione del reddito, ma intervengono anche fattori non sistemici, o incidentali. Per esempio, la crescita delle disparità di reddito negli Stati Uniti e in altri paesi è dovuta in parte all’aumento del cosiddetto skill premium, ossia il premio alle competenze del capitale umano che viene riconosciuto ai lavoratori più istruiti, e questa non è una caratteristica sistemica del capitalismo liberale. Questo premio crescente è dovuto alla carenza di lavoratori altamente qualificati e al progresso tecnologico che ha reso il lavoro qualificato più produttivo e quindi più richiesto (Goldin e Katz 2010). Ma nulla di fondamentale ai fini del capitalismo liberale impedisce un aumento adeguato dell’offerta di lavoro ad alta qualifica. Non esistono ostacoli giuridici che impediscano alle persone di proseguire negli studi; inoltre, nella maggior parte dei paesi dell’Europa occidentale, l’istruzione superiore è gratuita o relativamente economica. La mancata risposta del lavoro al mutamento tecnologico non deriva da fattori sistemici intrinseci al capitalismo liberale.
Per meglio comprendere la differenza tra fattori sistemici e non sistemici, prendiamo la prima caratteristica del capitalismo analizzata in precedenza, ossia la quota crescente del reddito da capitale. Questo fenomeno è una caratteristica sistemica del capitalismo liberal-meritocratico perché deriva dall’indebolimento del potere contrattuale dei lavoratori. Questo potere indebolito è, a sua volta, il risultato (a) di un cambiamento nell’organizzazione del lavoro nel capitalismo postindustriale, in cui le grandi concentrazioni fisiche di lavoratori sono state sostituite da una forza lavoro decentralizzata composta da soggetti che spesso non interagiscono materialmente fra loro e non possono essere facilmente organizzati, e (b) la globalizzazione in generale e, più specificamente, l’aumento dell’offerta globale di lavoro, compresa l’esternalizzazione della produzione. Tali caratteristiche derivano da profondi cambiamenti nella natura del lavoro nel capitalismo più avanzato e nella globalizzazione, e nessuna delle due è suscettibile di essere ribaltata nel medio periodo.
Anche l’accoppiamento assortativo è un fattore sistemico nella misura in cui scaturisce dalle pari opportunità di accesso all’istruzione per donne e uomini, che a loro volta derivano da una caratteristica sistemica del capitalismo meritocratico (e ancora di più di quello liberale), ossia l’impegno per la parità di trattamento di tutti gli individui indipendentemente da sesso, razza, orientamento sessuale e via elencando. C’è un’ulteriore e più sottile ragione per cui può essere considerata sistemica. In una società in cui la discriminazione, almeno formalmente, è esclusa, la preferenza a legarsi con una persona simile a noi può essere espressa più liberamente che non in un sistema in cui i matrimoni sono combinati. In altre parole, la preferenza per l’uno o l’altro tipo di coniuge non è in sé astorica, ma cambia con il tipo di società in cui si vive11.
La frequente incapacità degli economisti di distinguere tra fattori sistemici e secondari è illustrata dalla mancata comprensione di alcune formulazioni chiave di Thomas Piketty, in particolare l’espressione r > g (che sta a indicare come il tasso di rendimento del capitale sia maggiore del tasso di crescita dell’economia). Debraj Ray (2014), per esempio, ha sottolineato che questa relazione dipende dalla propensione al risparmio dei capitalisti: se questi spendessero l’intero profitto che ricavano dal capitale, allora r > g non avrebbe alcun effetto sui successivi redditi da capitale perché sia il capitale sia il reddito da esso derivante rimarrebbero gli stessi. Ray sostiene pertanto che né un aumento del rapporto capitale-prodotto né un aumento della quota di reddito percepita dai capitalisti è inevitabile. Il ragionamento è corretto, ma irrilevante. È corretto nel senso che se i capitalisti utilizzassero effettivamente il profitto nella sua totalità, non ci sarebbero né aumento del capitale né crescita della disuguaglianza. Ma non ci sarebbe neppure il capitalismo! Infatti, una delle caratteristiche principali del capitalismo – forse la più importante – è che si tratta di un sistema di crescita, in cui i capitalisti non si comportano come feudatari che consumano la rendita, bensì la investono. La funzione del capitalista o del capitalista-imprenditore è sempre stata intesa, da Smith e Marx a Schumpeter e John Maynard Keynes, come accumulazione di risparmi e reinvestimento dei profitti. Se i capitalisti smettessero di comportarsi in questo modo, la regolarità evidenziata da Piketty non reggerebbe, e il sistema di cui stiamo parlando non sarebbe capitalistico, ma qualcos’altro.
La consapevolezza di queste differenze tra caratteristiche sistemiche e secondarie è assolutamente cruciale se vogliamo studiare l’evoluzione del capitalismo liberal-meritocratico e, nel capitolo 3, di quello politico. Quando guardiamo alle caratteristiche sistemiche, prescindiamo dalle variazioni incidentali e dalle peculiarità nazionali per concentrarci sugli elementi che definiscono un sistema e su come essi possono influenzarne l’evoluzione.
2.2. Disparità sistemiche
2.2a. Aumento della quota aggregata del capitale nel reddito nazionale
Circa un decennio fa, è apparso evidente come la quota del reddito da capitale nel reddito nazionale netto fosse in aumento. La scienza economica reputava che il contributo del capitale e quello del lavoro alla formazione del reddito nazionale fossero stabili, per esempio con il 70 per cento derivante dal lavoro e il 30 dal capitale (come indicato dalla legge di Bowley, analizzata nel sottoparagrafo 2.1a). Erano state inoltre elaborate argomentazioni teoriche sul perché le cose dovessero essere così, implicite nella cosiddetta elasticità di sostituzione unitaria tra capitale e lavoro, secondo cui a mano a mano che il prezzo relativo del lavoro aumenta di x punti percentuali rispetto al capitale (ossia il lavoro diventa relativamente più costoso), l’uso relativo del lavoro rispetto al capitale scenderà dell’x per cento. La diminuzione dell’uso di un fattore di produzione più costoso compenserebbe esattamente il suo aumento di prezzo, cosicché la quota aggregata del reddito di quel fattore di produzione (e per definizione dell’altro, dato che ce ne sono solo due) rimarrebbe invariata.
L’idea che la quota del lavoro e quella del capitale siano costanti era così diffusa che gli economisti prestavano poca attenzione a come il reddito fosse distribuito fra capitale e lavoro e anche alle conseguenze sulla concentrazione del reddito da capitale. Gli unici aspetti di cui si occupavano erano il reddito da lavoro e il premio salariale crescente dei lavoratori più istruiti rispetto a quelli meno istruiti, e questo doveva bastare a spiegare l’aumento della disuguaglianza nel suo complesso. L’autorevole libro di Claudia Goldin e Lawrence Katz, The Race between Education and Technology (2010), parla proprio di questo, riproponendo l’idea di Jan Tinbergen secondo cui il progresso tecnologico aumenta la produttività del lavoro altamente qualificato, e in assenza di un sufficiente aumento dell’offerta di tale lavoro, la disuguaglianza dei redditi da lavoro tenderà ad aumentare.
Ma il capitale veniva ignorato, e questo è un errore, perché la quota del capitale nel reddito nazionale è in aumento, come hanno dimostrato Elsby, Hobijn e Şahin (2013) per gli Stati Uniti, e Karabarbounis e Neiman (2013) sia per i paesi ricchi sia per quelli in via di sviluppo12. Da questi saggi emerge che la quota del lavoro negli Stati Uniti, attestata più o meno al 67 per cento alla fine degli anni Settanta, era diminuita di circa 4-5 punti percentuali intorno al 2010. La quota del capitale, dunque, sarebbe dovuta aumentare di 4-5 punti, quindi parecchio, dato che la quota del capitale iniziale era pari a circa un terzo del reddito nazionale13. In uno studio che includeva le economie avanzate, emergenti e in via di sviluppo, Dao et al. (2017) hanno rilevato che il calo della quota del lavoro nelle economie avanzate era dovuto perlopiù alla diminuzione della quota del reddito dei lavoratori con competenze medie, soprattutto attraverso la riduzione dei loro salari.
Le ragioni dell’aumento della quota del capitale sono oggetto di dibattito ed è improbabile che si giunga a una conclusione in tempi brevi. Può anche darsi che non sia possibile rispondere alla domanda in via definitiva perché ciascuno dei fattori addotti come spiegazione può mostrare l’effetto atteso solo se è l’unico a cambiare, e tutti gli altri costanti. Ma è possibile che molti fattori siano interdipendenti e che tutti siano cambiati contemporaneamente, cosicché prenderli uno per uno, benché la cosa abbia senso da un punto di vista econometrico, può non fornire una spiegazione analitica soddisfacente.
Secondo Karabarbounis e Neiman (2013), l’aumento della quota del capitale non è il risultato di una diversa composizione della produzione (per esempio, un aumento nei settori in cui la quota del capitale è elevata) perché rilevano la crescita della quota del capitale in settori diversi, e addirittura in regioni diverse degli Stati Uniti. Secondo gli autori, l’aumento della quota del capitale è stato determinato da un calo del costo dei beni strumentali (si pensi ai computer relativamente economici); ciò ha incrementato l’uso del capitale (sostituendo la manodopera poco qualificata con la tecnologia) aumentandone la quota nel prodotto netto. Ma, sostengono, questo non spiega del tutto l’aumento: parte di esso è dovuto alla crescita del potere monopolistico e dei margini di utile lordi, una constatazione che altri hanno confermato14.
Secondo Robert Solow, l’aumento della quota del capitale deriva da un cambiamento del potere contrattuale relativo del lavoro e del capitale. Quando la manodopera organizzata era relativamente potente, come esemplifica il «contratto di Detroit» del 1950 fra i sindacati degli operai dell’industria automobilistica e le case costruttrici, i lavoratori erano in grado di spingere la distribuzione del reddito a proprio favore15. Ma quando il potere della forza lavoro organizzata si è indebolito – con lo spostamento nella direzione del terziario oltre che verso un sistema capitalistico globale che ha più che raddoppiato il numero dei salariati in tutto il mondo –, il suo decadimento ha spostato la distribuzione funzionale del reddito a favore del capitale16.
Analizzando i dati disponibili da un interessante punto di vista, Barkai (2016) argomenta che sia la quota del capitale sia quella del lavoro sono diminuite, mentre è cresciuta l’importanza di un terzo fattore di produzione: l’imprenditorialità (che normalmente si somma al capitale). In questa ottica, la quota del capitale – definita come reddito percepito dai soli detentori di capitali – è scesa, mentre gli utili societari (ossia quelli degli imprenditori) sono saliti alle stelle17. La causa, secondo Barkai, è la crescente monopolizzazione dell’economia, soprattutto nei settori che sono cresciuti più rapidamente, come quelli dell’informazione e della comunicazione18.
In The Vanishing American Corporation (2016), Gerald Davis evidenzia i cambiamenti nella struttura e nelle dimensioni delle aziende negli Stati Uniti. Secondo l’autore, le società con i ricavi più alti erano anche quelle che impiegavano il maggior numero di persone. Rispettavano accordi taciti con i lavoratori e li retribuivano con salari lievemente superiori a quelli di mercato. Può anche darsi che lo facessero per motivi egoistici, al fine di incentivare la fedeltà verso l’azienda, migliorare i rapporti di lavoro, avere meno scioperi, o meno problemi di ostruzionismo. Ma, sostiene Davis, quando queste aziende hanno esternalizzato molti dei servizi che prima venivano forniti internamente, il loro rapporto con la forza lavoro è cambiato: il personale delle ditte appaltatrici non faceva parte dell’organico aziendale e non c’era più bisogno di premiare la fedeltà né di garantire un ambiente di lavoro piacevole e congeniale. Gli appaltatori potevano essere pagati alle tariffe minime stabilite dal mercato. Da qui la riduzione della quota del lavoro nella formazione del reddito.
Potremmo trovare altre spiegazioni per la riduzione della quota del lavoro (e quindi per l’aumento della quota del capitale), ma quello che ci interessa qui è che la crescita della quota aggregata del reddito da capitale – a causa di quanto è concentrata e di dove si trovano i beneficiari dei redditi da capitale più elevati – avrà un effetto diretto sulle disparità di reddito interpersonali.
2.2b. Elevata concentrazione della proprietà del capitale
La ricchezza è sempre stata più concentrata (cioè non equamente distribuita) rispetto al reddito. È praticamente un’ovvietà: la distribuzione della ricchezza è il prodotto dell’accumulazione nel tempo e della trasmissione all’interno delle famiglie e attraverso le generazioni; tende inoltre a crescere in modo esponenziale non solo se impiegata con saggezza, ma anche se investita in attività prive di rischio. Sappiamo empiricamente che nella storia gli unici contraccolpi veramente gravi alle grandi concentrazioni di ricchezze sono stati provocati da guerre, rivoluzioni e, in alcuni casi, da un’iperinflazione imprevista19.
Nel suo monumentale libro A Century of Wealth in America, Edward Wolff, che da diversi decenni studia la disparità di ricchezza negli Stati Uniti, ha dimostrato che nel 2013 l’1 per cento dei più facoltosi detentori di ricchezza possedeva la metà di tutti i titoli e fondi comuni, il 55 per cento dei titoli finanziari, il 65 per cento dei fondi fiduciari e il 63 per cento del capitale delle aziende. Forse ancora più significativo è che il 10 per cento dei più ricchi possedesse oltre il 90 per cento di tutte le attività finanziarie (Wolff 2017, pp. 103-105). Semplificando, possiamo dire che quasi tutta la ricchezza finanziaria degli Stati Uniti è concentrata nelle mani del 10 per cento più ricco della popolazione. Inoltre, queste percentuali sono lievemente aumentate negli ultimi trent’anni e sono molto più alte della quota di reddito disponibile percepita dai soggetti appartenenti al primo decile di reddito statunitense, che si aggira intorno al 30 per cento20.
Poiché la ricchezza è distribuita in modo meno equo rispetto al reddito complessivo, ne consegue che pure i redditi derivanti da tale ricchezza saranno distribuiti in maniera più disuguale rispetto al reddito complessivo (e soprattutto rispetto ad altre fonti di reddito, come i redditi da lavoro dipendente o autonomo)21. Il reddito da capitale sarà percepito da persone che si collocano anche ai primi posti nella distribuzione del reddito. Questi sono i motivi per cui una quota crescente del reddito da capitale tenderà ad aumentare le disuguaglianze.
Guardando ai livelli di disuguaglianza nel reddito da capitale e da lavoro negli ultimi trent’anni negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e in Norvegia (figura 2.1), notiamo due cose interessanti: il reddito da capitale è distribuito in modo molto più disuguale rispetto al reddito da lavoro e le disparità nel reddito da capitale e da lavoro sono aumentate nel tempo22. L’aumento delle disparità nel reddito da capitale è piuttosto contenuto (pari a pochi punti Gini) perché il livello di disuguaglianza era già molto alto: circa 0,9 negli Stati Uniti e nel Regno Unito, tra 0,85 e 0,9 in Germania, e tra 0,8 e 0,9 in Norvegia23. Si avvicina quindi in tutti i casi a una disuguaglianza massima teorica di 1 (quando l’intero reddito da capitale fosse riconducibile a un individuo o a una famiglia). È inoltre degno di nota il fatto che concentrazioni così elevate di redditi da capitale esistano in tutti i paesi occidentali, e che gli Stati Uniti e il Regno Unito – i quali spesso non rientrano fra i paesi con elevate disparità dei redditi al netto delle imposte – evidenzino in questo caso altri risultati. In breve, è una caratteristica sistemica del capitalismo liberal-meritocratico che il reddito da capitale sia estremamente concentrato e venga percepito soprattutto dai ricchi24.
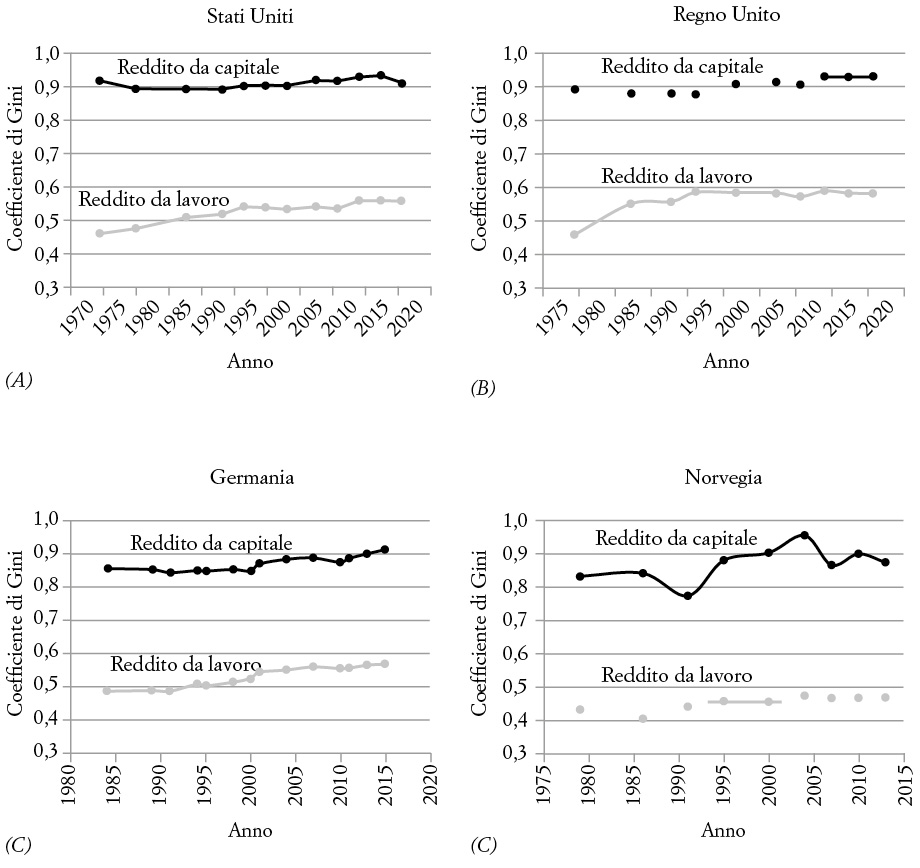
Figura 2.1. Coefficienti di Gini del reddito
da capitale e da lavoro negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in
Germania e in Norvegia, dagli anni Settanta e Ottanta agli anni
2010.
I redditi da capitale e quelli da lavoro sono entrambi al lordo
delle imposte. Poiché i redditi da capitale nella parte alta della
distribuzione del reddito tendono a essere sottostimati (vedi
Yonzan et al. 2018),
il coefficiente di Gini per il reddito da capitale potrebbe essere
ancora più alto. Per le definizioni di reddito da capitale e da
lavoro, si rimanda all’Appendice C.
Fonte: I calcoli sono
basati sui dati del Luxembourg Income Study
(https://www.lisdatacenter.org), che forniscono informazioni a
livello individuale tratte dalle indagini sulle famiglie e
armonizzano le definizioni delle variabili in modo che i redditi da
capitale e da lavoro siano definiti in modo coerente nel tempo e
tra i paesi.
Si noti inoltre che la disparità nel reddito da lavoro (al lordo delle imposte) in questi paesi è aumentata nel periodo, passando da un coefficiente di Gini inferiore a 0,5 a circa 0,6.
Osservando un’istantanea delle disuguaglianze dei redditi da capitale e da lavoro nei paesi ricchi intorno al 2013, vediamo che, fatta eccezione per Taiwan, tutti i paesi indicati hanno un reddito da capitale estremamente concentrato, con coefficienti di Gini superiori a 0,86 (figura 2.2). Gli indici di Gini riferiti ai redditi da lavoro sono molto più contenuti, generalmente tra 0,5 e 0,6, e ancora più bassi per Taiwan. Ritornerò sul caso di Taiwan più avanti nel capitolo.
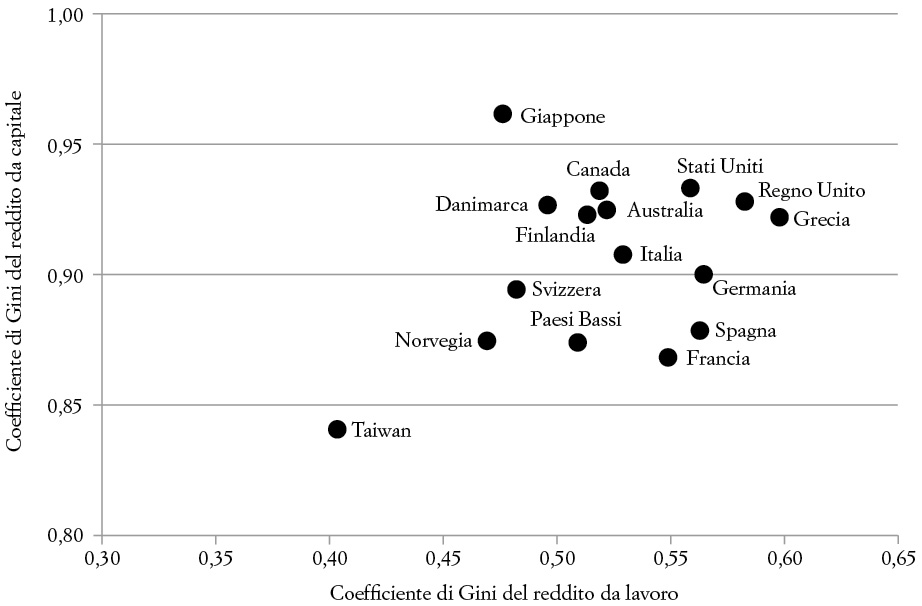
Figura 2.2. Disparità di reddito da capitale
e da lavoro nei paesi ricchi, intorno al 2013.
Fonte: Database del
Luxembourg Income Study (https://www.lisdatacenter.org).
La maledizione della ricchezza
Per capire quanto sia importante la combinazione dell’aumento del reddito da capitale e della forte concentrazione della proprietà del capitale ai fini della disparità di reddito nel suo complesso, bisogna considerarla in modo dinamico. A mano a mano che i paesi si arricchiscono, incrementano la ricchezza attraverso il risparmio e gli investimenti (esattamente come accade alle persone). Inoltre, il capitale aumenta più del reddito e si trasformano gradualmente in paesi «ad alta intensità di capitale». Questo rapporto fra capitale e reddito è un tema centrale nel Capitale nel xxi secolo di Piketty. I paesi con un reddito (Pil pro capite) più elevato non solo hanno una maggiore ricchezza pro capite, ma il loro rapporto ricchezza-reddito (indicato con β) è più alto (tabella 2.2). In termini di Pil pro capite, la Svizzera raggiunge quindi un risultato 53 volte migliore dell’India, ma ha una ricchezza per adulto quasi 100 volte superiore a quella del paese asiatico.
A mano a mano che i paesi capitalisti diventano più ricchi, la quota del reddito da capitale sul reddito netto totale è destinata ad aumentare (a meno che il tasso di rendimento della ricchezza non diminuisca in misura proporzionale), e fintanto che la ricchezza sarà fortemente concentrata, aumenterà anche la disuguaglianza. Inoltre, la relazione tra una ricchezza più consistente e una maggiore disuguaglianza interpersonale è generalmente più forte nei paesi con una più grande abbondanza di capitali, perché è più forte la correlazione tra il disporre di ingenti capitali e l’essere ai primi posti nella distribuzione del reddito (Milanovic 2017). Se la correlazione tra possedere maggiori capitali ed essere ricchi fosse vicina allo zero (cioè se tutti avessero una ricchezza proporzionale al loro reddito), l’aumento della quota del capitale non avrebbe conseguenze sulla disuguaglianza interpersonale. Farebbe semplicemente aumentare il reddito di tutti nella medesima proporzione. Ma quando i ricchi detengono la maggior parte del capitale, qualsiasi aumento della quota del capitale fa aumentare il loro reddito in modo più che proporzionale e alimenta la disuguaglianza.
Il fatto che lo sviluppo porti i paesi ad arricchirsi in misura maggiore che non per l’aumento del loro reddito può essere visto, dal punto di vista della distribuzione, come una maledizione della ricchezza. Come mai? Perché i paesi più ricchi tenderanno «naturalmente» a maggiori disparità. Per questo motivo, gli sforzi finalizzati a ridurre le profonde disuguaglianze dovrebbero essere proporzionalmente maggiori. Se non verranno adottate misure supplementari sul piano politico per compensare le forze che tendono ad aggravare le disuguaglianze a mano a mano che i paesi si arricchiscono, queste finiranno per aumentare.
Ma l’aggravarsi delle disuguaglianze sarà ancora più marcato se il rendimento della ricchezza non è uniforme a tutti i livelli, ma è più elevato per le persone che ne possiedono di più. Questo è l’argomento di cui andiamo ora a occuparci.
|
Ricchezza |
Pil pro capite |
Rapporto |
|
|
Svizzera |
513.000 |
85.000 |
6,0 |
|
Stati Uniti |
301.000 |
53.000 |
5,7 |
|
Giappone |
217.000 |
40.000 |
5,4 |
|
Cina |
22.000 |
7.000 |
3,2 |
|
Indonesia |
12.000 |
3.600 |
3,3 |
|
India |
4.700 |
1.500 |
3,1 |
Tabella 2.2. Ricchezza netta delle famiglie per adulto e Pil pro capite in alcuni paesi selezionati, 2013 (in dollari Usa attuali, ai tassi di cambio di mercato).
Fonte: Dati patrimoniali del Credit Suisse Research Institute (2013) e Jim Davies (comunicazione personale). Dati del Pil della Banca mondiale, Indicatori di sviluppo mondiale.
2.2c. Tasso di rendimento più elevato del patrimonio dei ricchi
I ricchi non solo possiedono patrimoni più ingenti, ma anche una maggiore ricchezza in proporzione al loro reddito e, inoltre, la loro è una ricchezza diversificata rispetto al resto della popolazione. Nel 2013, circa il 20 per cento delle famiglie negli Stati Uniti aveva una ricchezza netta pari a zero o negativa, mentre il 60 per cento delle famiglie della fascia intermedia aveva quasi i due terzi del patrimonio immobilizzati nella casa e il 16 per cento impegnato in fondi pensione (Wolff 2017, cap. 1)25. La ricchezza del ceto medio non è diversificata (poiché la maggior parte è costituita dall’abitazione) ed è gravata da debiti consistenti, che rappresentano una componente sostanziale della ricchezza lorda. Questo è quanto è avvenuto per tutto il secondo dopoguerra, come hanno dimostrato Kuhn, Schularick e Steins (2017), utilizzando i dati storici delle indagini sulla ricchezza negli Stati Uniti. Il rapporto di indebitamento è andato aumentando con la finanziarizzazione dell’economia: nel 2010, la leva finanziaria del ceto medio aveva raggiunto lo sbalorditivo livello dell’80 per cento (su 5 dollari di ricchezza lorda, 4 erano di debiti e solo 1 rappresentava il patrimonio netto), contro il 20 per cento del 1950 (Kuhn, Schularick e Steins 2017, p. 34). La ricchezza della classe media, così poco diversificata e con una leva finanziaria tanto alta, dipende dalle oscillazioni dei prezzi delle case ed è molto volatile. Con un indebitamento dell’80 per cento, basta che il prezzo dell’abitazione scenda del 20 per cento perché la ricchezza netta venga del tutto annullata, ed è quanto è successo durante la crisi finanziaria del 2008.
Ma se guardiamo al 20 per cento della popolazione nella fascia più alta, la composizione della ricchezza cambia: il patrimonio è costituito perlopiù da azioni e strumenti finanziari che, in quell’1 per cento rappresentato dai più benestanti, arrivano a quasi tre quarti della ricchezza. La ricchezza legata al patrimonio immobiliare è, in proporzione, inferiore e nel cosiddetto «top 1 percent» costituisce meno di un decimo del totale.
Questa differenza nella composizione della ricchezza ha un effetto determinante sul tasso medio di rendimento della ricchezza stessa ottenuto dai diversi gruppi di reddito. Se i tassi di rendimento sono abbastanza costanti all’interno delle classi di attività (cioè, il tasso di rendimento dell’abitazione è all’incirca lo stesso, che si possieda un’enorme villa o un piccolo monolocale), allora il tasso di rendimento complessivo dipenderà dalla differenza del tasso di rendimento tra le diverse classi di attività, per esempio se il rendimento dell’abitazione differisce da quello delle attività finanziarie. Nonostante il numero esiguo di studi condotti sul rapporto esistente fra il rendimento di un determinato bene e la quantità di quel bene posseduta, Wolff (2017, p. 119) ha concluso che i tassi di rendimento variano di poco all’interno delle classi di attività. In altre parole (per tornare al nostro esempio), che si possieda una villa o un monolocale, il tasso di rendimento sarà più o meno lo stesso; e questo è vero anche se si possiedono obbligazioni per 1000 dollari o 1 milione di dollari.
Il problema si riduce quindi alla differenza di rendimento fra le varie classi di attività. Nel corso del trentennio 1983-2013, la situazione economica delle famiglie più ricche è andata migliorando perché le attività finanziarie hanno ottenuto performance superiori a quelle delle proprietà immobiliari (Wolff 2017, pp. 116-121). Il rendimento medio reale annuo delle attività finanziarie (tenuto conto dell’inflazione) è stato del 6,3 per cento, mentre il rendimento medio reale delle abitazioni è stato appena dello 0,6 per cento (Wolff 2017, p. 138, tabella 3.1 in appendice). Il rendimento delle attività lorde per l’1 per cento dei più ricchi è stato in media del 2,9 per cento all’anno contro l’1,3 per cento per i tre quintili centrali. Capitalizzata in trent’anni, questa differenza si traduce in un vantaggio per i ricchi di circa il 60 per cento.
Se i ricchi ottengono sistematicamente sulle loro attività rendimenti migliori rispetto al ceto medio e ai poveri, siamo di fronte a un importante fattore di disuguaglianza nel lungo periodo. Per porvi rimedio (ammesso di volerlo fare), occorrerebbe un’imposizione fiscale progressiva sui grandi patrimoni. Bisogna tenere presente, tuttavia, che il tipo di attività detenute dai ricchi non sempre sono quelle di maggior valore. Durante una bolla immobiliare, come negli Stati Uniti tra il 2001 e il 2007, gli immobili spesso surclassano le attività finanziarie. Non è stato così durante i primi tre anni della Grande recessione (quando i rendimenti immobiliari erano più negativi di quelli finanziari), ma normalmente è quanto accade: quando i mercati azionari crollano e i prezzi degli immobili rimangono pressoché invariati, i ricchi ottengono un tasso di rendimento complessivo inferiore a quello del ceto medio. Come abbiamo visto, negli ultimi trent’anni è accaduto il contrario.
Potrebbe darsi, in teoria, che le classi di attività detenute dai ricchi siano più rischiose e più volatili, e che il loro rendimento più elevato sia da attribuire in parte a un premio al rischio. Tuttavia, trent’anni sono un periodo abbastanza lungo per compensare le conseguenze del rischio e, nel lungo termine, i detentori di grandi ricchezze hanno ottenuto risultati migliori del ceto medio.
Le classi di attività detenute dai ricchi valgono di più anche perché in genere sono soggette a un’imposizione fiscale inferiore rispetto a quelle in possesso della classe media. Pertanto, le plusvalenze e, negli Stati Uniti, i «carried interests» (ossia gli utili percepiti dai gestori di fondi di investimento) sono tassati, nella maggior parte dei casi, ad aliquote inferiori rispetto a quelle applicate sugli interessi dei conti di risparmio26.
I ricchi traggono inoltre vantaggio dall’entità del loro patrimonio: i tagli minimi di investimento richiesti per le attività finanziarie ad alto rendimento sono elevati e scoraggiano i piccoli risparmiatori; i grandi investitori possono anche avvalersi di consulenze molto più qualificate su come e dove collocare il loro denaro e pagare commissioni più basse per unità di dollaro investito. Feldstein e Yitzhaki (1982) hanno evidenziato come i ricchi investitori abbiano ottenuto costantemente risultati migliori rispetto ai piccoli risparmiatori in termini di rendimento delle loro attività27.
Nel complesso, i maggiori rendimenti che i ricchi ricavano dai loro patrimoni dipendono da tre fattori: (1) i ricchi detengono proporzionalmente un volume maggiore di attività il cui rendimento a lungo termine è più elevato (effetto della composizione del patrimonio); (2) i ricchi pagano meno imposte per dollaro guadagnato dal patrimonio (vantaggio fiscale); e (3) le commissioni di ingresso e le spese di gestione per dollaro di attività sono inferiori (effetto delle minori barriere all’ingresso).
2.2d. Livelli elevati di reddito da capitale e reddito da lavoro negli stessi individui
Una caratteristica unica e nettamente diversa del capitalismo liberal-meritocratico rispetto alla sua forma classica è la presenza di persone con un alto reddito da lavoro nel decile o nel percentile superiore e, cosa ancora più interessante, la quota crescente di popolazione che detiene sia un alto reddito da lavoro sia un alto reddito da capitale. Creando un neologismo di derivazione greca, chiamo l’associazione fra reddito da lavoro elevato e reddito da capitale elevato all’interno della stessa famiglia (o concentrati nello stesso individuo) omoplutia (da homós «uguale», e ploûtos «ricchezza»).
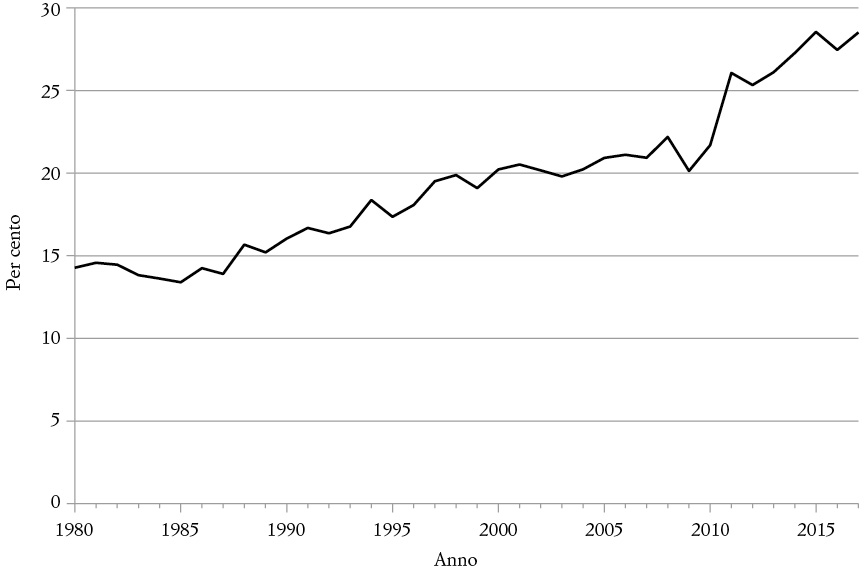
Figura 2.3. Primo decile di capitalisti nel
primo decile di lavoratori (e viceversa), Stati Uniti,
1980-2017.
Gli individui sono classificati in base al reddito pro capite da
lavoro o da capitale; quindi il decile «capitalista» più ricco
include le persone che vivono nel 10 per cento delle famiglie con i
più alti redditi da capitale (e lo stesso per il lavoro). Pertanto,
le percentuali dei capitalisti più ricchi tra i lavoratori più
ricchi e dei lavoratori più ricchi tra i capitalisti più ricchi
sono le stesse.
Fonte: Calcolato in
base ai dati dello US Current Population Survey:
https://www.census.gov/programs-surveys/cps.html.
La parte di persone che hanno sia un alto reddito da lavoro (o da capitale) sia un alto reddito da capitale (o da lavoro) è aumentata negli ultimi decenni (figura 2.3). Nel 1980, solo il 15 per cento delle persone nel primo decile per reddito da capitale si trovavano anche nel primo decile del reddito da lavoro, e viceversa. Questa percentuale è raddoppiata negli ultimi trentasette anni. In una versione rigida del capitalismo classico, ci aspetteremmo che fra i grandi capitalisti quasi nessuno abbia un reddito da lavoro elevato. Sarebbero ricchi comunque, anche con i soli redditi da capitale, e non avrebbero né il desiderio né il tempo di darsi da fare per trovare un lavoro. Allo stesso modo, nessun salariato nel capitalismo classico potrebbe mai avere un reddito da capitale sufficiente da collocarsi fra i capitalisti del primo decile. Ma le cose sono cambiate.
Il punto d’arrivo dell’omoplutia (se riusciamo a immaginarlo) si verificherebbe quando i maggiori capitalisti e i lavoratori con i redditi più alti fossero le stesse persone (il valore sull’asse verticale della figura 2.3 sarebbe 100 per cento). La corrispondenza tra alto capitale e alto reddito da lavoro alimenta le disparità ma, cosa ancora più importante, rende molto più difficile l’avvio di politiche economiche volte a ridurre la disuguaglianza. La ragione di tutto questo è politica. Nel capitalismo classico, la maggior parte dei ricchi non ha avuto bisogno di compiere grandi sforzi, giorno dopo giorno, per raggiungere (o mantenere) il proprio status, mentre nel capitalismo liberal-meritocratico molti di loro sono lavoratori, anche quando una parte importante del loro reddito proviene dalla proprietà del capitale. Vediamo che sono ricchi, ma non sappiamo quanta parte del loro reddito totale derivi dal capitale e quanta dal lavoro. Da un punto di vista politico, è quindi più difficile applicare loro le altissime aliquote fiscali che si usavano in passato, poiché i loro cospicui redditi sono ritenuti più meritati, in quanto derivanti dal lavoro.
L’omoplutia può crescere sia quando persone ricche di capitali acquisiscono alti livelli di istruzione e percepiscono retribuzioni elevate sia quando soggetti ottimamente retribuiti risparmiano parte dei loro stipendi e diventano ricchi capitalisti. Valutare l’impatto dell’una e dell’altra ipotesi senza dati aggiuntivi è impossibile. Il fatto noto, tuttavia, è che la concentrazione della ricchezza è rimasta estremamente elevata negli Stati Uniti e la proprietà diretta di capitali azionari non è cambiata di molto. Nel 1983, il 13,7 per cento della popolazione possedeva direttamente almeno alcune azioni; trent’anni dopo, quella percentuale risultava invariata (Wolff 2017, p. 122). Se includiamo i fondi comuni di investimento e i fondi pensione, la proprietà azionaria è cresciuta da meno di un terzo della popolazione statunitense a circa la metà, ma gli importi posseduti sono perlopiù minimi. Questo suggerisce che l’omoplutia è il prodotto di salari estremamente elevati che «si combinano» (negli stessi soggetti) a una proprietà di capitali già altamente concentrata.
2.2e. Maggiore omogamia (accoppiamento assortativo)
Può essere utile introdurre questo argomento con un aneddoto. Una decina di anni fa mi trovai a conversare dopo cena con un americano che aveva studiato in un college d’élite della Ivy League e ora insegnava in Europa. Resa scorrevole dal vino, la nostra conversazione cadde su questioni inerenti alla vita, al matrimonio e ai figli. In un primo momento, rimasi sorpreso da una sua affermazione. Disse che chiunque avesse sposato, determinate cose, in un certo senso, erano già «scritte»: il luogo dove i coniugi avrebbero deciso di vivere, il tipo di casa che avrebbero acquistato, il genere di vacanze e di divertimenti che avrebbero scelto e persino le università che i figli avrebbero frequentato. Il suo ragionamento era il seguente: «Quando sono andato all’università, sapevo che avrei sposato una donna conosciuta lì. Per le ragazze funzionava allo stesso modo. Tutti eravamo consapevoli del fatto che non avremmo mai più vissuto in un ambiente altrettanto favorevole per trovare un buon partito, con una scelta così ampia di candidati e candidate eccellenti. E poi, qualsiasi ragazza avessi sposato, sarebbe stata un esemplare dello stesso genere: erano tutte colte, donne intelligenti che provenivano dalla stessa classe sociale, leggevano gli stessi romanzi e giornali, si vestivano allo stesso modo, avevano le stesse preferenze in fatto di ristoranti, escursioni, luoghi in cui vivere, automobili da guidare, persone con cui uscire, e la pensavano allo stesso modo anche su come allevare i figli e in quali scuole mandarli. Da un punto di vista sociale, la scelta della donna da sposare non avrebbe fatto praticamente nessuna differenza». E poi aggiunse: «All’epoca non me ne rendevo conto, ma oggi mi è chiarissimo».
La storia mi colpì e mi è rimasta in mente per molto tempo. Contraddiceva l’amata leggenda che ci vuole tutti profondamente diversi, individui unici, e secondo cui le decisioni personali come il matrimonio, che hanno a che fare con l’amore e le preferenze, sono di capitale importanza e hanno conseguenze determinanti sul resto della nostra vita. Ciò che il mio amico diceva era l’esatto contrario: avrebbe potuto innamorarsi di A, o B, o C, o D, e alla fine sarebbe comunque andato ad abitare praticamente nella stessa casa, nello stesso ricco quartiere – a Washington, a Chicago o a Los Angeles – con una cerchia simile di amici e interessi analoghi, e con bambini che vanno nelle stesse scuole e fanno gli stessi giochi. La sua storia aveva senso, eccome. Naturalmente, questo scenario presupponeva che le persone che frequentavano lo stesso college avrebbero formato delle coppie. Se avesse lasciato l’università, o se fra le compagne di studi non ne avesse trovata nessuna adatta da sposare, il risultato avrebbe potuto essere diverso (per esempio, una casa in un quartiere abitato da famiglie meno abbienti). La sua storia illustra efficacemente il potere della socializzazione: quasi tutti nelle università di élite provengono da famiglie più o meno ugualmente ricche, e quasi tutti condividono più o meno gli stessi valori e gli stessi gusti. E queste persone così reciprocamente indistinguibili si sposano tra loro.
Ricerche recenti hanno documentato un chiaro aumento della prevalenza dell’omogamia, o accoppiamento assortativo (persone con un livello di istruzione e di reddito uguale o simile che si sposano). Uno studio basato su una rassegna della letteratura associata ai dati decennali dell’American Community Survey ha evidenziato che l’associazione fra il livello di istruzione dei partner era prossima allo zero nel 1970; in ogni decennio successivo fino al 2010, il coefficiente è stato positivo e ha continuato ad aumentare (Greenwood, Guner e Vandenbroucke 2017). Un altro database (Yonzan 2018) fornisce una prospettiva diversa su questa tendenza; prende in esame le statistiche sul matrimonio per le donne e gli uomini americani che si sono sposati quando erano «giovani», cioè tra i venti e i trentacinque anni. Nel 1970, solo il 13 per cento dei giovani americani che si trovavano nel decile superiore dei lavoratori maschi sposavano giovani donne che si trovavano nel decile superiore delle lavoratrici. Nel 2017, questo dato era salito a quasi il 29 per cento (figura 2.4a). Allo stesso tempo, i giovani lavoratori maschi del decile superiore avevano molte meno probabilità di sposare giovani donne che si trovassero nel decile inferiore delle lavoratrici. Il tasso è sceso costantemente, dal 13,4 per cento a meno dell’11 per cento. In altre parole, i giovani americani con redditi da lavoro molto alti che negli anni Settanta avevano la stessa probabilità di sposarsi con donne che guadagnavano molto o con donne che guadagnavano poco manifestano oggi una preferenza di quasi tre a uno a favore delle donne con stipendi elevati. Un cambiamento ancora più drastico si registra per le donne: la percentuale delle giovani con stipendi elevati che sposano uomini con retribuzioni consistenti è aumentata da poco meno del 13 per cento al 26,4 per cento, mentre quella delle giovani ricche che sposano giovani poveri si è dimezzata (figura 2.4b)28. Dal non avere alcuna preferenza tra uomini ricchi e poveri negli anni Settanta, le donne preferiscono ora gli uomini ricchi in un rapporto di quasi cinque a uno29.

Figura 2.4a. Percentuale di uomini dai 20 ai 35 anni nel primo decile uomini per reddito da lavoro che hanno sposato donne dai 20 ai 35 anni nel primo e nell’ultimo decile donne per reddito da lavoro, 1970-2017.
Il «marriage education premium»
In un articolo molto ambizioso, Chiappori, Salanié e Weiss (2017) hanno cercato di spiegare sia l’aumento dell’accoppiamento assortativo sia il crescente livello di istruzione fra le donne (che contrasta con il mancato aumento di questo parametro per gli uomini). Secondo gli autori, le donne altamente istruite hanno migliori prospettive matrimoniali: esisterebbe pertanto un marriage education premium che è forse tanto importante quanto lo skill premium, ossia il differenziale di retribuzione garantito a chi ha studiato. Mentre questo premio salariale non ha, in linea di principio, connotazioni di genere, il marriage education premium è, secondo gli autori, molto più alto per le donne. Alla base del fenomeno c’è probabilmente una maggiore «preferenza pura» per l’omogamia tra gli uomini perché, se non esistesse, l’aumento del livello di istruzione delle donne potrebbe essere, sul mercato dei matrimoni, tanto un deterrente quanto un’attrattiva.

Figura 2.4b. Percentuale di donne dai 20
ai 35 anni nel primo decile donne per reddito da lavoro che hanno
sposato uomini dai 20 ai 35 anni nel primo e nell’ultimo decile
uomini per reddito da lavoro, 1970-2017.
Il campione per ciascuna indagine è composto da uomini e donne che
all’epoca (i) avevano tra 20 e 35 anni, (ii) erano sposati e (iii)
occupati (con guadagni positivi). Il numero di corrispondenze (dal
decile superiore degli uomini al decile superiore delle donne e
viceversa) è lo stesso nelle figure 2.4a e 2.4b, ma le percentuali
variano leggermente perché l’entità dei decili di uomini e donne
differiscono. Fonte:
Yonzan (2018), calcolato in base ai dati dello US Current
Population Survey:
https://www.census.gov/programs-surveys/cps.html.
Esiste un nesso ulteriore fra, da un lato, l’accoppiamento assortativo e, dall’altro, il rendimento crescente degli investimenti nella prole, che solo le coppie più istruite sono in grado di realizzare. Possono, per esempio, allevare i figli in un’atmosfera stimolante e favorevole all’apprendimento e coinvolgerli in esperienze culturali difficilmente alla portata di genitori meno istruiti (concerti, biblioteche, balletti), oltre che in sport elitari. Il fatto di collegare questi sviluppi apparentemente non correlati – istruzione delle donne, maggiore partecipazione di queste al mondo del lavoro, modelli di matrimonio assortativo, peso crescente dell’apprendimento nella prima infanzia – è fondamentale, in quanto chiarisce uno dei meccanismi chiave alla base della creazione della disuguaglianza all’interno della stessa generazione e della sua trasmissione intergenerazionale.
Se persone istruite, altamente qualificate e benestanti sono orientate a sposarsi fra loro, basterà questo, tendenzialmente, ad accentuare le disparità. Circa un terzo dell’aumento della disuguaglianza negli Stati Uniti fra il 1967 e il 2007 può essere spiegato con l’accoppiamento assortativo (Decancq, Peichl e Van Kerm 2013)30. Per i paesi dell’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), l’accoppiamento assortativo è responsabile in media dell’11 per cento dell’aumento delle disuguaglianze tra i primi anni Ottanta e i primi anni Duemila (Ocse 2011)31.
Ma se, in aggiunta a questo, cresce a dismisura il rendimento legato all’istruzione e all’apprendimento precoce dei figli, e se questi vantaggi iniziali sono alla portata solo di genitori altamente istruiti – che, come dimostrano i dati, trascorrono molto più tempo con i loro figli rispetto ai genitori che lo sono meno –, ecco che si spalancano le porte alla trasmissione intergenerazionale dei vantaggi e della disuguaglianza. Questo è vero anche se – ed è importante sottolinearlo – l’imposizione fiscale sulle successioni è elevata, perché il fatto di ereditare risorse finanziarie è solo uno dei vantaggi di cui godono i figli di genitori colti e ricchi. E in molti casi, può anche non essere la parte più importante. Anche se, come sosterrò nel paragrafo 2.4, l’imposizione fiscale sulle successioni è una politica particolarmente efficace per mettere tutti nelle stesse condizioni e aumentare le pari opportunità, è illusorio credere che le imposte in quanto tali possano bastare a garantire ai figli nati da genitori poveri le stesse opportunità di cui godono i figli dei ricchi.
2.2f. Maggiore trasmissione del reddito e della ricchezza attraverso le generazioni
Le profonde disparità di reddito e ricchezza negli Stati Uniti venivano un tempo giustificate con l’affermazione secondo cui tutti avevano la possibilità di diventare qualcuno, indipendentemente dalla famiglia di provenienza. Era il famoso «sogno americano», che poneva l’accento più sulle pari opportunità che non sulla parità dei risultati ottenuti32. Era un concetto dinamico e orientato al futuro. Quando parla di disparità di reddito, Schumpeter propone un’interessante metafora: possiamo immaginare la distribuzione dei redditi in un anno qualsiasi come analoga alla distribuzione degli ospiti che soggiornano a diversi piani di un hotel in cui più alto è il piano più lussuosa è la camera. Se i clienti si spostano da un piano all’altro, e se – analogamente – i loro figli non rimangono al piano in cui sono nati, un’istantanea di quali famiglie vivono a quali piani non ci dirà allora granché su quale sarà il piano che queste famiglie abiteranno in futuro, o la loro posizione nel lungo periodo. Allo stesso modo, la disparità di reddito o di ricchezza misurata in un determinato momento può darci un’idea fuorviante o esagerata dei veri livelli di disuguaglianza e può non tenere conto della mobilità intergenerazionale33.
L’idea del sogno americano continua a esercitare un forte impatto sia sull’immaginario popolare sia fra gli economisti. Tuttavia, da una decina d’anni a questa parte, ossia da quando è stato possibile accedere per la prima volta a dati pertinenti, ha cominciato a essere messa seriamente in discussione. Guardando a ventidue paesi di tutto il mondo, Miles Corak (2013) ha dimostrato che esiste una correlazione positiva fra un’elevata disuguaglianza in un qualsiasi anno e una forte correlazione tra i redditi dei genitori e dei figli (cioè, la bassa mobilità di reddito). Questo risultato ha senso, perché un’elevata disuguaglianza oggi implica che i figli dei ricchi avranno, rispetto ai figli dei poveri, opportunità molto maggiori. Non solo potranno contare su un’eredità più consistente, ma avranno anche modo di beneficiare di una migliore istruzione, di un capitale sociale più elevato ottenuto dai genitori e di molti altri vantaggi immateriali portati dalla ricchezza. Nessuna di queste cose è alla portata dei figli dei poveri. Ma mentre il sogno americano è stato in qualche modo sgonfiato dalla consapevolezza che la mobilità di reddito è maggiore nei paesi più egualitari che non negli Stati Uniti, questi risultati non implicano che la mobilità intergenerazionale sia peggiorata nel tempo.
Il calo della mobilità relativa
Ricerche recenti dimostrano tuttavia che la mobilità intergenerazionale è di fatto in calo. Utilizzando un campione di coppie genitore-figlio e genitore-figlia, e confrontando una coorte di nati fra il 1949 e il 1953 con una di nati fra il 1961 e il 1964, Jonathan Davis e Bhashkar Mazumder (2017) hanno evidenziato una mobilità intergenerazionale significativamente inferiore per quest’ultima coorte. Gli autori hanno utilizzato due indicatori comuni di mobilità intergenerazionale relativa: il rank to rank (la correlazione fra le posizioni di reddito relativo di genitori e figli) e l’elasticità intergenerazionale dei redditi (la correlazione tra i redditi dei genitori e quelli dei figli)34. Entrambi gli indicatori hanno evidenziato un aumento nel tempo della correlazione fra il reddito dei genitori e quello dei figli (da 0,22 a 0,37 per le figlie e da 0,17 a 0,36 per i figli, mentre l’elasticità intergenerazionale dei redditi è passata da 0,28 a 0,52 per le figlie e da 0,13 a 0,43 per i maschi). Per entrambi gli indicatori, la svolta si è verificata nel corso degli anni Ottanta, lo stesso periodo in cui le disparità di reddito negli Stati Uniti hanno cominciato ad aumentare. In realtà, si sono verificati in contemporanea tre cambiamenti: l’aumento delle disuguaglianze, l’aumento del rendimento degli investimenti negli studi e l’aumento della correlazione fra il reddito dei genitori e quello dei figli. Vediamo quindi che non solo tra i paesi, ma anche nel tempo, le maggiori disuguaglianze di reddito e la minore mobilità intergenerazionale tendono ad andare di pari passo.
Abbiamo esaminato finora solo la mobilità relativa. Dobbiamo considerare anche la mobilità intergenerazionale assoluta, cioè la variazione del reddito reale fra le generazioni. Anche in questo caso si assiste a una diminuzione: la mobilità assoluta negli Stati Uniti è calata in maniera significativa tra il 1940 e gli anni Duemila, a causa di un rallentamento della crescita economica associato all’aumento delle disuguaglianze (Chetty et al. 2017b)35. Occorre tenere presente che la mobilità assoluta è molto diversa dalla mobilità relativa, in quanto dipende in massima parte dall’andamento del tasso di crescita. Per esempio, la mobilità assoluta può essere positiva per tutti se il reddito di ogni figlio supera quello dei genitori, anche se le posizioni dei genitori e dei figli nella distribuzione del reddito sono esattamente le stesse. In questo esempio, la piena mobilità intergenerazionale assoluta coinciderebbe con una totale mancanza di mobilità intergenerazionale relativa. In questo libro faccio riferimento più alla mobilità relativa che non a quella assoluta perché riflette meglio le caratteristiche sistemiche di un’economia.
2.3. Nuove politiche sociali
In questo paragrafo prendo in esame nuove politiche sociali rispetto al capitale e al lavoro, e la pressione sullo stato sociale in regime di globalizzazione36.
2.3a. Perché gli strumenti del Novecento non sono adatti a risolvere le disparità di reddito del xxi secolo
Il periodo straordinario in cui le disparità di reddito e di ricchezza nei paesi ricchi si erano ridotte, e che è durato approssimativamente dalla fine della Seconda guerra mondiale ai primi anni Ottanta, poggiava su quattro pilastri: sindacati forti, istruzione di massa, un’imposizione fiscale elevata e cospicui trasferimenti sociali. Da quando, circa quarant’anni fa, le disparità di reddito hanno cominciato a crescere, si è cercato di arginarne l’ulteriore aumento potenziando questi pilastri, o alcuni di essi, o almeno auspicando che ciò accadesse. Questo approccio, tuttavia, non funzionerà nel xxi secolo. Ma perché?
Consideriamo prima di tutto i sindacati. La riduzione nel numero degli iscritti, che si è verificata in tutti i paesi ricchi ed è stata particolarmente drastica nel settore privato, non è solo il prodotto di politiche di governo ostili. Anche l’organizzazione del lavoro è cambiata. Il passaggio dalla produzione manifatturiera ai servizi e dalla presenza forzata in fabbrica o negli uffici al telelavoro ha portato al moltiplicarsi di unità operative relativamente piccole, spesso non ubicate fisicamente nello stesso luogo. Coordinare persone sparpagliate in varie sedi è molto più difficile che non organizzare le maestranze di un unico grande stabilimento, che interagiscono continuamente tra loro e condividono lo stesso ambiente sociale e gli stessi interessi in materia di retribuzione e condizioni di lavoro. Inoltre, il deterioramento del ruolo dei sindacati riflette il diminuito potere contrattuale del lavoro nei confronti del capitale, risultato della massiccia espansione del bacino di manodopera disponibile nei sistemi capitalistici a partire dalla fine della guerra fredda e a seguito del reinserimento della Cina nell’economia mondiale. Sebbene quest’ultimo evento sia stato uno shock una tantum, i suoi effetti si faranno sentire almeno per diversi decenni e potrebbero essere accentuati dai futuri alti tassi di crescita demografica in Africa, con il risultato di mantenere inalterata l’abbondanza relativa di manodopera.
Passando al secondo pilastro, l’istruzione di massa, vediamo che è stato uno strumento per la riduzione delle disuguaglianze in Occidente nel periodo in cui il numero medio di anni di istruzione è passato dai quattro-otto degli anni Cinquanta ai tredici o più di oggi. Ciò ha portato a una riduzione del premio alle competenze del capitale umano (skill premium), cioè del divario salariale tra chi ha una formazione universitaria e chi non ce l’ha. A metà degli anni Settanta, convinto che l’offerta di lavoratori altamente qualificati sarebbe rimasta abbondante, l’olandese Jan Tinbergen – primo economista a ricevere il Nobel per le Scienze economiche – prevedeva che alla fine del secolo il premio per le competenze si sarebbe ridotto quasi a zero, e che la corsa fra la tecnologia che crea una domanda di lavoratori sempre più qualificati e l’offerta sarebbe stata vinta da quest’ultima37.
Ma un’ulteriore espansione di massa dell’istruzione è impossibile quando in un paese il percorso scolastico medio ha raggiunto quattordici o quindici anni, per il semplice fatto che il livello massimo di istruzione è limitato dall’alto, vincolato non solo dal numero di anni di studio, ma anche in termini di vantaggio cognitivo. Quando si entra in un periodo di transizione dall’istruzione elitaria a quella di massa, com’è accaduto nella maggior parte dei paesi occidentali nella seconda metà del Novecento, i vantaggi in termini di conoscenze acquisite attraverso un’istruzione più lunga e migliore sono enormi. Ma quando, nella maggior parte dei casi, le persone sono andate a scuola quanto desiderano e hanno imparato ciò a cui sono interessate o che sono in grado di apprendere, la società raggiunge un picco in materia di istruzione che non è possibile superare: la tecnologia, alla fine, vince la corsa con l’istruzione. Pertanto, non possiamo fare affidamento su piccoli incrementi del livello medio di istruzione per garantire l’effetto equilibratore sui salari che un tempo è stato prodotto dall’istruzione di massa.
L’elevata imposizione fiscale sui redditi correnti e i cospicui trasferimenti sociali hanno costituito il terzo e quarto pilastro della riduzione delle disparità di reddito nel xx secolo. Ma è politicamente difficile aumentarli ulteriormente, e questo per due ragioni principali. Con la globalizzazione e la maggiore mobilità del capitale e del lavoro, l’aumento delle imposte potrebbe portare sia il capitale sia i lavoratori altamente qualificati a lasciare il paese alla ricerca di giurisdizioni con livelli di imposizione più bassi, e quindi a una perdita di gettito fiscale per il paese di provenienza38. La seconda ragione risiede in una visione scettica circa il ruolo dello Stato e delle politiche fiscali e di trasferimento che oggi è molto più diffusa tra le classi medie in tanti paesi ricchi rispetto a mezzo secolo fa. Questo non significa che la gente non sappia che senza un’imposizione fiscale più elevata i sistemi di previdenza sociale, l’istruzione gratuita e le moderne infrastrutture crollerebbero. Ma le persone sono scettiche circa i vantaggi che si potrebbero trarre da ulteriori aumenti delle imposte sul reddito corrente, e difficilmente si esprimerebbero favorevolmente al riguardo.
Limiti dei risultati che si possono ottenere attraverso imposte e trasferimenti
Per illustrare che cosa si può fare utilizzando i vecchi strumenti di ridistribuzione attraverso il tax and transfer, consideriamo gli esempi degli Stati Uniti e della Germania dell’ultimo mezzo secolo, mostrati nella figura 2.5. Prendiamo innanzitutto le linee relative alla disuguaglianza del reddito di mercato, che misura la disuguaglianza del reddito al lordo delle imposte e dei trasferimenti. In entrambi i paesi (come in quasi tutti i paesi ricchi), le disparità del reddito di mercato sono aumentate drasticamente, a causa dei fattori discussi in precedenza. L’aumento in Germania è stato ancora più marcato che negli Stati Uniti. La linea mediana in entrambi i grafici mostra la disuguaglianza del reddito lordo, ossia il livello di disuguaglianza che esiste dopo aver tenuto conto dei trasferimenti (come le pensioni pubbliche e le prestazioni sociali), mentre la linea inferiore mostra la disuguaglianza del reddito disponibile, dopo aver incluso anche gli effetti delle imposte dirette. Se i policy maker o il legislatore vogliono ridurre le disuguaglianze a livello di reddito disponibile, devono aumentare le imposte e i trasferimenti o renderli più progressivi.
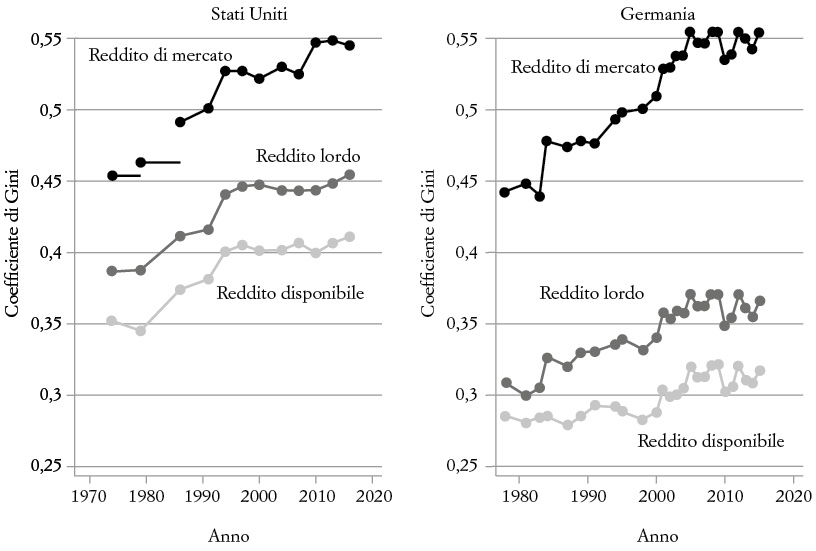
Figura 2.5. Disparità di reddito di mercato,
reddito lordo e reddito disponibile in Stati Uniti (1974-2016) e
Germania (1978-2015).
Il reddito di mercato comprende i salari e le altre retribuzioni
connesse all’occupazione, i redditi patrimoniali e i redditi da
lavoro autonomo. Il reddito lordo è uguale al reddito di mercato
più i trasferimenti sociali in contanti come le pensioni pubbliche,
le indennità di disoccupazione e le prestazioni sociali (come i
buoni pasto, negli Stati Uniti, oggi denominati Snap). Il reddito
disponibile è uguale al reddito lordo meno le imposte dirette. Le
prestazioni in natura fornite dallo Stato (sanità e istruzione) non
sono incluse. Tutti i calcoli sono eseguiti su base pro capite
(ossia gli indici di Gini sono calcolati fra i redditi pro capite
delle famiglie). Fonte: Calcoli effettuati in
base ai dati del Luxembourg Income Study
(https://www.lisdatacenter.org).
La Germania è quasi riuscita a compensare l’aumento della disparità di reddito di mercato; la disuguaglianza nel reddito disponibile (la linea inferiore) evidenzia solo un aumento modesto dall’inizio degli anni Ottanta. Ciò è stato possibile con i grandi trasferimenti sociali (si noti l’aumento del divario tra la linea superiore e quella centrale) e, in misura minore, grazie a un’imposizione fiscale più elevata o più progressiva (il divario fra la linea centrale e quella inferiore è rimasto pressoché invariato dal 1990). La ridistribuzione del reddito negli Stati Uniti, al contrario, è diventata lievemente più progressiva, cosicché la disuguaglianza del reddito disponibile è aumentata di un importo simile alla disuguaglianza del reddito di mercato (come dimostrano i movimenti paralleli della linea superiore e inferiore). Questo confronto dimostra che la politica può fare la differenza, ma ne evidenzia anche i limiti. Trasferimenti più consistenti e imposte dirette più elevate possono neutralizzare le maggiori disuguaglianze di fondo. Ma se questa disuguaglianza di fondo ha la tendenza a continuare ad aumentare, questa politica deve opporsi a venti contrari sempre più forti. A un certo punto, l’effetto dei vecchi strumenti di ridistribuzione rischia di essere vanificato.
L’utopia libertaria di uno Stato poco invasivo è realizzabile solo con politiche protocomuniste
Se la disuguaglianza è destinata ad aumentare e se i vecchi strumenti impiegati per combatterla non funzioneranno più, quali dovremmo utilizzare ora? Qui non solo dobbiamo pensare fuori dagli schemi per trovarne altri, ma occorre che ci poniamo un obiettivo del tutto nuovo: dobbiamo puntare a un capitalismo egualitario basato su una dotazione di capitale e di competenze più o meno uguale per tutta la popolazione.
Questa forma di capitalismo genererebbe risultati egualitari anche senza grandi ridistribuzioni di reddito. Se i ricchi avessero solo il doppio delle unità di capitale e il doppio delle unità di competenza rispetto ai poveri, e se i rendimenti per unità di capitale e competenza fossero approssimativamente uguali, allora la disuguaglianza complessiva non potrebbe essere più di due a uno. Tornando alla figura 2.5, una perequazione delle dotazioni inciderebbe direttamente sulla disuguaglianza di mercato sottostante: ciò rallenterebbe e addirittura invertirebbe l’aumento della linea superiore, al punto tale che l’entità della ridistribuzione (il divario tra la linea superiore e le due linee inferiori) potrebbe addirittura diminuire senza incidere sulla disuguaglianza complessiva del reddito disponibile. L’esempio più vicino al mondo reale è quello di Taiwan, dove la distribuzione dei redditi da lavoro e da capitale è nettamente più egualitaria che in qualsiasi altro paese ricco (vedi figura 2.2) e dove, di conseguenza, il livello di disuguaglianza del reddito disponibile è simile a quello del Canada, un risultato ottenuto con una ridistribuzione minima. Per portare l’esempio fino all’estremo, consideriamo un mondo immaginario con dotazioni di capitale e lavoro assolutamente uguali: la disuguaglianza del reddito di mercato sarebbe pari a zero, e non occorrerebbe alcuna ridistribuzione; anche la disuguaglianza del reddito disponibile sarebbe pari a zero39.
Ma come rendere meno iniqua la distribuzione delle dotazioni di capitale e competenze? Per quanto riguarda il capitale, lo si potrebbe fare deconcentrando la proprietà dei beni. Per quanto riguarda il lavoro, si dovrebbero perequare i rendimenti a livelli di abilità più o meno analoghi. Nel caso del capitale, la disuguaglianza si ridurrebbe perequando l’insieme delle dotazioni; nel caso del lavoro, si ridurrebbe principalmente perequando i rendimenti dell’istruzione40.
Deconcentrazione della proprietà di capitali
Cominciamo dal capitale. Come abbiamo visto nel sottoparagrafo 2.2b, in tutti i paesi avanzati, la concentrazione dei redditi patrimoniali è rimasta a un livello incredibilmente elevato dagli anni Settanta. Questo è uno dei motivi principali per cui l’aumento continuo del potere relativo del capitale rispetto al lavoro e l’aumento della quota del capitale nella produzione netta si sono tradotti direttamente, e continueranno a farlo, in una maggiore disuguaglianza interpersonale.
Le politiche nazionali possono non essere in grado di influenzare la ripartizione del reddito netto totale fra capitale e lavoro (poiché questa tendenza è spesso alimentata dal progresso tecnologico e dalla globalizzazione), ma possono sicuramente influenzare la distribuzione della proprietà del capitale fra gli individui all’interno dei confini nazionali. Con una minore concentrazione della proprietà del capitale, un aumento della quota del capitale nel reddito netto non deve necessariamente portare a una maggiore disuguaglianza tra i singoli individui. L’aumento delle disuguaglianze interpersonali potrebbe essere frenato o contrastato del tutto.
I metodi per ridurre la concentrazione del capitale non sono né nuovi né sconosciuti, ma non sono mai stati utilizzati in modo serio e coerente. Possiamo dividerli in tre gruppi. In primo luogo, si potrebbero avviare politiche fiscali favorevoli per rendere la partecipazione azionaria più attraente per i piccoli e medi azionisti e meno per quelli grandi (una politica esattamente all’opposto di quanto accade oggi negli Stati Uniti). Attualmente, la classe media detiene un volume relativamente limitato di attività finanziarie che, nel lungo periodo, registrano rendimenti migliori rispetto all’edilizia abitativa. Se vogliamo contribuire a perequare i rendimenti della classe media e quelli dei ricchi, ne consegue che il ceto medio dovrebbe essere incoraggiato a detenere più azioni e obbligazioni. Un’obiezione comune a questa proposta è che i piccoli investitori sono avversi al rischio, in quanto anche un piccolo rendimento negativo può far volatilizzare gran parte del loro patrimonio finanziario. Questo è vero, ma esistono modi per migliorare i proventi che potrebbero ottenere, garantendo una minore volatilità. Molti dei vantaggi fiscali di cui attualmente possono usufruire solo gli investitori importanti potrebbero essere estesi anche ai piccoli o, meglio ancora, se ne potrebbero introdurre di nuovi studiati appositamente per loro. Una minore volatilità e una maggiore sicurezza degli investimenti potrebbero essere assicurate da un sistema garantito dallo Stato attraverso l’introduzione di una soglia minima (per esempio di rendimento reale pari a zero) per determinate classi di investimenti di modesta entità. I piccoli investitori potrebbero avvalersi di tale garanzia su base annua al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi41.
Un secondo gruppo di metodi consiste nel promuovere, attraverso appositi piani, la partecipazione azionaria dei dipendenti nelle aziende in cui lavorano (Esop, Employee Stock Ownership Plan) o nel promuovere altri incentivi a livello aziendale finalizzati a questo scopo. A tal proposito, esistono già norme giuridiche negli Stati Uniti e in molti altri paesi. Nemmeno questa è un’idea nuova. Nel 1919, Irving Fisher la presentò nel suo discorso presidenziale di fronte alla American Economic Association (Fisher 1919, p. 13); negli anni Ottanta, Margaret Thatcher parlò allo stesso modo del «capitalismo popolare». Tuttavia, dopo un periodo di relativo successo negli anni Ottanta, i piani Esop sono caduti nell’oblio. Quando si utilizza questo genere di schemi partecipativi, in genere ciò avviene più per fornire incentivi al top management che non per istituire una qualche forma di capitalismo dei lavoratori. L’obiezione a questa idea è che i lavoratori preferirebbero diversificare, anziché ricevere un salario e un reddito da capitale entrambi legati all’andamento di una particolare azienda; raccoglierebbero risultati migliori se «investissero» la loro capacità lavorativa in un’azienda e il capitale in altre società, in titoli di Stato o in proprietà immobiliari. Questo argomento, in teoria, è corretto. Ferme restando tutte le altre condizioni, ha più senso investire il proprio patrimonio in aziende diverse da quella in cui si è impiegati. Tuttavia, la maggior parte delle persone non possiedono praticamente nessuna attività finanziaria, quindi tengono comunque tutte le uova nello stesso paniere: quello dell’azienda in cui lavorano. Se la classe media avesse maggiori opportunità di investire in capitale finanziario, gli Esop potrebbero essere una strategia inadeguata. Ma fintanto che le opportunità di investire con profitto piccoli importi rimarranno limitate, gli Esop hanno senso come primo passo verso una proprietà patrimoniale meno concentrata42.
In terzo luogo, un’imposta di successione o una patrimoniale potrebbero essere un mezzo per pareggiare l’accesso al capitale se il gettito fiscale fosse utilizzato per concedere una sovvenzione in conto capitale a ogni giovane adulto. Questa proposta è stata avanzata da Atkinson (2015) e Meade (1964). Un’imposta di successione presenta, in linea di principio, molti vantaggi. Influisce meno sulle decisioni riguardanti il lavoro o gli investimenti rispetto alle imposte calcolate sul reddito, e rappresenta un’imposta sulla ricchezza (non guadagnata) ricevuta dalle generazioni future. Inoltre, la perpetuazione dell’alta borghesia è resa possibile dalla sua capacità di trasferire ingenti quantità di beni, spesso in esenzione fiscale, da una generazione all’altra. Pertanto, un’imposta di successione ha anche un ruolo importante da svolgere nel ridurre il divario di opportunità.
È importante collocare l’imposta di successione in un contesto intellettuale e ideologico. John Rawls, nella sua tassonomia delle varie uguaglianze, introduce l’imposta sulle eredità come primo (e più basso) complemento all’uguaglianza davanti alla legge (1971, p. 57). Nel più basso stato di uguaglianza di Rawls, non esistono vincoli legali tali per cui le persone non possano raggiungere la stessa posizione nella vita. Questo livello di uguaglianza soddisfa il primo principio di giustizia di Rawls, ovvero che tutti hanno la stessa libertà politica, a prescindere dalla classe economica o sociale di appartenenza. Questo è il sistema della libertà naturale di Rawls, o «capitalismo meritocratico». Nella seconda metà dell’Ottocento in Europa, in Russia e nelle Americhe, e dopo l’indipendenza indiana e la Rivoluzione cinese a metà del Novecento, il mondo intero ha cominciato a operare in un sistema di libertà naturale. Da allora i paesi si sono mossi, in varia misura, in una direzione che soddisfa il secondo principio di giustizia di Rawls, vale a dire l’uguaglianza delle opportunità. Il raggiungimento delle pari opportunità richiede l’applicazione di correttivi allo scopo di compensare i vantaggi di cui godono le persone nate nelle famiglie «giuste» o con le abilità genetiche «giuste». La correzione non potrà mai essere completa perché comporterebbe la compensazione delle differenze di talento e dei vantaggi immateriali di cui godono i bambini nati in famiglie più ricche o più istruite. Ma aggiustamenti significativi sono possibili e la prima politica correttiva che Rawls introduce è la tassazione delle successioni che, associata all’istruzione gratuita, ci porta al sistema di uguaglianza liberale di Rawls (quello che in questo libro chiamo «capitalismo liberale»). Pertanto, l’imposta di successione, di per sé auspicabile (secondo Rawls e altri che hanno a cuore il concetto di pari opportunità), può essere utilizzata anche per ridurre la concentrazione della ricchezza se i proventi vengono distribuiti a tutti i cittadini. Si tratta quindi di un’imposta auspicabile per due motivi: l’uguaglianza attuale e le opportunità future43.
È un peccato che le imposte di successione siano diminuite nella maggior parte delle economie avanzate. Anche in paesi che le prevedono e in cui l’aliquota d’imposta marginale è elevata (per esempio, Giappone e Corea del Sud, con aliquote marginali del 50 per cento, e Regno Unito, Francia e Stati Uniti, con aliquote marginali del 40-45 per cento), il gettito delle imposte ha subìto una drastica riduzione a causa di quote esenti molto elevate (cioè il livello al di sotto del quale le successioni non vengono tassate). Negli Stati Uniti la quota esente era di 675.000 dollari nel 2001, ma è stata portata a 5,49 milioni di dollari nel 2017 (22 milioni di dollari per una coppia sposata). Caroline Freund (2016, p. 174) sottolinea, parlando degli Stati Uniti, che «nel 2001, le entrate derivanti dall’imposta sulle successioni e le donazioni avrebbero potuto finanziare 14 volte il costo del programma governativo di aiuti alimentari alle famiglie bisognose. Nel 2011 le entrate avrebbero potuto coprirne solo due terzi». Un’imposta di successione indebolita, ridotta dall’innalzamento della quota esente e da aliquote marginali progressivamente più basse, non può fare granché ai fini della realizzazione dell’obiettivo per il quale era stata pensata, e cioè assicurare parità di condizioni a tutti i soggetti. Per tornare alla classificazione dell’uguaglianza di Rawls, sembra che molti paesi potrebbero fare marcia indietro anche sull’uguaglianza liberale e tornare a un semplice sistema di libertà naturale, che garantisce l’uguaglianza davanti alla legge ma non l’uguaglianza di opportunità.
Parità di accesso allo stesso livello di istruzione
Dopo aver parlato di come equiparare le dotazioni di capitale, ci occupiamo ora del lavoro. In una società ricca e ben istruita, il problema non è solo quello di rendere l’istruzione più accessibile, ma di parificare il rendimento dell’investimento negli studi fra persone con lo stesso livello di istruzione. La disuguaglianza salariale non è più dovuta solo alle differenze riconducibili al numero di anni di studio dei singoli individui (scarto che probabilmente si ridurrà ancora). Oggi, le differenze di retribuzione (a parità di numero di anni di studio, esperienza e altre variabili rilevanti) sono alimentate anche dalle differenze di qualità – percepite o reali – delle diverse scuole. Il modo per ridurre questa disuguaglianza è uniformare gli standard di insegnamento tra i diversi istituti. Negli Stati Uniti, e sempre più spesso in Europa, ciò richiederebbe un miglioramento della qualità delle scuole statali, obiettivo realizzabile solo con grandi investimenti nell’istruzione pubblica e con l’abolizione di numerosi vantaggi (tra cui l’esenzione fiscale) di cui godono le università e le scuole secondarie private, molte delle quali dispongono di dotazioni finanziarie enormi44. Se non si ripristina una situazione di pari opportunità fra le scuole private e quelle pubbliche, un semplice aumento del numero di anni di studio o l’ammissione di alcuni studenti di famiglie di ceto medio-basso nelle università d’élite non ridurranno le disuguaglianze nel reddito da lavoro né daranno garanzie di pari opportunità.
2.3b. Lo stato sociale nell’era della globalizzazione
Affermare che lo stato sociale è sotto pressione per gli effetti della globalizzazione e delle migrazioni è ormai un’ovvietà. Tornare alle origini del welfare state sarà utile per comprendere la natura di questo stress.
Come ci hanno recentemente ricordato Avner Offer e Gabriel Söderberg nel loro libro The Nobel Factor (2016), la socialdemocrazia e lo stato sociale sono nati dalla consapevolezza che tutti gli individui attraversano periodi in cui, pur non guadagnando nulla, devono comunque continuare a consumare. Ciò vale per i giovani (da qui le prestazioni a favore dei bambini), i malati (assistenza sanitaria e indennità di malattia), chi si fa male al lavoro (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), i neogenitori (congedo parentale), le persone che perdono il lavoro (indennità di disoccupazione) e gli anziani (pensioni). Lo stato sociale è nato per fornire queste prestazioni, erogate sotto forma di assicurazione contro il verificarsi di condizioni inevitabili o molto comuni, ed è stato costruito su una presunta comunanza di comportamenti o, in altre parole, di omogeneità culturale e spesso etnica. Non è un caso che il prototipo di welfare state, nato nel mondo omogeneo della Svezia degli anni Trenta, presentasse molti elementi del nazionalsocialismo (non usato qui in senso peggiorativo).
Oltre a dipendere da comportamenti ed esperienze comuni, lo stato sociale, per essere sostenibile, richiede una partecipazione di massa. La previdenza sociale non può essere applicata solo a una piccola parte della forza lavoro, perché questo porterebbe naturalmente a una selezione avversa, un punto ben illustrato dalle infinite lotte sulla copertura sanitaria negli Stati Uniti. Se fosse possibile aderire al sistema su base volontaria, chiunque ritenesse di non aver bisogno dell’assicurazione (per esempio i ricchi, chi difficilmente potrà perdere il lavoro, o le persone in buona salute) preferirebbe uscirne, per evitare di sovvenzionare gli «altri». Un meccanismo basato solo sugli «altri» è insostenibile a causa degli enormi premi che andrebbe a comportare. Pertanto, lo stato sociale può funzionare solo quando copre tutta la forza lavoro, o quasi, o tutti i cittadini.
La globalizzazione erode questi requisiti. La globalizzazione del commercio ha portato, nella maggior parte dei paesi occidentali, a una contrazione del ceto medio e del reddito relativo. Si è prodotta così una polarizzazione del reddito, ossia ci sono più persone ai due estremi della distribuzione del reddito e meno intorno alla mediana45. Con la polarizzazione del reddito, i ricchi si rendono conto della convenienza di creare un loro sistema privato, in quanto condividere un sistema di massa con chi è sostanzialmente più povero e va incontro a rischi diversi (come una maggiore probabilità di trovarsi disoccupato o di sviluppare determinate patologie) porterebbe a notevoli trasferimenti di reddito da parte dei ricchi. I sistemi privati garantiscono a questi ultimi anche una migliore qualità (per unità di spesa) in quanto consentono di risparmiare sui tipi di rischi che loro non devono affrontare. Se tra le classi abbienti pochissimi fumano o soffrono di obesità, chi ne fa parte non sarà incentivato a contribuire all’assistenza sanitaria nei confronti di fumatori o persone in sovrappeso. In questo modo si crea un sistema di separatismo sociale che si riflette nell’importanza crescente delle iniziative private nell’ambito delle assicurazioni sanitarie, dell’istruzione e delle pensioni46. Una volta creati questi sistemi privati, i ricchi sono sempre più restii a pagare imposte elevate, dal momento che ne traggono scarso beneficio. Questo porta di conseguenza all’erosione della base imponibile. Il punto fondamentale è che una società fortemente ingiusta, o polarizzata, non può facilmente mantenere uno stato sociale inclusivo.
Migrazioni e stato sociale
Le migrazioni economiche, altro aspetto della globalizzazione a cui la maggior parte delle società ricche sono state esposte negli ultimi cinquant’anni – e alcune di esse, soprattutto in Europa, per la prima volta in assoluto –, sono un altro dei fattori che indeboliscono il sostegno allo stato sociale. Questo avviene attraverso l’inclusione nel sistema del welfare di persone che osservano norme sociali, comportamenti o hanno esperienze di vita che sono o vengono percepiti come diversi. I nativi e i migranti possono avere comportamenti e preferenze differenti; un divario simile può anche esistere fra gruppi diversi di nativi. Negli Usa, la mancanza percepita di «affinità» fra la maggioranza bianca e gli afroamericani ha eroso lo stato sociale statunitense rispetto ai paesi europei (Kristov, Lindert e McClelland 1992). Lo stesso processo è attualmente in corso in Europa, dove grandi sacche di immigrazione non sono state assimilate e la popolazione autoctona ritiene che gli stranieri ricevano benefici a cui non hanno diritto. Il fatto che i nativi sentano una mancanza di affinità non deve essere interpretato come discriminatorio. Talvolta può trattarsi, in effetti, di discriminazione, ma spesso questo pregiudizio può anche affondare le proprie radici nell’evidenza che difficilmente, nel corso della loro vita, determinate persone dovranno affrontare eventi della stessa natura o con la stessa frequenza così come accade ad altri, e per questo non sono propense a contribuire economicamente ad assicurazioni contro tali eventi. Negli Stati Uniti, il fatto che gli afroamericani abbiano maggiori probabilità di restare disoccupati o di finire in carcere ha probabilmente portato i bianchi a concedere indennità di disoccupazione meno generose e a favorire l’esistenza di un sistema penitenziario spesso disfunzionale. Analogamente, il fatto che gli immigrati tendano ad avere un numero di figli maggiore dei nativi potrebbe portare, in Europa, a riduzioni dei sussidi destinati ai bambini. In ogni caso, le differenze nell’aspettativa di vita compromettono l’omogeneità necessaria per uno stato sociale sostenibile.
Inoltre, nell’era della globalizzazione, gli stati sociali più sviluppati possono sperimentare l’effetto perverso di attrarre migranti meno qualificati o meno ambiziosi. A parità di altre condizioni, la decisione di un migrante su dove dirigersi dipenderà dal reddito atteso in un paese rispetto a un altro. In linea di principio, si dovrebbero preferire i paesi più ricchi. Ma dobbiamo anche considerare il punto di vista dei migranti a proposito di dove andrebbero a collocarsi nella distribuzione del reddito del paese ospite. Un migrante che preveda di posizionarsi nella parte bassa della distribuzione del reddito, magari per mancanza di competenze o di ambizione, potrebbe essere incline a scegliere un paese più ugualitario e con un sistema di welfare più inclusivo. Un migrante che si prefigga di raggiungere la fascia superiore della distribuzione del reddito nel paese di destinazione farebbe il calcolo opposto. Da qui la selezione avversa tra i migranti che scelgono i paesi con un welfare più sviluppato.
La figura 2.6 mostra empiricamente, sulla base dei calcoli elaborati per 118 paesi nel 2008 (Milanovic 2015), quanto valga la parità di reddito per i migranti a seconda di dove immaginano di collocarsi nella distribuzione del reddito del paese di destinazione. I risultati della figura devono essere interpretati come segue. Se i migranti sono pessimisti o poco qualificati e si aspettano di collocarsi nel 5 per cento dei più poveri (il ventile più basso) del paese di destinazione, il loro reddito sarà lo stesso se scelgono un paese che è più povero dell’8 per cento in termini di Pil pro capite ma con una disuguaglianza di 1 punto Gini inferiore a quella che si avrebbe se andassero in un paese più ricco ma con maggiori disuguaglianze, come evidenziato al punto A. Per il secondo ventile della figura 2.6, una maggiore uguaglianza varrà lievemente meno – circa il 5 per cento del reddito – e così via. I migranti che si aspettano di finire nel sedicesimo ventile o ancora più in alto nel paese di destinazione preferiranno invece paesi con maggiori disuguaglianze, poiché a quel punto le disuguaglianze si trasformano per loro in un vantaggio. Per questi migranti ottimisti o altamente qualificati, la disuguaglianza è un fattore positivo, e potranno essere inclini ad accettare di emigrare in un paese più povero a condizione che sia caratterizzato da una maggiore disuguaglianza. Per esempio, queste persone potrebbero ritenere preferibile emigrare in Colombia anziché in Svezia, anche se la Colombia è più povera. Poiché si aspettano di risalire nella distribuzione del reddito del paese ospite, attribuiranno maggiore importanza alla disuguaglianza del paese piuttosto che al suo reddito medio.
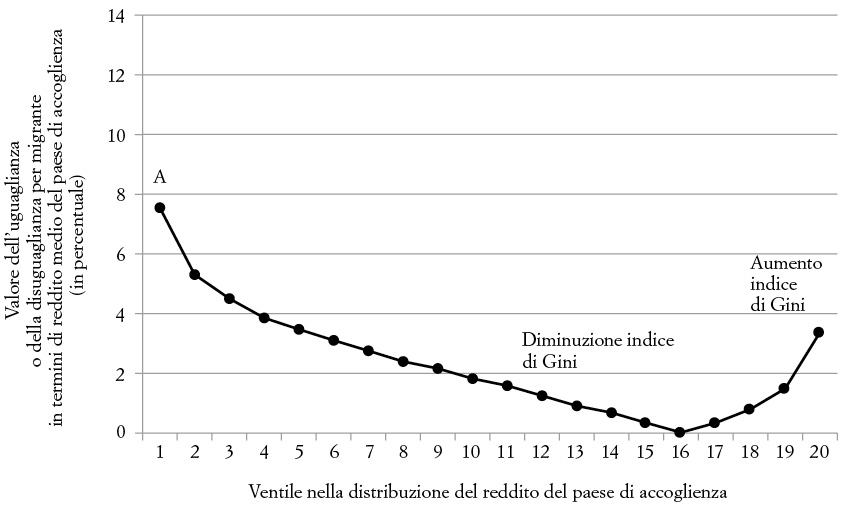
Figura 2.6. Compromesso (trade-off) per i migranti fra
uguaglianza dei redditi e reddito medio del paese di
accoglienza.
Il grafico mostra quanto vale per un migrante, in percentuale del
reddito medio del paese ricevente, un paese con una distribuzione
del reddito più equa (indice di Gini più basso) (se un migrante
prevede di collocarsi nelle fasce più basse della distribuzione del
reddito del paese ospite), o più disuguale (indice di Gini più
alto) (se un migrante prevede di posizionarsi nelle fasce più alte
della distribuzione del reddito del paese ricevente). In altre
parole, per i migranti che prevedono di collocarsi fra il primo e
il sedicesimo ventile della distribuzione del reddito del paese
ricevente, può essere consigliabile orientarsi verso un paese più
povero in cui la disuguaglianza di reddito è minore (per esempio la
Svezia) che non verso uno più ricco (per esempio gli Stati Uniti)
in cui la disuguaglianza è maggiore. È vero il contrario per i
migranti che prevedono di andarsi a collocare nei quattro ventili
superiori della distribuzione del reddito del paese ospite.
Fonte: Ricalcolato
sulla base di Milanovic (2015).
Il contrario, come abbiamo visto, vale per i migranti pessimisti o poco qualificati che prevedono di collocarsi ai livelli più bassi nella distribuzione del reddito del paese di destinazione: essi tenderanno infatti a scegliere paesi caratterizzati da una maggiore equità. Per questo motivo, potrebbe verificarsi un fenomeno di selezione avversa di migranti pessimisti che si trasferiscono in paesi con reti di sicurezza sociale più sviluppate. Se i migranti più pessimisti sono effettivamente meno ambiziosi o meno qualificati, i paesi ricchi con sistemi avanzati di previdenza sociale tenderanno ad attrarre il tipo di migranti «sbagliato»47. L’esistenza di una tale dinamica di selezione avversa è documentata da Akcigit, Baslandze e Stantcheva (2015), i quali dimostrano come gli inventori (che presumibilmente si possono considerare altamente qualificati o molto ambiziosi) tendano a emigrare da giurisdizioni a elevato tasso di imposizione fiscale verso giurisdizioni a bassa tassazione, cioè verso luoghi con uno stato sociale meno sviluppato. Borjas (1987) ha evidenziato lo stesso risultato per gli Stati Uniti rispetto ai paesi di origine dei migranti: quelli provenienti da paesi caratterizzati da una maggiore equità economica rispetto agli Stati Uniti sono tendenzialmente più qualificati.
I paesi che si troverebbero ad affrontare i problemi peggiori sarebbero quelli con sistemi di welfare ben sviluppati e una bassa mobilità dei redditi. I migranti che si recano in questi paesi non si possono aspettare che i loro figli risalgano lungo la scala del reddito. In un circolo vizioso distruttivo, tali paesi attirerebbero i migranti meno qualificati o meno ambiziosi, che andrebbero a creare un sottoproletariato, limitando la mobilità verso l’alto dei loro figli. Un sistema del genere funziona come una profezia che si autoavvera: attira masse sempre maggiori di migranti non qualificati che non riescono ad assimilarsi. La popolazione autoctona tenderà a giudicare questi migranti carenti dal punto di vista delle competenze e delle ambizioni (il che, come ho appena detto, può anche essere vero) e quindi «diversi». Allo stesso tempo, il fatto di non sentirsi accettati come membri alla pari della comunità sarà sentito dai migranti come la conferma dei pregiudizi dei nativi contro gli stranieri o, peggio ancora, come una discriminazione etnica o religiosa.
I sistemi di welfare avanzati si trovano così di fronte a due tipi di selezione avversa, che si rafforzano a vicenda. Sul versante interno, la polarizzazione tra poveri e ricchi incoraggia le prestazioni private di servizi sociali e induce i ricchi a fuoriuscire volontariamente dal sistema dei servizi forniti dallo Stato esercitando l’opzione di opt out. In questo modo, rimangono nel sistema solo coloro i cui premi possono essere insostenibilmente elevati, e molti di essi possono abbandonare completamente il sistema. Sul piano internazionale, la selezione avversa funziona tramite l’ingresso di migranti poco qualificati, un processo che porta alla fuoriuscita (opt out) del nativo.
Non esiste una soluzione semplice al circolo vizioso che i paesi con un welfare avanzato devono affrontare in un’epoca di globalizzazione. Due importanti iniziative, tuttavia, potrebbero fare una grande differenza:
1. Il perseguimento di politiche che portino a una perequazione delle dotazioni, in modo da ridurre l’imposizione fiscale sui redditi correnti e le dimensioni dello stato sociale (come esposto nel sottoparagrafo 2.3a).
2. Un cambiamento radicale nella natura dell’immigrazione, in modo da renderla molto più affine a un movimento temporaneo dei lavoratori che non dia accesso automatico alla cittadinanza e all’intera gamma delle prestazioni sociali (come vedremo più in dettaglio nel capitolo 4).
2.4. L’alta borghesia si autoperpetua?
La formazione di un’alta borghesia durevole è impossibile a meno che questa classe non eserciti un controllo politico. Solo la politica, utilizzata a tale scopo, può garantire all’alta borghesia di restare al vertice.
In linea di principio, ciò dovrebbe essere impossibile in una democrazia; il diritto di voto appartiene a tutti, e la maggioranza dei cittadini ha interesse a garantire che i potenti e i ricchi non mantengano permanentemente il loro status. È stato tuttavia ampiamente dimostrato, e in maniera convincente, che i ricchi negli Stati Uniti esercitano sulla politica un’influenza sproporzionata. I politologi Martin Gilens (2012, 2015), Benjamin Page (con Gilens 2014), Christopher Achen e Larry Bartels (2017) hanno confermato empiricamente, per la prima volta nella storia, che i ricchi hanno più peso politico e che il regime è passato da essere una democrazia a diventare un’oligarchia; un sistema in cui, per usare la definizione di Aristotele, «i capi hanno il potere in forza della ricchezza»48. Dallo studio di Gilens (2015) è emerso per esempio che i membri del Congresso Usa hanno probabilità nettamente maggiori di discutere e votare su questioni di interesse per i ricchi che non su temi importanti solo per il ceto medio e i poveri49. Gilens conclude che i problemi del ceto medio hanno una probabilità di essere presi in considerazione solo se coincidono con ciò che interessa ai ricchi.
Questi risultati sono significativi non solo per la loro forza empirica e le implicazioni politiche, ma anche perché si applicano a una delle democrazie più consolidate del mondo, dove, per di più, la classe media è stata tradizionalmente considerata un elemento chiave sia nella politica sia nell’economia. Se il ceto medio, anche nella società che più di ogni altra al mondo gli è favorevole (almeno in termini di discorso ideologico), ha potere politico solo quando ha opinioni condivise dai ricchi, allora – da un punto di vista politico – la classe media e i poveri nel resto del mondo saranno probabilmente ancora meno rilevanti.
Ma come fanno i ricchi a controllare il processo politico in una democrazia? Non è una cosa facile da spiegare, non solo perché i ricchi non costituiscono giuridicamente un gruppo a parte con diritti speciali, ma anche perché i politici delle democrazie moderne non vengono selezionati automaticamente dagli strati privilegiati della popolazione. Si potrebbe obiettare che in passato, in condizioni che si avvicinavano solo approssimativamente al pieno suffragio universale, la classe politica era costituita principalmente da persone ricche, il che comportava una certa comunanza di opinioni, interessi condivisi e comprensione reciproca fra i politici e il resto della popolazione agiata. Ma non è questo il caso nelle democrazie di oggi: i politici provengono da classi sociali e background differenti, e molti di essi hanno sociologicamente molto poco, o talvolta nulla, in comune con i ricchi. Bill Clinton e Barack Obama negli Stati Uniti, Margaret Thatcher e John Major nel Regno Unito provenivano tutti da ambienti modesti, ma hanno sostenuto con una certa efficacia gli interessi dell’1 per cento più ricco.
La politica è controllata dall’1 per cento dei più ricchi
Da dove deriva, allora, l’influenza dei ricchi? La risposta è abbastanza chiara: attraverso il finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali. Gli Stati Uniti ne sono il primo esempio, grazie alla capacità delle imprese di finanziare i politici e all’assenza virtuale di limiti ai contributi privati. Questo determina una concentrazione estremamente elevata di contributi politici da parte di coloro che si collocano ai vertici della distribuzione del reddito o della ricchezza: nel 2016, l’1 per cento dei più ricchi dell’1 per cento più ricco (e non è un errore di battitura) ha contribuito per il 40 per cento delle donazioni totali della campagna elettorale50. Di fatto, la distribuzione dei contributi politici è ancora più concentrata della distribuzione della ricchezza51. Se consideriamo il contributo politico come una spesa, sarebbe senza dubbio una di quelle maggiormente limitate ai ricchi, come l’acquisto di yacht e auto sportive.
Questa scoperta non è nuova, se non per gli importi di denaro necessari per influenzare le elezioni e la pervasività del fenomeno. Nel suo saggio del 1861, Considerazioni sul governo rappresentativo, John Stuart Mill scriveva: «Gli uomini politici non si sono mai seriamente e strenuamente ingegnati d’impedire la corruttela, perché non hanno mai desiderato veramente che le elezioni non fossero costose. Il loro cospicuo costo è un vantaggio per chi può sobbarcarsi questa spesa, giacché esclude un gran numero di competitori» (Mill 1975, p. 316). Il problema non si limita agli Stati Uniti, ma esiste anche in Germania e in Francia, dove in linea di principio le spese per le campagne elettorali sono più controllate (Schäfer 2017; Bekkouche e Cagé 2018). La situazione è probabilmente ancora più grave in molte giovani democrazie in cui le regole del finanziamento politico sono addirittura meno chiare e spesso non vengono applicate. La maggior parte dei recenti scandali politici in Europa (che hanno coinvolto Helmut Kohl, Nicolas Sarkozy e Silvio Berlusconi, per esempio) non hanno riguardato la corruzione personale, ma quella a sfondo politico, con i soggetti coinvolti accusati di aver accettato illegalmente denaro e di averlo usato per fini politici. In alcuni casi, hanno subìto sentenze di condanna. Il problema ha assunto proporzioni gigantesche in India, dove ingenti donazioni sottobanco sono all’ordine del giorno, e i candidati prendono un po’ di soldi per sé e un po’ per il partito (Crabtree 2018). Nell’Europa orientale e meridionale si osserva un’evidente sproporzione fra gli importi necessari per condurre le campagne (pagare i sondaggisti e gli attivisti, pubblicare annunci sui giornali, sui media elettronici e in televisione) e le somme che risultano provenire da fonti legittime. La questione viene generalmente passata sotto silenzio e ignorata: ai vincitori non si chiede in che modo hanno vinto le elezioni, e chi ha perso sa che potrebbe sentirsi rivolgere le stesse domande in materia di finanziamenti.
È giunto ora il momento di chiedersi se i ricchi ottengano risultati in proporzione ai loro contributi. I politici fanno quello che vogliono i ricchi? All’inizio di questo sottoparagrafo, ho citato prove empiriche che dimostrano come i politici prestino maggiore attenzione alle questioni che contano per i ricchi. Ma l’economia ci fornisce anche una chiave di lettura metodologica al riguardo. Forse, innanzitutto, è strano che venga formulata una simile domanda, data l’ovvietà della risposta: equivale a chiedersi se ai ricchi piacciano davvero le grandi case che comprano. Il fatto è che nessuno spende il proprio denaro senza aspettarsi di ricevere qualcosa in cambio, che si tratti del vantaggio di possedere una grande casa o di una politica fiscale favorevole. Sostenere che i ricchi contribuiscano alle campagne elettorali senza aspettarsi favori in cambio non solo è totalmente antitetico al normale comportamento dei ricchi (la maggior parte dei quali lo sono diventati spremendo come limoni dipendenti, fornitori e clienti), ma va anche contro il buonsenso e tutto ciò che sappiamo della natura umana. Solo i politici possono dire cose tanto illogiche in pubblico, come per esempio Hillary Clinton, fintamente sorpresa di scoprire che la gente pensava che Goldman Sachs si aspettasse qualcosa in cambio dopo averle elargito somme consistenti per la sua campagna elettorale52. Possiamo credere all’affermazione di Hillary Clinton solo se siamo disposti a credere che i ricchi donatori, come classe, vanno temporaneamente fuori di testa a intervalli regolari biennali o quadriennali. In altre parole, com’è normale che sia, i ricchi (al pari di tutti gli altri) si aspettano che il loro denaro renda, che si tratti di finanziamenti obbligazionari o di contributi alle campagne elettorali53.
Il nodo fra potere e ricchezza
Ciò che i ricchi acquistano con i loro contributi sono politiche economiche che vanno a loro vantaggio: imposte più leggere sui redditi elevati, maggiori detrazioni fiscali, plusvalenze più consistenti grazie ai tagli fiscali a favore delle imprese, meno regole, e così via. Queste politiche, a loro volta, aumentano le probabilità che i ricchi mantengano le loro posizioni di vertice. Questo è l’ultimo anello della catena che va da una maggiore quota del capitale nel reddito netto alla creazione di un’alta borghesia permanente, o almeno durevole, nel capitalismo liberal-meritocratico. Anche senza quest’ultimo anello della catena, l’alta borghesia avrebbe comunque il vento in poppa, ma la chiusura «politica» del cerchio rende la sua posizione pressoché inattaccabile. Il controllo politico è quindi una componente indispensabile per l’esistenza di un’alta borghesia durevole, come abbiamo detto all’inizio.
L’élite preferisce un’istruzione costosa perché consolida il suo potere
Ma saremmo negligenti nel vedere la nuova alta borghesia capitalista come una replica della vecchia. I suoi membri differiscono nei diversi modi che ho già esposto: sono più istruiti, lavorano di più, traggono una quota maggiore del loro reddito dal lavoro e tendono a imparentarsi fra di loro. Inoltre, prestano molta più attenzione all’istruzione dei loro figli. L’alta borghesia «neocapitalista» moderna vuole assicurarsi che i propri beni, insieme a molteplici vantaggi non tangibili – come gli agganci, le conoscenze e la migliore istruzione che il denaro può comprare –, vengano trasferiti ai figli. Il ruolo della dispendiosa istruzione privata, in questo contesto, può essere visto sotto una luce completamente nuova. Il costo dei corsi universitari privati, che è aumentato molto più velocemente rispetto al costo generale della vita o al reddito reale delle famiglie negli Stati Uniti, fa sì che il ceto medio non riesca quasi più a permettersi di far studiare i figli54. Nei primi trentotto college e università degli Stati Uniti, sono più numerosi gli studenti appartenenti a famiglie dell’1 per cento più ricco di quelli che si collocano nel 60 per cento più basso della scala dei redditi55. Supponendo che il numero di figli per famiglia sia più o meno lo stesso nelle famiglie ricche e in quelle meno abbienti, ciò significa che la possibilità di frequentare le scuole migliori è per i ragazzi nati in famiglie molto ricche circa sessanta volte superiore a quella dei nati non solo nelle famiglie povere, ma anche in quelle del ceto medio56. Le cosiddette «legacy admissions» (ossia il fatto di essere ammessi in un’università perché l’ha frequentata uno dei genitori) rappresentano tra un decimo e un quarto degli studenti dei primi cento college e università statunitensi (Levy e Tyre 2018).
Inoltre, poiché nel sistema americano di istruzione superiore l’essere accettati in un’università significa automaticamente laurearsi, il grande sforzo dei genitori e dei figli è tutto concentrato sull’ammissione, ed è proprio qui che i ricchi godono di vantaggi enormi57. In tali contesti, assumono importanza nel curriculum del ragazzo anche la scuola secondaria privata e, andando ancora indietro, quella primaria e persino la scuola materna, perché aprono la strada verso i college e le università di élite. È quindi fuorviante confrontare semplicemente il costo dei migliori college privati con, per esempio, quello delle università statali. Si dovrebbe considerare il differenziale di costo pubblico-privato in tutto il percorso scolastico del ragazzo, nel periodo di circa 14-16 anni che precede l’università. Quando un simile investimento dà i propri frutti, in quanto garantisce l’ammissione in determinati istituti, il fatto che gli studenti arrivino praticamente sempre alla laurea tranquillizza i ricchi rampolli che in un ambiente più competitivo non riuscirebbero mai a terminare gli studi58. Parlando di George W. Bush, per fare un esempio, entrare a Yale era l’unica cosa che contava, e la sua famiglia ha fatto in modo che ciò accadesse. Una volta lì, non ha dovuto far altro che impegnarsi al minimo, evitare scandali e non ritirarsi dagli studi59.
L’alto costo dell’istruzione, unito alla qualità didattica reale o percepita di alcuni istituti d’élite, assolve a due funzioni: rende impossibile ad altri competere con i principali detentori della ricchezza, che monopolizzano la fascia più alta dell’istruzione, e lancia un segnale forte: chi ha studiato in queste scuole non solo proviene da famiglie ricche, ma deve essere per forza intellettualmente superiore60.
Si noti che entrambi questi fattori (costo elevato e alto livello di istruzione) sono necessari. Se i costi fossero più bassi, i figli dei genitori ricchi si troverebbero a dover affrontare una concorrenza molto più agguerrita. E se la qualità di tali scuole fosse considerata inferiore, potrebbero essere marchiate come «diplomifici» che si limitano a legittimare professionalmente i figli dei ricchi, senza però godere di particolare credito nel mondo reale. Ma poiché queste scuole sono allo stesso tempo costose (e questo limita la concorrenza) e valide (il che ne sancisce la superiorità intellettuale), i ricchi riescono a evitare entrambi i problemi. I vantaggi si manifestano non solo nel crescente divario retributivo a cui hanno accesso i laureati, ma anche nelle sempre maggiori differenze tra laureati, a parità di anni di studio. Dieci anni dopo l’inizio dell’università, il decile superiore dei lavoratori laureati di tutti gli atenei aveva uno stipendio medio di 68.000 dollari, mentre per quelli provenienti dalle prime dieci università americane la retribuzione media era di 220.000 dollari (Stewart 2018, p. 22).
Questo è anche il motivo per cui è lecito prevedere che se non si farà qualcosa di decisivo per migliorare la qualità relativa dell’istruzione pubblica e per equiparare le possibilità di accesso alle università più quotate, l’attuale situazione degli Stati Uniti diventerà ancora più estrema e si estenderà ad altri paesi. Anche se in fase ancora iniziale, lo stesso processo sta cominciando a verificarsi nei paesi europei che, storicamente, hanno sistemi scolastici pubblici ben consolidati.
Poiché i ricchi si rendono conto dei vantaggi di una costosa istruzione privata, la loro disponibilità a pagare rette elevate permette a quegli istituti di attirare i docenti migliori e di sottrarre gradualmente alla scuola pubblica gli insegnanti più preparati e i figli delle famiglie benestanti. Inoltre, a mano a mano che i ricchi si allontanano, diminuisce la loro disponibilità a pagare le tasse per l’istruzione pubblica. Il risultato che ne consegue è un sistema scolastico biforcato che replica la distribuzione della ricchezza: un gruppo ristretto di scuole di alto livello frequentate soprattutto dai ricchi, e un grande gruppo di scuole mediocri aperte a tutti gli altri.
Gli altoborghesi possono così trasferire i loro vantaggi alla generazione successiva. I figli, oltre a ricevere denaro mentre i genitori sono in vita, a ereditare ricchezza e a beneficiare del capitale sociale della famiglia, godono anche dell’enorme vantaggio di partenza di un’istruzione eccellente che comincia dall’asilo nido privato per concludersi con il dottorato. Nel suo discorso del 2015 tenuto alla facoltà di giurisprudenza di Yale in occasione del conferimento delle lauree, Daniel Markovits ha stimato che l’investimento aggiuntivo per l’istruzione ricevuto dai figli dei ricchi (rispetto a quelli del ceto medio) equivale a un’eredità tra i 5 e i 10 milioni di dollari. Ha poi concluso affermando che «i figli delle famiglie meno abbienti o anche del ceto medio non possono competere [...] con soggetti sui quali è stato compiuto questo investimento massiccio, prolungato nel tempo, pianificato e calcolato, sin dalla nascita o addirittura da quando erano ancora nel grembo materno». Imprenditori imparziali che guardino solo ai loro interessi avranno tutte le ragioni del mondo per dare i posti di lavoro migliori a questo gruppo di privilegiati. Come in molti altri casi, l’esistenza in contemporanea di due equilibri, uno per i ricchi, ad alto livello, e un altro per il ceto medio, a basso livello, genera forze che consolidano questo doppio equilibrio e ne rendono più difficile il capovolgimento.
La ricchezza ereditata
Concludiamo con la ricchezza ereditata. Per cogliere l’importanza della sola eredità finanziaria, consideriamo un calcolo che è stato fatto per la Francia, ma che probabilmente è ancora più pertinente nei paesi con disparità di ricchezza maggiori, come gli Stati Uniti. Nel Capitale nel xxi secolo (2014, pp. 377-429 ed. ingl.), Piketty si chiede, suddividendo il quesito in due, quanta parte della ricchezza totale venga ereditata annualmente, e quale percentuale della popolazione, in un determinato anno, riceva in eredità una ricchezza il cui valore è superiore al reddito capitalizzato che un lavoratore medio percepisce nel corso di un’intera vita (qui chiamato per semplicità «lavoratore mediano»). La domanda è importante perché quanto più alta è la percentuale della popolazione che riceve tali somme, tanto maggiore sarà – a parità di condizioni – quella delle persone che vivono di rendita. Ma anche se il problema non è la percentuale di soggetti che vivono di rendita – la gente aspira in realtà a qualcosa di più che non semplicemente a staccare delle cedole –, più questo numero è alto e maggiore è il vantaggio dei ricchi. La formula per il flusso economico annuo di successioni e donazioni, espresso in rapporto al Pil, è μ × m × β, dove m è il tasso di mortalità annuale, μ è il rapporto fra il patrimonio del defunto e il patrimonio delle persone in vita, e β è il rapporto fra il totale dei patrimoni privati e il reddito nazionale. Ora (come abbiamo visto prima), quando i paesi si arricchiscono, il loro β sale; inoltre, poiché le persone vivono più a lungo, la ricchezza dei defunti tende a essere molto più alta della ricchezza media per adulto (in quanto le persone accumulano maggiore ricchezza con l’età). Entrambe le variabili tenderanno pertanto ad aumentare nel tempo il flusso successorio in percentuale del reddito nazionale. In Francia, l’attuale rapporto tra flusso successorio e Pil è pari a circa il 15 per cento del reddito nazionale (Piketty 2014, grafico 11.1). E quale percentuale della popolazione francese riceve eredità pari o superiori al reddito capitalizzato che il lavoratore mediano percepisce nel corso di un’intera vita? Tra il 12 e il 15 per cento. Questo gruppo di persone potrebbe mantenere indefinitamente il tenore di vita di un lavoratore mediano senza mai lavorare nemmeno un giorno. Nei paesi con disuguaglianze di ricchezza più profonde, la percentuale è probabilmente maggiore, soprattutto a causa di un valore di μ più elevato. E anche tenendo conto del fatto che nei paesi con le maggiori disparità, in cui la distribuzione delle eredità è fortemente sbilanciata verso i ricchi, la percentuale di eredità molto ingenti (cioè, quelle il cui valore supera il reddito capitalizzato percepito da un lavoratore mediano nel corso della vita) può essere inferiore, è comunque vero che una parte importante della popolazione godrà di un enorme vantaggio rispetto a coloro che non ereditano nulla o molto poco61.
Fino a che punto l’alta borghesia è permeabile?
Una delle caratteristiche dell’alta borghesia nel capitalismo liberal-meritocratico è la sua relativa apertura verso persone di altre classi. Poiché gli altoborghesi non sono giuridicamente diversi dal resto della popolazione (come accade invece ai membri dell’aristocrazia), e poiché la loro principale (e in realtà unica) caratteristica distintiva è il denaro, non si chiudono a quegli individui che, per abilità o fortuna, sono riusciti a diventare ricchi a dispetto degli ostacoli con cui si sono scontrati. A differenza del passato, l’alta borghesia moderna è aperta nei confronti di queste persone e non le tiene in minore considerazione; potrebbe addirittura stimarle maggiormente proprio in virtù del percorso accidentato che hanno dovuto affrontare per raggiungere la vetta. Questa apertura ai nuovi arrivati dal basso rafforza l’alta borghesia in due modi: coopta gli esponenti più brillanti delle classi inferiori e trasmette il messaggio che la mobilità verso l’alto è alla portata di tutti, il che a sua volta rende il dominio dell’alta borghesia più legittimo e quindi più stabile.
L’apertura nei confronti dei nuovi arrivati può essere maggiore quando il progresso tecnologico è rapido e le grandi fortune si fanno rapidamente, com’è avvenuto negli ultimi decenni. Anche solo un rapido sguardo ai nuovi miliardari è sufficiente a dimostrare che, mentre molti provenivano da famiglie benestanti, pochissimi facevano parte dell’1 per cento più ricco o godevano di vantaggi sociali sproporzionati. Ciò è confermato dai dati sui miliardari statunitensi: la quota del patrimonio ereditato rispetto alla ricchezza totale dei miliardari statunitensi è costantemente diminuita, passando da circa il 50 per cento nel 1976 al 35 per cento nel 2001 per poi scendere a poco più del 30 per cento nel 2014 (Freund e Oliver 2016, p. 30)62. La maggior parte dei miliardari e probabilmente molti milionari hanno livelli di reddito e posizioni relative molto più elevati di quelli dei loro genitori e hanno sperimentato sia la mobilità verso l’alto assoluta che quella intergenerazionale relativa.
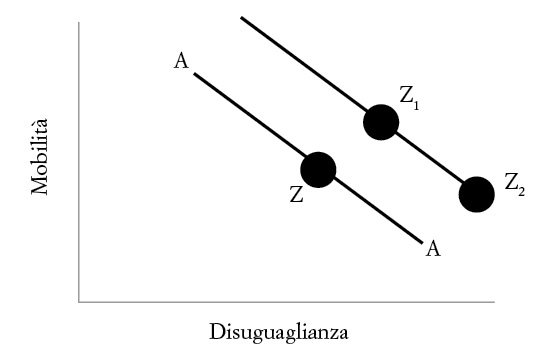
Figura 2.7. Il rapporto a lungo e breve termine tra disuguaglianza e mobilità intergenerazionale.
Questo dato potrebbe suggerire un rapporto positivo, per un periodo di tempo limitato, fra una rapida crescita economica e un rapido aumento della disuguaglianza di reddito da un lato, e un’elevata mobilità intergenerazionale dall’altro. Ma tale rapporto sembra essere in conflitto con i dati analizzati in precedenza che mostrano un’associazione tra un livello elevato di disuguaglianza e un basso livello di mobilità. Il modo di conciliare le due variabili (disuguaglianza e mobilità) può consistere nel distinguere i cambiamenti temporanei da quelli più duraturi in entrambe. Consideriamo la seguente situazione, illustrata nella figura 2.7. Supponiamo che mobilità e disuguaglianza siano negativamente correlate, come confermano i dati a lungo termine degli Stati Uniti e di altri paesi. Questa relazione è rappresentata dalla linea A-A. Supponiamo ora che un paese come gli Stati Uniti parta dal punto Z, ma che poi la disuguaglianza salga, trainata dal rapido progresso tecnologico e da nuove grandi fortune. Sia la disuguaglianza sia la mobilità possono aumentare, con conseguente spostamento al punto Z1. Questo punto, tuttavia, si trova su una nuova (e più alta) linea che collega disuguaglianza e mobilità, e il rapporto a lungo termine fra le due è ancora negativo (una maggiore disuguaglianza porta a una minore mobilità). Questo scenario mostra perché i movimenti temporanei di disuguaglianza e mobilità dovrebbero essere distinti dal loro rapporto a lungo termine, e quello che sembra essere uno sviluppo positivo (aumento della mobilità intergenerazionale) può, a lungo termine, mantenere semplicemente il sottostante rapporto «cattivo» tra disuguaglianza e mobilità.
In termini pratici, ciò significa che quando il progresso tecnologico rallenta e generare nuove fortune diventa sempre più difficile, la resistenza dell’alta borghesia sarà rafforzata. Avremo quindi un’alta borghesia meno aperta, una maggiore disuguaglianza e una minore mobilità sociale, rappresentata dal punto Z2. Questa, naturalmente, sarebbe una ricetta per la creazione di un’alta borghesia (semi)permanente.
L’élite di oggi nel capitalismo liberal-meritocratico
Forse non si dà il giusto peso alla similitudine tra il punto di vista di Marx e quello dell’economista italiano Vilfredo Pareto sul ruolo della classe dirigente (nella terminologia di Marx) o dell’élite (in quella di Pareto). Secondo entrambi, ogni società contiene, o ha contenuto, una distinta alta borghesia, la quale usa l’ideologia per presentare i propri interessi come interessi generali e quindi per mantenere l’egemonia su coloro che essa governa.
Il loro punto di vista, tuttavia, differiva sull’importanza della proprietà dei mezzi di produzione come base principale per la distinzione di classe, e sull’importanza del modo in cui la produzione è organizzata. Secondo Marx, questi fattori determinavano le caratteristiche delle società e delle classi dirigenti, mentre la visione di Pareto era più aperta: anche all’interno di una singola formazione sociale, l’élite si può plasmare secondo criteri diversi e può mantenere il proprio dominio in maniere differenti. Pareto identifica due tipi di classi dirigenti: i «leoni», una classe militarizzata che mantiene la propria posizione con la forza e la coercizione, e le «volpi», una classe dirigente più sofisticata che evita l’uso della violenza e preferisce governare attraverso il potere economico e il dominio ideologico63.
La classificazione di Pareto ci porta a formulare la seguente domanda: data la natura del capitalismo liberal-meritocratico, quali sarebbero le caratteristiche principali della sua élite dominante? O, in altre parole, quale tipo di élite o di classe dirigente (qui uso i due termini in modo intercambiabile) è associato al capitalismo liberal-meritocratico e vi prospera?
Senza dubbio, per usare la terminologia di Pareto, la classe dirigente del capitalismo liberale è composta da volpi. Non usa mezzi militaristici per mantenere il potere, e presenta altre caratteristiche che ho esposto in questo capitolo e che può essere utile riassumere:
1. La classe dirigente controlla la maggior parte del capitale finanziario del paese. Abbiamo visto che negli Stati Uniti il 10 per cento dei detentori di ricchezza controlla oltre il 90 per cento delle attività finanziarie.
2. La classe dirigente è molto istruita. Numerosi membri della classe dirigente hanno un’occupazione, e il loro reddito da lavoro tende a essere elevato (a causa dell’alto livello di istruzione). I membri della classe dirigente detengono quindi un alto reddito sia da lavoro sia da capitale (la condizione che ho chiamato omoplutia).
3. Le élites investono opportunamente nella prole e nel controllo politico. L’investimento nell’istruzione dei figli permette loro di mantenere un elevato reddito da lavoro e l’alto status tradizionalmente associato alla conoscenza e all’istruzione. L’investimento in influenze politiche permette alle élites di scrivere le regole in materia di successioni, in modo che il capitale finanziario sia facilmente trasferibile alla generazione successiva. I due fattori messi insieme (istruzione acquisita e capitale trasmesso) consentono la riproduzione della classe dirigente.
4. L’obiettivo dell’investimento nel controllo politico non è finalizzato solo a migliorare il contemporaneo potere economico della classe dirigente, ma anche ad assicurarne il dominio nel tempo.
5. La capacità delle donne di accedere allo stesso livello di istruzione degli uomini e di godere delle stesse regole in materia di successioni le rende sempre più indistinguibili dagli uomini in termini di reddito e di potere. Pertanto, la classe dirigente del capitalismo liberal-meritocratico è probabilmente la meno sessista di tutte le classi dirigenti storiche.
6. Le crescenti affinità fra uomini e donne in termini di disponibilità economica e istruzione porta alla formazione di famiglie a partire da coppie benestanti e con un’istruzione simile (omogamia), altro fattore che contribuisce al mantenimento intergenerazionale di questi vantaggi.
7. Poiché l’alta borghesia non si definisce secondo criteri ereditari o professionali, ma si basa sulla ricchezza e sull’istruzione, si tratta di un’alta borghesia «aperta». Coopta dalle classi inferiori i membri più promettenti che hanno la capacità di diventare ricchi e di compiere un percorso di studi avanzati.
8. I membri della classe dirigente sono laboriosi e hanno una visione amorale della vita (vedi capitolo 5). Tutto ciò che permette a questa classe di mantenere e rafforzare la propria posizione e che rientra nei limiti di legge è, di per sé, auspicabile. L’etica dei suoi appartenenti è definita dal quadro giuridico vigente e il loro uso del denaro per controllare il processo politico si estende all’uso del denaro stesso per modificare le leggi. Questa interpretazione flessibile delle regole consente loro di mantenersi entro i confini della legalità, anche se le pratiche che adottano si discostano sempre più dalle norme etiche generali.
1 André Orléan (2011, p. 23) utilizza una definizione simile, distinguendo l’economia capitalista dall’economia di mercato (économie marchande) per la presenza, nella prima, del lavoro salariato. Peer Vries (2013) fa altrettanto, ma aggiunge la «proiezione del potere all’estero» come caratteristica centrale del capitalismo (argomento che tratteremo nel capitolo 3).
2 In un altro saggio ho introdotto una classificazione simile dei capitalismi (Milanovic 2017).
3 Il presupposto è che il risparmio derivante dai redditi da lavoro sia trascurabile.
4 Si parte dal presupposto che le proporzioni del reddito da capitale e di quello da lavoro siano costanti nella distribuzione del reddito, e non importi assoluti. Una persona potrà quindi ottenere 7 unità di reddito dal lavoro e 3 unità di reddito dal capitale e un’altra rispettivamente 14 e 6. I loro redditi totali saranno diversi, ma le proporzioni tra i due fattori rimangono le stesse.
5 E poiché gli individui più ricchi risparmiano di più, e chi dispone di capitali in abbondanza tende a essere ricco, si genera un ulteriore impulso dinamico che alimenta una maggiore disuguaglianza.
6 In via teorica, tuttavia, non è detto che debba essere necessariamente così. Un sistema capitalistico, e persino una quota crescente del reddito netto da capitale, è compatibile con analoghe proporzioni fra il reddito da capitale e quello da lavoro percepito da tutte le classi di reddito. Questo spezzerebbe il legame fra l’abbondanza di capitali e il posizionamento nella distribuzione del reddito.
7 I lavoratori, inoltre, non risparmiavano. Questo di certo era quanto accadeva in passato, quando i salari erano prossimi al livello di sussistenza o appena di poco superiori.
8 Fino a che punto si possono definire «lavoratori»? Non tutti sono d’accordo al riguardo, perché parte del loro reddito imita i rendimenti delle attività (come accade, per esempio, ai soggetti la cui retribuzione è agganciata all’andamento del capitale proprio dell’azienda), ma è ancora lecito parlare di retribuzione, in quanto per percepirla occorre lavorare. Si noti che è un caso diverso rispetto a chi viene pagato in partecipazioni azionarie, in quanto i redditi legati ai titoli o le plusvalenze realizzate rientrano fra i redditi da capitale.
9 Vedi Piketty (2014), cap. 8, in particolare le figg. 8.3 e 8.4; Piketty e Saez (2003); Atkinson, Piketty e Saez (2011); e, tra gli altri, Bakija, Cole e Heim (2010).
10 Secondo Dahrendorf ([1963] 1978, p. 113), la mobilità sociale intergenerazionale era relativamente elevata negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Germania e «il tasso di mobilità sembra corrispondere approssimativamente al grado di industrializzazione di un paese».
11 Non credo che questo punto di vista possa essere particolarmente controverso. La «preferenza pura» sarà diversa in una società aristocratica, in cui gli ordini sociali sono disposti gerarchicamente, rispetto a una società più democratica.
12 Per alcune questioni tecniche relative alla misurazione della quota del capitale, si rimanda all’Appendice C.
13 Non sempre è chiaro che cosa debba essere incluso nella quota del capitale. La questione è spiegata nell’Appendice C.
14 Per quanto riguarda il potere monopolistico e l’aumento della quota del capitale, si veda Kurz (2018), il quale constata che il «surplus income» (la quota del profitto di monopolio nel valore della produzione) è passato negli Stati Uniti da quasi 0 nel 1986 al 22 per cento nel 2015 (tabella 7). Per quanto riguarda il potere monopsonistico, si vedano Azar, Marinescu e Steinbaum (2017).
15 Vedi B. Milanovic, Bob Solow on Rents and Decoupling of Productivity and Wages, in «Global Inequality», 2 maggio 2015: http://glineq.blogspot.com/2015/05/bob-solow-on-rents-and-decoupling-of.html.
16 Numerosi economisti hanno spiegato la crescita della quota del capitale rispetto a quella del lavoro attribuendola al potere di mercato, o al rent seeking (ossia il prelievo di rendite). Tra questi anche Angus Deaton, in un’intervista rilasciata ai curatori del blog «ProMarket» in data 8 febbraio 2018: https://promarket.org/angus-deaton-discussed-driver-inequality-america-easier-rent-seekers-affect-policy-much-europe/.
17 Gli utili societari nel 2015 hanno raggiunto il picco dell’ultimo mezzo secolo (Wolff 2017, p. 27).
18 Goldman Sachs Research osserva: «Secondo le nostre stime, l’aumentata concentrazione del mercato dei prodotti e del mercato del lavoro ha depresso la crescita salariale annua di 0,25 punti percentuali all’anno dai primi anni Duemila» (citato in A. Scaggs, On Juggernaut Companies and Wage Growth, in «Financial Times», 4 febbraio 2018).
19 L’iperinflazione prevista o cronica, come nel Brasile degli anni Settanta, non colpisce più di tanto i detentori di capitali, poiché sono in grado di mettersi al riparo da questi eventi e di cavarsela meglio delle famiglie più povere, le quali, per le necessità quotidiane, devono operare in contanti utilizzando una moneta che perde valore di giorno in giorno.
20 Si noti come le persone che si trovano nel primo decile della ricchezza non siano necessariamente le stesse che si posizionano nel primo decile del reddito.
21 L’assunto implicito, avvalorato empiricamente, è che le classifiche per ricchezza e reddito presentano una forte correlazione positiva, vale a dire che le persone con redditi elevati sono anche persone con grandi ricchezze.
22 I coefficienti di Gini sono calcolati a partire da dati individuali nelle indagini sulle famiglie, dividendo il reddito da lavoro totale per il numero di soggetti che compongono la famiglia e calcolando poi l’indice di Gini tra gli individui e i valori così definiti. L’approccio è lo stesso per il reddito da capitale; si noti che questo calcolo mostra l’importanza dei redditi da capitale e da lavoro per le famiglie e si riferisce direttamente ai dati dei bilanci nazionali. È diverso da un calcolo della disuguaglianza salariale basato solo sui lavoratori. Per esempio, in quest’ultimo calcolo, due persone ad alto reddito sposate fra loro sono trattate come persone indipendenti, mentre in un calcolo basato sul reddito familiare i loro redditi vengono sommati.
23 I redditi da capitale comprendono dividendi, interessi, rendite e così via, ma non le plusvalenze (o le minusvalenze) realizzate.
24 I risultati qui riportati sono in realtà sottostime della concentrazione del capitale, poiché le indagini sulle famiglie da cui sono tratti questi risultati tendono a non includere gli individui con maggiore abbondanza di capitale, o, per evitare eventuali problemi di riservatezza, le indagini fanno «top-coding» (non riportano, cioè, i redditi al di sopra di una determinata soglia) o «swapping» (vale a dire scambiano redditi da capitale e da lavoro molto elevati tra gli individui più ricchi in modo che non possano essere identificati). I dati fiscali tendono a mostrare una concentrazione alquanto più elevata dei redditi da capitale, ma hanno i loro difetti: a volte le unità possono essere famiglie e a volte singoli individui semplicemente a causa di modifiche delle norme fiscali, o di movimenti improvvisi tra i redditi da capitale riportati nelle dichiarazioni e gli utili societari (utilizzando gli uni o gli altri a seconda di quali vengono tassati meno, com’è accaduto negli Stati Uniti con il Tax Reform Act del 1986).
25 Il fatto che una parte importante della popolazione sia priva di patrimonio non è peculiare degli Stati Uniti e riguarda anche altri paesi ricchi. Secondo le stime di Grabka e Westermeier (2014), il 28 per cento degli adulti tedeschi ha una ricchezza netta pari a zero o negativa, mentre metà della popolazione svedese ha una ricchezza negativa (Lundberg e Walderström 2016, tabella 1).
26 I «carried interests» sono tassati come plusvalenze più o meno al 20 per cento. Gli interessi dei conti di risparmio sono tassati come redditi ordinari con aliquote che possono arrivare al 40 per cento.
27 Bas van Bavel (comunicazione personale) mi ha portato l’esempio del fondo di gestione patrimoniale Bnp Paribas Fortis, che distingue fra clientela retail, prioritaria, private banking e gestione patrimoniale. Per quest’ultimo gruppo, i cui investimenti devono essere di almeno 4 milioni di euro, il numero di opzioni di investimento è molto maggiore e le commissioni di gestione (in percentuale rispetto al patrimonio investito) sono più basse.
28 L’analisi prende in considerazione solo i matrimoni uomo-donna, poiché il numero di matrimoni fra persone dello stesso sesso nel periodo è trascurabile.
29 Il risultato non può essere spiegato dalla maggiore partecipazione delle donne al mondo del lavoro perché il campione, in entrambi i casi, è composto solo da persone che non hanno reddito zero. Pertanto la possibilità che nel 1970 un maggior numero di uomini sposassero donne che non lavoravano non influisce sulle quote relative del decile superiore dei lavoratori maschi che sposavano donne appartenenti al decile superiore o inferiore delle donne lavoratrici.
30 Decancq, Peichl e Van Kerm (2013) hanno rilevato che l’indice di Gini negli Stati Uniti è passato da 0,349 a 0,415 tra il 1967 e il 2007, ma se il modello matrimoniale nel 2007 fosse stato lo stesso del 1967, il Gini controfattuale sarebbe stato solo 0,394. L’aumento dell’omogamia ha quindi aggiunto più di 2 punti Gini alla disuguaglianza (0,415 – 0,394). La misura in cui l’omogamia aumenta la disuguaglianza, sebbene sia positiva, non è del tutto chiara. In una prima stima, Greenwood et al. (2014a) hanno rilevato che l’accoppiamento assortativo spiega il grosso dell’aumento della disuguaglianza negli Stati Uniti fra il 1960 e il 2005. In seguito hanno ritrattato questo dato e in un corrigendum (Greenwood et al. 2014b) hanno stimato che l’effetto sulla disuguaglianza si è attestato fra 0,1 e 1 punto Gini sui 9 punti Gini di aumento della disuguaglianza osservata.
31 Fiorio e Verzillo (2018) hanno evidenziato che l’accoppiamento assortativo in Italia è molto forte fra gli uomini e le donne che appartengono indipendentemente all’1 per cento dei più ricchi. Le donne in questa classe di distribuzione del reddito delle donne hanno probabilità venticinque volte maggiori rispetto a quelle con un reddito mediano di sposare uomini che fanno parte dell’1 per cento dei più ricchi nella distribuzione del reddito degli uomini. Gli autori sostengono, tuttavia, che gli effetti sulla disuguaglianza complessiva sono esigui e che l’omogamia viene praticata solo nella fascia più alta della distribuzione del reddito italiano.
32 In una significativa analisi nascosta in una nota a piè di pagina di Legge, legislazione e libertà (2010, p. 342), Hayek fa riferimento alla percezione di una maggiore parità di opportunità negli Stati Uniti portando a esempio sé stesso (o meglio i propri figli). Mentre era a Londra in fuga dai nazisti, Hayek valutò di mandare i suoi bambini fuori dall’Inghilterra a vivere presso una famiglia. Riflettendo sulle diverse possibilità, si trovò a propendere per gli Stati Uniti anziché la Svezia o l’Argentina perché riteneva che gli Usa offrissero a uno straniero migliori opportunità, in quanto il successo era meno influenzato dal background dei genitori. Curiosamente, poi, Hayek osserva che la sua posizione sociale elevata rappresentava un vantaggio nel Regno Unito, ma non lo sarebbe stata altrettanto negli Stati Uniti, dove al tempo era relativamente sconosciuto. Ma dovendo partire da zero, i figli avrebbero avuto più possibilità di successo in America che non in Argentina. Hayek puntualizza inoltre che l’intero ragionamento partiva dall’implicito presupposto che i bambini non sarebbero stati collocati presso una famiglia nera, perché altrimenti tutti i vantaggi della maggiore mobilità americana si sarebbero trasformati nel contrario.
33 Nel suo Rischiare grosso (2018), Nassim Taleb propone la stessa idea, a cui dà il nome di ergodicità. Durante la vita o, nel caso intergenerazionale, per diverse generazioni, le persone dovrebbero – se ci fosse piena mobilità – trascorrere periodi di tempo equivalenti in diverse fasce della distribuzione del reddito, vale a dire che tutti avrebbero il 20 per cento di probabilità (su questo orizzonte temporale più lungo) di essere nel quintile inferiore e il 20 per cento di essere in quello della fascia medio-alta.
34 La mobilità relativa è una misura dei cambiamenti di posizione nella distribuzione del reddito nel corso delle generazioni: per esempio, se la posizione del padre era al cinquantesimo percentile e quella del figlio al sessantesimo, allora c’è stata una mobilità verso l’alto. Si noti, poiché la mobilità relativa si occupa di posizioni, che a ogni movimento verso l’alto ne deve corrispondere uno equivalente verso il basso. La situazione «ideale» sarebbe la perfetta ortogonalità (nessuna relazione) tra le posizioni di reddito dei genitori e quelle dei figli.
35 Nella loro analisi, Chetty et al. (2017b) esagerano il declino della mobilità assoluta negli Stati Uniti. Il loro scenario di riferimento mostra che il 92 per cento dei figli nel periodo iniziale (la coorte dei nati nel 1940) ha un reddito superiore a quello dei genitori, mentre alla fine del periodo (la coorte dei nati nel 1984) ciò è vero solo nel 50 per cento dei casi. Tuttavia, questo calcolo si basa sul confronto del reddito complessivo delle famiglie, cosa inappropriata dal momento che le dimensioni di queste sono in diminuzione. Dopo gli opportuni aggiustamenti, a cui procedono tenendo conto del reddito pro capite, il calo risulta molto minore e il dato passa dal 92 per cento al 62 per cento. Inoltre, utilizzano il reddito lordo anziché il reddito disponibile. Con l’aumento dei trasferimenti sociali ridistributivi e delle imposte nel periodo, la mobilità assoluta del reddito è diminuita probabilmente ancora meno. Davis e Mazumder (2017, p. 12) riscontrano un calo molto più contenuto, e non statisticamente significativo, della mobilità intergenerazionale assoluta negli Stati Uniti.
36 Alcune parti del testo di questo paragrafo sono basate sui post che ho pubblicato sul mio blog «Global Inequality» nel 2017: http://glineq.blogspot.com/.
37 Per gli Stati Uniti nel 1990, Tinbergen prevedeva che il rapporto fra i redditi dei lavoratori laureati e quello dei soggetti a reddito medio sarebbe stato compreso fra 0,83 (ossia, l’università avrebbe portato a un premio negativo del 17 per cento) e 1,07. Per i Paesi Bassi, il premio sarebbe rimasto consistente (con un rapporto di circa 2 a 1), ma si sarebbe dimezzato rispetto al livello del 1970 (Tinbergen 1975, tabella 6.7).
38 Che i paesi debbano trattare in modo diverso i cittadini che possiedono beni mobili o che possono spostarsi facilmente all’estero rispetto a quelli che non hanno questa possibilità fu già osservato da Montesquieu, come ci ricorda Hirschman nel suo Le passioni e gli interessi (1977, p. 94 ed. or.). Adam Smith era dello stesso avviso perché «il possessore di capitali è propriamente un cittadino del mondo e non è necessariamente legato a nessun paese particolare. Egli sarebbe pronto ad abbandonare il paese in cui è stato esposto a una indagine vessatoria per l’accertamento di un’imposta gravosa e trasferirebbe i suoi fondi in qualche altro paese dove poter svolgere la sua attività o godersi la sua ricchezza a suo agio» (La ricchezza delle nazioni, libro V, cap. 2).
39 In un mondo così utopico, l’assicurazione sociale obbligatoria potrebbe ancora esistere. Le imposte e i trasferimenti non sarebbero pari a zero, ma potrebbero essere relativamente contenuti e il loro obiettivo sarebbe quello di perequazione dei redditi piuttosto che di ridistribuzione o lotta alla povertà.
40 Possiamo aspettarci, sia a causa del numero crescente di anni di istruzione obbligatoria sia del limite naturale del numero massimo di anni di studio, che le differenze individuali in questo ambito andranno progressivamente riducendosi, come già avviene nei paesi ricchi: intorno al 2000, per esempio, il coefficiente di Gini per gli anni di istruzione era di 0,6 in India, 0,43 in Brasile (che sta passando da un livello di istruzione basso a uno medio), e solo 0,16-0,18 negli Stati Uniti e in Svezia, in cui il livello di istruzione è elevato (Thomas, Wang e Fan 2001).
41 Per esempio, un investitore i cui investimenti finanziari totali in un anno siano rimasti al di sotto di una determinata soglia potrebbe essere protetto da eventuali perdite nette (se ce ne fossero, potrebbero essere utilizzate implicitamente come credito d’imposta). Si potrebbe sostenere che con una simile garanzia i piccoli investitori sarebbero indotti ad assumere rischi irragionevoli, perché se l’investimento va bene si intascano gli utili, mentre se va male interviene lo Stato con le sue garanzie. Per evitare che ciò accada, si potrebbe fare in modo che la garanzia sia valida solo se le perdite non superano, per esempio, il 30 per cento, applicandola comunque solo a investitori sufficientemente piccoli. In questo modo si limiterebbe la responsabilità complessiva dello Stato, scoraggiando comportamenti eccessivamente rischiosi.
42 Isabel Sawhill (2017) suggerisce che la possibilità di trattare le retribuzioni molto elevate dei Ceo alla stregua di salari (e utilizzandole quindi per ridurre il reddito imponibile della società) venga limitata solo alle imprese che optano per piani di compartecipazione agli utili e di azionariato dei dipendenti. È un’idea interessante perché aggancerebbe gli interessi dei top manager a quelli dei lavoratori. Il Partito laburista britannico propone un sistema secondo cui le imprese con più di 250 dipendenti sarebbero obbligate a cedere dall’1 al 10 per cento delle azioni ai loro lavoratori.
43 L’idea di ridurre la povertà e la disuguaglianza attraverso sovvenzioni una tantum, per salvaguardare la democrazia, risale ad Aristotele: «Lo statista veramente democratico deve badare che la massa del popolo non sia troppo indigente: per questo motivo è perversa la democrazia. Bisogna perciò adoperare ogni mezzo perché l’agiatezza permanga a lungo. E poiché ciò conviene anche alle classi agiate, bisogna raccogliere in un fondo comune i ricavati delle entrate e distribuirli ai poveri, soprattutto se se ne può raccoglier tanto quanto basti ad essi per acquistare un campicello o altrimenti per dar inizio a un’impresa commerciale o agricola» (Politica, libro VI, cap. 5 [1976, p. 246 ed. ingl.]). Una proposta molto simile fu avanzata da Thomas Paine nella sua opera La giustizia agraria, pubblicata nel 1797.
44 La moral suasion può essere (forse) un altro modo per raggiungere questo obiettivo. Le università più ricche potrebbero essere invitate a firmare un impegno a donare il cosiddetto «Giving Pledge», in base al quale una determinata percentuale del loro reddito annuo realizzato attraverso donazioni non tassate verrebbe destinata a un fondo speciale da utilizzare per l’istruzione pubblica. Si noti che, negli Stati Uniti, l’esenzione fiscale prevista per le donazioni ai college privati fa sì che il gettito non percepito dai singoli Stati su tali donazioni sia spesso maggiore degli stanziamenti a favore delle università pubbliche che vengono finanziati dai contribuenti. Quindi, indirettamente, accade che gli Stati contribuiscano più all’istruzione privata che a quella pubblica.
45 Tra le altre fonti, vedi Milanovic (2016, pp. 194-199).
46 Un esempio è quello delle pensioni britanniche: alla fine degli anni Settanta, le pensioni pubbliche rappresentavano il 90 per cento di tutte le pensioni erogate mentre le pensioni professionali private erano solo il 10 per cento. Nel 2013, le pensioni professionali avevano superato quelle pubbliche (calcolate in base ai microdati britannici disponibili nel database del Luxembourg Income Study: https://www.lisdatacenter.org/).
47 Un caso interessante è il relativo insuccesso del sistema tedesco della «carta verde» nell’attrarre, in via permanente, migranti altamente qualificati. Se considerassero solo il loro reddito, queste persone potrebbero preferire un sistema molto più disuguale come quello statunitense che non uno più magnanimo ed equo come lo si potrebbe trovare in Europa occidentale.
48 Aristotele, Politica, libro III, cap. 8 [1976, p. 117 ed. ingl.].
49 Per esempio, se il 90 per cento dei ricchi è a favore di un determinato cambiamento, le probabilità che questo venga preso in considerazione sono quasi del 50 per cento; se il 90 per cento delle persone intorno al reddito mediano ha a cuore un problema, le probabilità che venga affrontato sono del 30 per cento (Gilens 2015).
50 I contributi dei membri di questo gruppo di ricchi sono quindi quattromila volte superiori a quelli dei cittadini medi. Vedi Thomas B. Edsall, Why Is It So Hard for Democracy to Deal with Inequality?, in «The New York Times», 15 febbraio 2019, basato sui dati di Bonica et al. (2013).
51 Sarebbe interessante studiare congiuntamente la distribuzione del reddito da capitale o della ricchezza e i contributi politici negli stessi individui. I dati per entrambi esistono, ma provengono da indagini diverse, e il legame tra i principali contribuenti e i principali detentori di ricchezza non è stato studiato, che io sappia, se non per i quattrocento americani più ricchi della lista pubblicata da «Forbes». Per questi, Bonica e Rosenthal (2016) hanno rilevato che fra il 1984 e il 2012, i quattrocento americani più ricchi hanno contribuito con una quota che è sempre stata superiore al 70 per cento e nel 2012 è salita all’81 per cento, mentre l’elasticità della ricchezza dei contributi politici era lievemente al di sopra di 1 (il che significa che ogni punto percentuale di aumento della ricchezza è stato accompagnato da un aumento dell’1 per cento circa dei contributi).
52 T. Timm, Money Influences Everybody. That Includes Hillary Clinton, in «The Guardian», 14 aprile 2016.
53 Questo non significa, come talvolta si pensa interpretando le cose in maniera grossolana, che i politici siano delle lavagne vuote su cui i ricchi possono disegnare qualsiasi politica faccia loro comodo. Il punto è che esiste un processo di selezione in cui i ricchi «individuano» i candidati potenzialmente bendisposti verso i loro interessi e li influenzano ulteriormente in quella direzione «desiderabile».
54 Il costo reale (cioè al netto dell’inflazione) delle rette e delle tasse universitarie private è aumentato di 2,3 volte tra il 1988 e il 2018. Vedi Emmie Martin, Here’s How Much More Expensive It Is for You to Go to College Than It Was for Your Parents, CNBC, 29 novembre 2017: https://www.cnbc.com/2017/11/29/how-much-college-tuition-has-increased-from-1988-to-2018.html. Nello stesso periodo, il reddito pro capite mediano reale negli Stati Uniti è aumentato di circa il 20 per cento (calcoli effettuati sulla base dei dati del Luxembourg Income Study: https://www.lisdatacenter.org/).
55 Gregor Aisch et al., Some Colleges Have More Students from the Top 1 Percent Than the Bottom 60, in «The New York Times», 18 gennaio 2017. Per lo studio da cui è tratto l’articolo, vedi Chetty et al. (2017a).
56 Se le famiglie meno abbienti e quelle del ceto medio hanno più figli per famiglia, il vantaggio dei ricchi è addirittura superiore a 60:1.
57 Per un’analisi del sistema scolastico nella riproduzione sociale del sistema classista, vedi Bowles e Gintis (1976).
58 Questo testo è stato scritto prima che scoppiasse lo scandalo delle tangenti pagate dai genitori per ottenere l’ammissione dei figli nelle università, di cui si è avuta notizia nel febbraio 2019. Vedi J. Medina, K. Benner e K. Taylor, Actresses, Business Leaders and Wealthy Parents Charged in U.S. College Entry Fraud, in «The New York Times», 12 marzo 2019.
59 Le cose non vanno molto diversamente in Francia: nel 2017, solo il 2,7 per cento degli studenti delle elitarie grandes écoles aveva genitori appartenenti alla fascia più bassa della scala socioeconomica; vedi Ph. Aghion e B. Berner, Macron’s Education Revolution, in «Project Syndicate», 7 maggio 2018: https://www.project-syndicate.org/commentary/macron-education-reforms-by-philippe-aghion-and-benedicte-berner-2018-03.
60 Fino a poco tempo fa è stato molto difficile ottenere dalle principali università statunitensi informazioni sul reddito o sulla ricchezza dei genitori degli studenti. Questa segretezza è in evidente contrasto con il fatto che tutte le principali università degli Stati Uniti hanno appositi dipartimenti in cui numerosi addetti si occupano esclusivamente di acquisire la massima quantità possibile di informazioni sulla situazione economica dei genitori e anche degli ex alunni, al fine di calibrare correttamente le richieste di contributi in denaro.
61 L’unico altro paese per il quale sono disponibili tali stime è il Regno Unito. Atkinson (2018) ritiene che il rapporto tra ricchezza ereditata e Pil sia sceso dal 20 per cento all’inizio del xx secolo a circa il 5 per cento negli anni Ottanta (il punto di minimo) e che da allora sia poi risalito a circa l’8 per cento, il che lo pone ancora lievemente al di sotto del livello francese. Atkinson conferma anche il risultato osservato da Piketty di un valore di μ in aumento, cioè la ricchezza relativa dei defunti.
62 Anche la percentuale di miliardari che hanno ereditato la loro ricchezza nelle economie avanzate (all’interno delle quali gli Stati Uniti svolgono un ruolo preponderante) è scesa nello stesso periodo, dal 42 per cento al 37 per cento (Freund 2016, p. 22).
63 «La classe governante A procura di difendere in vari modi il proprio potere, e di allontanare il pericolo che i B muovano contro di essa [...]. Gli A aggiungono derivazioni [ideologia] per far stare queti [sic] i B [...]; dicono loro che ‘ogni potere viene da Dio’, che è ‘delitto’ ricorrere alla violenza, che non vi è nessun motivo di usare la forza per ottenere ciò che, se è ‘giusto’, si può conseguire colla ‘ragione’; la quale derivazione ha per scopo principale di distogliere i B dal dare battaglia su un campo ad essi favorevole, per trarli su un altro, cioè quello dell’astuzia, dove la disfatta è sicura» (Pareto 1916, cap. XII, § 2192, p. 569).