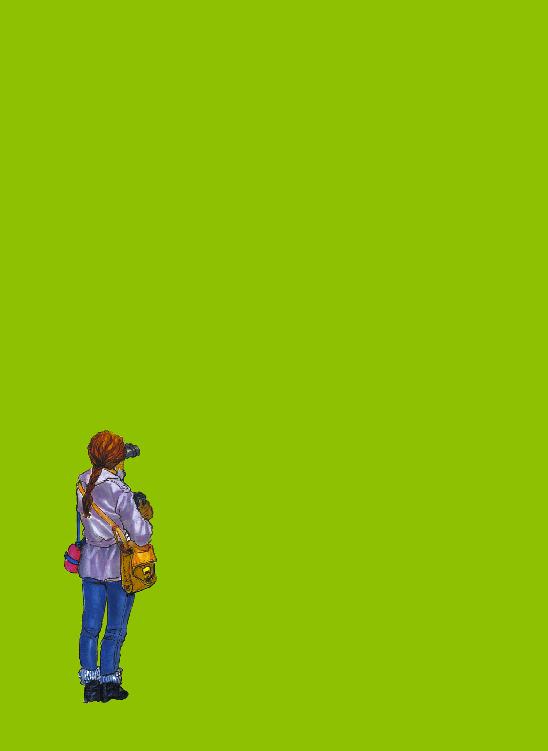Intervista
di Sylvie Coyaud a Elisabetta Visalberghi
Fra i primatologi italiani, Elisabetta Visalberghi è la più famosa. Direttore di ricerca dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR a Roma, Segretaria generale dell’International Primatological Society e Presidente della Società Italiana di Etologia, studia la biologia, il comportamento e le capacità cognitive dei cebi a Roma e in Brasile.
A scuola e al liceo, lei era brava?
Così sembrava, dai voti. Ma io ero convinta di non essere così brava come gli altri pensavano. All’università ho scelto biologia e all’inizio ho dovuto studiare fisica, chimica e matematica, materie che c’entravano poco con quello che sognavo di fare. Poi ho trovato un compagno di studi, Enrico Alleva, che condivideva la mia passione per la natura e tutto è cambiato. Insieme ci siamo messi a fare esperimenti sul senso di orientamento dei colombi.
Come mai è passata alle scimmie?
Per caso. Ho iniziato osservando un gruppo di macachi giapponesi appena arrivati allo zoo di Roma; ma in Italia non c’era nessuno che mi potesse insegnare qualcosa in questo campo. Così con una borsa di studio sono andata al centro dei primati dell’Università della California, a Davis, dove il professor Bill Mason mi ha insegnato a fare ricerca. Lo scopo del mio progetto era capire come le scimmie scoiattolo e i callicebi risolvevano i problemi della vita (problemi che io inventavo apposta per loro e che, se risolti, permettevano loro di ottenere un cibo preferito) e di comprendere anche come l’intelligenza, lo stile d’approccio al problema e le dinamiche sociali ne influenzavano il successo.
Poi sono tornata in Italia e, sempre allo zoo di Roma, ho incontrato un cebo: si chiamava Cammello. Quando l’ho visto la prima volta, stava cercando di rompere il guscio di una nocciolina americana con una patata lessa! Ciò era talmente assurdo che per giorni e giorni ho tentato di capire perché lo faceva. Così ho scoperto che Cammello era capace di usare strumenti ben più idonei, i sassi per esempio, per rompere gusci di frutti ben più duri, come noci e mandorle. Da allora non ho più smesso di studiare come, quando e perché le scimmie usano gli strumenti.
E come si studia?
In laboratorio, eseguendo esperimenti mirati e in natura osservando il loro comportamento spontaneo.
In natura, i cebi dai cornetti vivono prevalentemente sugli alberi: sono belli, eleganti, appena più grossi di un gatto e si chiamano così perché sulla testa hanno due ciuffetti di pelo. Per capire come vedono il mondo, cerco di immaginare una situazione che li stimoli o li interessi, con la quale possono spontaneamente misurarsi e ottenere qualcosa che vogliono. In questo modo sono felici di partecipare all’esperimento e lo sono anch’io.
Dian Fossey non faceva esperimenti.
No, era un’etologa che faceva osservazioni sul campo.
In una certa misura, lei è stata mandata allo sbaraglio, a fare una ricerca molto rischiosa. Non solo perché poteva restare uccisa, come le è accaduto, ma anche perché la primatologia era un campo nuovo in cui non c’erano né soldi, né fama da conquistare. Spesso capita che le donne siano gli apripista in settori a rischio; fino a quando non c’è da far carriera, gli uomini non entrano in competizione!
Dian Fossey con i gorilla e Jane Goodall con gli scimpanzé hanno reso la primatologia una scienza molto popolare, anche grazie ai documentari e ai film che le presentavano come “la bella e le bestie”. E poi le scimmie ci affascinano in modo particolare perché ci somigliano e ci interessa sapere fino a che punto. I primati sono uno specchio in cui guardare noi stessi.
A proposito del cebo Carlotta che lei ha visto crescere, ha scritto di aver provato le “stesse preoccupazioni di una madre col proprio piccolo.” Conviene di più mantenere il distacco verso le scimmie che si studiano o provare affetto?
Tocca mantenere il distacco nella descrizione e nell’analisi scientifica dei loro comportamenti, nel porre domande serie e dare risposte che tengano conto dei dati, e nello scartare spiegazioni complicate se ne esistono di più semplici. Ma emozioni e sentimenti aiutano a capire meglio un animale. Per una madre è difficile, ma possibile, giudicare con oggettività il proprio figlio; per noi è difficile essere oggettivi con un animale al quale vogliamo bene, dobbiamo essere coscienti di questa difficoltà, ed esercitare quello che Bekoff chiama un “antropomorfismo critico”.
I suoi colleghi l’hanno eletta presidente
della Società Italiana di Etologia (SIE) e segretario generale
dell’International Primatology Society (IPS) che è un po’ la vostra
Onu. Quindi significa che è proprio brava.
Pensa di avere un talento particolare?
Tanti fattori contribuiscono a far vincere un’elezione.
Per la Società di etologia forse è contato il fatto che sono una donna, visto che non c’era mai stata una presidente donna, e all’IPS che ero italiana, visto che ai vertici non c’era mai stato un italiano. Però non avendo fatto campagna elettorale, penso di aver ricevuto dai colleghi un segno di stima e questo mi ha fatto molto piacere.
Se ho un talento, forse è quello di guardare i problemi da un punto di vista originale, senza dar troppo peso alle teorie degli altri. Mi viene naturale fermarmi e chiedermi “sarà proprio così?”. Sono scettica. Sono scettica, o forse realista, anche nei miei confronti. Non ho mai avuto molta fiducia in me stessa, credo alle piccole imprese più che alle grandi. Più che brava, mi ritengo fortunata.