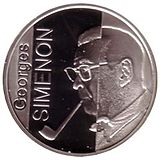Georges Simenon

Georges Simenon nel 1963
Biografia (abbozzo)
Georges Joseph Christian Simenon (13 febbraio 1903 – 4 settembre 1989)
Fu uno scrittore belga che pubblicò quasi 200 romanzi e numerosi racconti, È famoso soprattutto per la creazione del commissario Jules Maigret
Nacque a Liegi in rue Léopold, 26 (ora 24) . I suoi genitori furono Désiré Simenon e sua moglie Henriette Marie Élise Brüll,. Il padre lavorava come contabile in un’agenzia di assicurazioni ed aveva sposato la moglie nel 1902. Georges nacque il 13 febbraio dell’anno seguente, ma la registrazione della nascita risulta il 12, come racconta lo stesso Simenon all’inizio del suo romanzo Pedigree [nel romanzo i nomi sono Désiré Mamelin et Élise Peters]: il numero 13 porta sfortuna.1
26, Rue Leopold, qui nacque Simenon
L’albero genealogico della famiglia Simenon (della madre) ha origine nella regione fiamminga di Limburg. Uno dei suoi più famosi antenati fu un tal Gabriel Brühl, un criminale che terrorizzò la zona (allora ducato) dal 1720 al 1743, quando dovette smettere a causa della sua impiccagione!. Il suo cognome, Brühl, divenne un dei tanti pseudonimi utilizzati da Simenon.
Simenon imparò a leggere all’età di tre anni all’asilo di Saint-Julienne. In seguito frequentò l’ Institut Saint-André. Poco dopo l’inizio della I Guerra Mondiale, nel 1914, continuò i suoi studi al Collège Saint-Louis, tenuto dai gesuiti.
In tutto questo periodo i Simenon passarono da una casa all’altra e all’inizio del 1918, Georges abbandonò gli studi per un attacco di angina pectoris del padre. Aveva 15 anni e iniziò una vita da Bohemien in cui si manteneva con lavoretti («petits boulots») di breve durata (aiuto pasticcere, commesso in una libreria, ecc) fino a quando l’anno successivo fu assunto dalla «Gazette de Liège». Qua cominciò a scrivere firmando gli articoli (più di 150) col nome di G. Sim.
Con lo stesso pseudonimo scrisse il suo primo romanzo (Au Pont des Arches) all’età di 16 anni. Il romanzo fu pubblicato due anni dopo. Sotto il nome di «Monsieur Le Coq», fra il novembre del 1919 e il dicembre del 1922, pubblicò più di 800 pezzi umoristici.
Nel 1922 suo padre morì e in quest’occasione lo scrittore si trasferì a Parigi con Régine Renchon (soprannominata Tygi). Qua lo scrittore conobbe La città, i suoi Bistrot, gli alberghi economici, i bar e le trattorie e soprattutto quella classe operaia che è molto spesso presente nei suoi romanzi. Lo scrittore, continuando a pubblicare con diversi pseudonimi, divenne finanziariamente indipendente. George e Tigy ritornarono a Liegi nel 1923 per sposarsi, anche se questo non impedì a Simenon di avere nuove relazioni (la più famosa rimane quella con Josephine Baker)
Nel 1930 prende vita il suo personaggio più celebre, il commissario Maigret in un racconto, scritto dietro richiesta di Joseph Kessel per la rivista Détective2. In questi anni i Simenon sono molto spesso in viaggio: Africa, Europa dell’Est, Unione Sovietica, Turchia e questi luoghi rivivono successivamente nei suoi romanzi Anche i luoghi dove vissero o che visitarono, in Francia, divennero l’ambientazione perfetta di molti libri, sia della serie di Maigret, che nell’altra sua produzione.
Nel 1939 nacque il loro unico figlio, Marc.
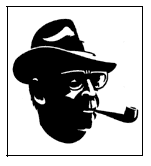
Durante la seconda guerra mondiale, Simenon visse in Vandea. Questo è il periodo più controverso della vita di Simenon, accusato di essere un collaborazionista dagli agricoltori locali.
In questo periodo Simenon produsse un gran numero di opere e lo scrittore ebbe contatti importanti, specie con André Gide. Alla fine della guerra fu processato per aver negoziato i diritti sui suoi scritti con studi cinematografici tedeschi. Nel 1945 Simenon, la moglie e il figlio si trasferirono in Nord-America dove passarono diversi mesi in Quebec. Nel 1950 lo scrittore fu condannato in Francia a non pubblicare nuovi libri per cinque anni. La sentenza non fu però resa pubblica ed ebbe scarso effetto
I Simenon continuarono la loro vita di viaggi e trasferimenti (Simenon si trasferì 33 volte nella sua vita). Nel 1949 Georges e Tigy divorziarono e nel 1950 Simenon si sposò con Denyse Ouimet da cui ebbe tre figli: Johnny (1949), Marie-Jo (1953) e Pierre (1959).
Nel 1952 Simenon e la nuova famigli tornarono in Europa, dapprima in Francia (Casta Azzurra) e successivamente in Svizzera
Simenon e Denyse Ouimet si separarono nel 1964 e da allora lo scrittore visse con la sua governante Teresa. Nel 1978 sua figlia Marie-Jo, che aveva sempre avuto gravi disturbi, si suicidò a Parigi. Dopo un operazione per un tumore da cui si riprese bene nel 1984, Simenon morì nel sonno nella notte fra il 3 e il 4 dicembre 1989.
Opera
Simenon è stato un degli scrittori più prolifici mai esistiti, in grado di scrivere dalle 60 alle 80 pagine al giorno. La sua produzione comprende 200 romanzi, 150 racconti, diversi lavori autobiografici, numerosi articoli ed altro, scritti sotto più di due dozzine di pseudonimi, Delle sue opere sono state pubblicate più di 550 milioni di copie (2014).
Il suo personaggio più famoso è il commissario Maigret che apparve per la prima volta in romanzo nel 1930 – Pietr-le-letton – e per l’ultima nel 1972 – Maigret et M. Charles. – per un totale di 75 romanzi e 28 racconti.
La moneta coniata per i 100 anni di Simenon
Il numero di film e di versioni televisive delle suo opere sono quasi incalcolabili. Ricordo qua alcune serie e film TV:3
1943 – 45 (Picpus, Cécile est morte!, Les caves du Majestic) con protagonista Albert Préjean4
1952 The Old Lady of Bayeux (Suspense: Season 4, Episode 48); Luis Van Rooten; 1952; Stati Uniti; 1 54 Ep.
1960 Maigret; Rupert Davies; 1960-1963; Inghilterra; 52 Ep.
1964 Maigret; Kees Brusse; 1964-1964; Olanda; 6 Ep.
1964 Maigret: De kruideniers; Kees Brusse; 1964; Olanda; 1 Ep.
1964 Le inchieste del commissario Maigret; Gino Cervi; 1964-1972; Italia; 16 Ep.
1967 Les enquêtes du commissaire Maigret; Jean Richard; 1967-1990; Francia; 88 Ep.
1967 Maigret; Jan Teulings; 1967-1969; Olanda; 12 Ep.
1973 МЕГРЭ [Maigret], Борис Тенин (Boris Tenin); 1973-1987 4 Ep.
1978 Tōkyō Megure Keishi; 1978 – Giappone; 12 Ep.5
1987 L’heure Simenon – Francia et Al. 13 Ep.
1991 Maigret; Bruno Cremer; 1991-2005; Francia; 54 Ep.6
1992 Maigret; Michael Gambon; 1992-1993; Inghilterra; 12 Ep.
2004 Maigret; Sergio Castellitto; 2004; Italia; 2 Ep.
Opinioni (da continuare)
Maigret e Montalbano7
Il rapporto tra i due personaggi, quello di Camilleri e quello di Simenon e quindi quello, molto stretto, tra Camilleri stesso e Simenon
Se ci si pensa solo un momento si vede subito che non certo per calcolo ma solo per istinto, la fortuna del commissario Montalbano creato da Camilleri si basa su una struttura equivalente, con in più la variante del dialetto che aggiunge alle vicende narrate un ulteriore e rassicurante connotato casalingo. Maigret è un grosso, solido borghese, che combatte la delinquenza e scopre gli autori dei delitti né per amore dell’avventura né per sfida intellettuale. Agisce come agisce solo perché si trascina fin dall’infanzia «una specie di senso del dovere» e anche perché cova «il timore di non aver mai fatto abbastanza per guadagnarsi il pane». [...] Ciò che in fondo interessa Maigret è capire i criminali con cui ha a che fare. La consegna del colpevole alla giustizia è così secondaria che alle volte viene sottintesa, alle volte addirittura omessa. In compenso Simenon ci informa fino al dettaglio sulla sua vita intima e privata come appunto sarà per gli investigatori anch’essi mediterranei scaturiti da Camilleri e da Montalbán.8
Questo è quello che pensa Augias, ma non solo: Pietro Dorfles9 e Giovanni Capecchi pensano lo stesso anche se poi il Capecchi cerca di affrancare Montalbano dal paragone ingombrante con Maigret.
Se Simenon svolge un ruolo fondamentale per entrare in contatto con il meccanismo del «giallo», è anche vero che questo punto di riferimento rimane sullo sfondo quando si tratta di delineare il carattere di Montalbano che cresce, inchiesta dopo inchiesta, contrapponendosi alla sostanziale immobilità di Maigret.10
Capecchi evita l’esiziale questione delle «motivazioni maigretiane» che muovono Camilleri. Preferisce sottolineare le differenze tra i due investigatori per enfatizzare in qualche modo «l’indipendenza» di Camilleri rispetto al modello di Simenon e la sua superiorità rispetto alla staticità e alla prevedibilità del commissario Maigret. Un simile atteggiamento è probabilmente dovuto al fatto che tra la fine della produzione della RAI (1972) e la pubblicazione del primo romanzo del ciclo di Montalbano (1994) passano più di vent’anni in cui il modello di Simenon, pressoché del tutto apolitico, in Italia viene sostituito dallo ampiamente affermato modello sciasciano con la sua denunzia della mafia e della corruzione politica del «contesto». Quasi subito Sciascia venne indicato dai critici come uno dei maestri di Camilleri e quest’ultimo lo confermò definendo Sciascia il suo «elettrauto» perché quando
«[ha] le batterie scariche si legge un suo libro»
Il raffronto tra Camilleri e Sciascia indubbiamente regge quando si tratta di esaminare i cosiddetti «romanzi storici e civili» in cui l’atteggiamento narrativo richiama a mente Sciascia, ma non regge se si tenta il ricorso alla griglia poetica dello scrittore di Racalmuto nella disamina del ciclo di Montalbano. Quando si parla del commissario Montalbano, si deve per forza di cose parlare del commissario Maigret.
Il debito di Camilleri con Simenon aumenta ad ogni citazione che qui riportiamo. Lo stesso Camilleri ne è consapevole al punto che nella genesi di Montalbano dovrà sforzarsi di diversificare il proprio personaggio da quello di Simenon che gli era ormai entrato sotto pelle11. Sarà uno sforzo»vano» perché del commissario parigino di Simenon e della stessa prosa simenoniana rimarranno ampie tracce in Camilleri. L’amore quasi incondizionato per Simenon prima che per Maigret farà sì che permanga in Camilleri giallista (ma anche in romanzi d’attualità quali La rizzagliata, L’intermittenza, Il sabato sera con gli amici, Il tailleur grigio, ecc.) un riflesso della prosa asciutta e politissima di Georges Sim, dalla calma olimpica e dall’equilibrio strutturale quasi classico. Nei romanzi cosiddetti «storici e civili» (per dirla con la terminologia della bipartizione dei «Meridiani» mondadoriani) come anche nella trilogia delle metamorfosi ci sembra invece di percepire una lingua più succulenta (la prosa maestosa di Il re di Girgenti ne è un esempio) e una struttura sovente strabica con focus che si sposta inaspettatamente spiazzando talvolta il lettore : basti qui l’esempio di Il casellante e della sua «falsa partenza», ma se ne potrebbero annoverare parecchi altri come la struttura sbieca di Privo di titolo, ad esempio, o in parte anche quella del recentissimo La setta degli angeli che costringe il lettore allo strabismo interpretativo.
Le «regole»
Montalbano viola le regole praticamente in ognuna delle sue avventure; Maigret, in Il cane giallo, dichiara apertamente di non essere adatto per essere preso come role model:
– Non capisco ancora del tutto i suoi metodi, commissario, ma forse comincio ad indovinare... Maigret lo guardò con i suoi occhi ridenti lanciando nel sole un grande sbuffo di fumo.
– Lei è fortunato, ragazzo mio ! Soprattutto in questo caso, nel quale il mio metodo è stato proprio quello di non averne... Vuole un consiglio? Se ci tiene a una promozione, non mi prenda come esempio e non cerchi di ricavare teorie da quello che mi vede fare... – Eppure... noto che adesso anche lei arriva agli indizi materiali dopo che... – Appunto, dopo ! Dopo tutto ! In altre parole, ho preso tutta questa inchiesta a rovescio, il che non m’impedirà magari di prendere la prossima dal diritto... Una questione di atmosfera... di facce... Arrivando qui, mi sono trovato davanti una faccia che non mi è piaciuta e non l’ho più mollata...12
«Rapporto con la tecnologia difficile»
– Pronto... 215 ?... chiamò Maigret. Grosjean, è lei? Mi sente?... Pronto... 215 ?... – 215 in ascolto... – Ci dirigiamo lentamente verso la Bastille... Branchu è a piedi... – Chiude ?
– Chiudo... Maigret scrollò le spalle.
– Mi tocca anche giocare alla guerra!...13
In Montalbano, quando viene introdotta la tecnologia informatica, non a caso è Catarella – il meno indispensabile alle sue dipendenze, a fare un corso, risultandone poi il primo.
«Notorietà non voluta»
– Sbaglio o ci siamo già visti ? chiese il tassista.
– Niente di più facile... – Strano, ma non riesco a ricordare il suo nome... So che lei è famoso... Attore ?
– No... – Mai fatto cinema ?... – No... – Forse l’ho vista in televisione ?... Per fortuna erano arrivati in rue Fontaine.14
A Montalbano accadono grosso modo cose simili e viene persino confuso con il suo omologo televisivo interpretato da Luca Zingaretti.
«La buona cucina»
Sia Maigret che Montalbano sono notoriamente delle buone forchette. Maigret, quando non ricorre all’abituale Brasserie Dauphine, si rifugia nel ricettario della signora Maigret mentre Salvo Montalbano va a mangiare da Enzo e, in alternativa, assaggia i manicaretti che gli prepara la «cammarera» Adelina. Certe volte persino le abitudini postprandiali del commissario di Vigàta sembrano dover qualcosa al predecessore d’oltralpe. In una delle avventure maigretiane più note, Il cane giallo, ci imbattiamo in Maigret che dice «Ma io adoro camminare, soprattutto quando devo riflettere» e poi aggiunge : «Non passò per la città, ma costeggiò il porto»15. Insomma, è difficile non farsi venire in mente la canonica passeggiata sul molo che Montalbano fa a compimento del rituale del pranzo.
Sono tante le cose che legano Maigret e quindi Simenon (magari attraverso la mediazione di Gino Cervi), a Montalbano: Lo stesso Camilleri lo dichiara:
– Lei ha detto che, all’epoca di Maigret, non ci pensava neppure, a Montalbano. Poi però qualcosa di Maigret ce l’ha messa, nel suo commissario. Magari inconsciamente... – No, no, anche coscientemente. Coscientemente proprio. Cercando di differenziarlo, certo, se no sarebbe stata una ripetizione.
– E Cervi ? S’è ricordato pure di Cervi ?
– Eh, devo dire... per esempio, c’è un punto, in un mio libro, che il commissario Montalbano si fa ‘na mangiata terribile e poi dice alla sua donna che ha mangiato solo un panino. Ecco, quella l’ho presa para para da Gino Cervi. Ci eravamo fatti, io e lui, una mangiata di quelle proprio da star male. Dopo di che lui telefonò a sua moglie e disse che aveva mangiato un panino con Camilleri, che era una bugia infame, perché la signora si preoccupava degli eccessi mangiatori di Gino... ma c’è qualcos’altro di Gino, in Montalbano. A volte mi vengono in mente certe sue reazioni davanti ai personaggi che mi divertivano. Certe occhiate, certi movimenti... E vedo che Montalbano magari fa lo stesso, così, spontaneamente.16
Simenon e Maigret (inizio)17
1 Caricatura di Plantu. «Le Monde», 15 luglio 1977.
Il ciclo di «Maigret»18 comprende 103 indagini sia sotto forma di romanzi (75) che racconti (28).Questo è il cosiddetto ciclo ufficiale, a cui alcuni aggiungono i quattro prototipi che Simenon ha firmato sotto pseudonimo (Georges Sim e Christian Brulls) Sono stati scritti nel 1929, poco prima di Pietr-le-Letton – Pietro il lettone (scritto nell’inverno del 1929-1930), considerata la prima indagine ufficiale del famoso commissario ... anche se era il quinto pubblicato.


2 Jules Maigret par Simenon (dédicace à Pierre Deligny, 1985). In Tout Simenon, catalogue 2003 de la Librairie La Sirène. Dessin de Loustal.
Maigret appare per la prima volta in quattro romanzi popolari che l’autore firma con gli pseudonimi di George Sim o Christian Brulls. Non sono inclusi nel ciclo ufficiale «Maigret» perché Simenon stesso ha stabilito - in particolare nel 1975 - un periodo in cui cercava ferocemente di nascondere tutti i lavori precedenti il 1931 - una distinzione tra il suo lavoro illegittimo (la letteratura sotto pseudonimi) e quello riconosciuto (i lavori pubblicati sotto il suo nome).
4 proto-Maigret:
- Femme rousse (La)19
- Figurante (La) (titre porté par le manuscrit, puis repris pour la réédition du texte : La jeune fille aux perles) – [La ragazza con le perle (1934)]
- Maison de l’inquiétude (La) – [tr. La casa dell’inquietudine (1932)]
- Train de nuit

3 Simenon par P. Sur une carte postale, émise à Chenove (Côte-d’Or, France), le 23 mars 1989.
Gli editori20
- La «periodo Fayard» (1931 - 1934) :
comprende 31 titoli: 19 «Maigret», 9 romanzi e 3 raccolte di racconti.
- La «periodo Gallimard» (1934 - 1947) :
6 «Maigret», 44 romanzi, 4 raccolte di racconti, 1 racconto di viaggi (La mauvaise étoile, avril 1938).

4 Dessin non signé pour la couverture de: Kommissar Maigret und die Frauen (Berlin, Verlag Volk und Welt, 1987.
- La «periodo Presses de la Cité» (1945 - 1981)
Comprende 141 titoli: 50 «Maigret», 60 romanzi detti del destino, 4 raccolte di racconti (di cui 3 «Maigret»), 4 storie a carattere autobiograficio, 21 Dictées, 1 saggio (Le roman de l’homme) e 1 reportage (La femme en France).
I «Maigret» e i non Maigret sono in totale 114 volumi di narrativa pubblicati da Presses de la Cité in 26 anni: 53 inchieste del celebre commissario (50 romanzi e 3 raccolte di racconti), 60 romanzi detti detti del destino e 1 raccolta di racconti.
I romanzi dedicati a Maigret e quelli di narrativa senza Maigret si dividono il totale quasi a metà. Questo dimostra l’attaccamento dello scrittore per il suo personaggio
Nel 1933, Simenon pubblica L’écluse n° 1 (La chiusa numero 1) appartenente al ciclo di Maigret.
Quattro mesi dopo l’uscita del libro, Simenon firmò un contratto che lo avrebbe legato fino al 1945 con Gallimard. Fayard gli offriva le stesse condizioni finanziarie, ma non la libertà di ispirazione che l’autore desiderava prima di tutto. Scegliendo Gallimard Simenon dimostrò la volontà di scrivere romanzi più letterari. A Simenon sarebbe piaciuto di sbarazzarsi di Maigret, per dedicarsi ad altro. Scrisse in seguito quello pensava sarebbe stato l’ultimo romanzo di Maigret, intitolato simbolicamente Maigret, pubblicato da Fayard nel 1934. Ma i lettori sono affezionati a Maigret e lo inondano di lettere per farglielo sapere.
(continua)