PRIMA PARTE
IL CUORE DI ROMA, I MONUMENTI
di Andrea Carandini
Premessa
Questo libro è stato scritto con un giovane allievo – Mattia Ippoliti –, come ormai è mia abitudine.1 Mai come preparando un libro s’insegna bene il mestiere e al tempo stesso ci si perfeziona dialogando con chi è nato molto dopo di noi. La sfida ha dell’impossibile, perché il cuore di Roma è molto più labirintico delle rovine e delle fogne di Vienna nel film Il terzo uomo (fig. 1). Infatti è composto da una infinità di dettagli tra loro intricati, che devono poi risolversi in stati di cose sensati e successivi nel tempo. Ciò è particolarmente arduo in una città che vive da oltre 2770 anni, la cui documentazione antica, seppure numerosa, è frammentaria e quindi interpretabile in vario modo. A volte ci si perde in contrastanti soluzioni, per cui la testa dell’indagatore si mette a girare, come quando ci si alza troppo in fretta.
Eppure nella stratigrafia e nella topografia di un centro urbano una stessa cosa non può stare ad un tempo qui e lì, anche se percorsi e funzioni possono variare attraverso i secoli, come accade con le varianti di una leggenda, che vanno fuori strada ma non troppo. Il problema per gli archeologi è anche quello di non dare tutto per scontato, perché quello di cui trattano è fuori epoca e quindi da spiegare, ma se poi tutto volessero motivare, si dovrebbero prevedere diversi volumi. Per semplificare un percorso, che altrimenti si rivelerebbe troppo impervio, è opportuno seguire le informazioni e le interpretazioni che sembrano più verosimili, accennando solo dove è proprio indispensabile alle opinioni contrarie, che nel nostro caso sono quelle tradizionali, appartenenti cioè alla “vulgata topografica”. La nostra visione, al contrario, riguarda un insieme di contesti ricostruiti minutamente tramite dati e argomenti che seguono una via originale. Pur avendo tratto all’inizio ispirazione da una ricerca assai poco convenzionale degli inizi degli anni ottanta,2 ci siamo mossi poi in modo sempre più autonomo, sia per quanto riguarda i testi che per quanto attiene ai monumenti, puntando molto sulla conoscenza concreta della città antica, dovuta all’esperienza fatta scavando, pubblicando gli scavi3 e producendo l’Atlante di Roma antica.4 I grafici elaborati da Mattia Ippoliti aiuteranno molto i lettori a districarsi tra strade ed edifici riportati alla luce, assiepati come non sorprende in questo crogiolo massimo di vita urbana, eppure non basta. Serve anche un grande sforzo di chiarezza nel raccontare, che presuppone un amore per i dettagli, oggi poco comune, prevalendo ampiamente ormai il gusto per l’approssimativo. I dettagli sono il sale della storia, ché il generico è sciapo.
Il compenso alla fatica sta nella ricostruzione trasparente degli stati di cose dell’epicentro di Roma antica, che esprimono, come in ritratti di età diverse, le vicende strutturali della città in continuo movimento. Si parte dagli aggregati di rioni precedenti Roma, che al loro culmine hanno quasi raggiunto la dimensione vasta e unitaria della prima città (circa 210 ettari). Si passa poi, con un salto, alle trasformazioni dovute alla fondazione romulea della città-stato, cioè a un insieme di atti sacrali, auspicali (cioè riguardanti segni dal cielo rivelatori della volontà di Giove), rituali e politico-istituzionali che hanno configurato Roma prima d’un tratto – senza una lunga formazione – e poi con perfezionamenti che hanno occupato soprattutto la seconda metà dell’VIII secolo a.C.: i decenni della svolta urbana. Seguono la rifondazione a opera di Servio Tullio, dalle durevoli conseguenze, l’abolizione della monarchia e la transizione alla libera res Publica. E poi, risalendo nel tempo, si giunge ai rifacimenti degli edifici nella più duttile e consistente tecnica edilizia dei caementa, i cui effetti si vedranno dopo l’incendio del 210 a.C. Un altro salto si ha poi con Augusto, che implicherà un sovvertimento funzionale dei luoghi, fino all’azione distruttiva del grande incendio del 64 d.C., che ha comportato il seppellimento del cuore cittadino più antico, durato ottocentoventicinque anni. A un centro irregolare, dovuto specialmente alle istanze religiose delle origini, è succeduta una scena regolare e magniloquente da capitale ellenistica, sul genere di Alessandria, con il lungo, retto e ampio viale porticato del clivo Sacro e con l’immane reggia di quell’anti-Cristo sotto il quale sono stati martirizzati Pietro e Paolo, Nerone. Per intendere questo megalomane, che si è tentato invano di riabilitare, servono sia Tacito sia Cannadine (Decline and fall of the British Aristocracy). Entrambi illustrano al meglio fino a quali innocenti stramberie e orripilanti perversioni giunge l’uomo quando tutto può, al vertice di un’alta nobiltà che muove un mondo.
Tutte queste trasformazioni maggiori di Roma si leggono nelle diverse espressioni del suo volto urbano attraverso i diversi stati di cose delle diverse epoche, perché la città non è immota ma scorre, come il Tevere che l’attraversa, ed è in questo mutare che rivela il suo essere. Per leggere gli stati di cose serve saper analizzare e saper vedere. Da questo punto di vista questo libro è un piccolo manuale, un mezzo d’iniziazione. Ma è venuto il momento di abbandonarci alle profondità del tempo.
ESORDIO MITISTORICO. Fondata Roma sul monte Palatino, Romolo e i Romani devono fronteggiare Tito Tazio e i Sabini che hanno occupato i colli aggiogati dell’Arce e del Campidoglio. Gli scontri fra i due re e i loro popoli si svolgono nella bassura che tra quei rilievi si interponeva, dove poi sorgerà la piazza pubblica del Foro. Nell’ultimo scontro, Romolo viene ferito e i Sabini inseguono ormai i Romani, che fuggono attraverso la bassura, arretrando fino alla loro città sul Palatino. Giunti alla prima porta che immetteva nel monte, i Sabini vengono affrontati dai Romani che custodivano le mura. Nel frattempo Romolo si è ripreso, anima la truppa e i Sabini vengono respinti lungo una strada infossata fino al limite della bassura (fig. 2).
Romolo era riuscito a salvare Roma perché davanti alla porta della città aveva invocato Giove: «Padre degli dèi e degli uomini, tieni lontani i nemici da questa porta. Qui a te Statore dedico un templum per ricordare ai posteri che la città è stata salvata dal tuo aiuto» (Livio, fonte 8.1; Dionigi di Alicarnasso, fonte 6.2; Plutarco, fonte 17.1).
Templum significava un’area sacra (corrispondente in questa fase a un sacellum) includente un focolare o un’ara su cui sacrificare, il cui suolo era stato inaugurato e cioè benedetto da Giove e anche consacrato a quel dio. Stator indica il Giove che ha fermato la fuga dei Romani e ha impedito loro di penetrare nell’urbs. Giove Statore è pertanto il primo custode di Roma. La strada infossata lungo la quale i Romani hanno respinto i Sabini era la Sacra via, allora accolta nel fossato del fondovalle tra Velia e Palatino. Il limite della bassura al quale i Sabini sono stati respinti corrisponderà alle future Regia e aedes (dimora) di Vesta, quindi al bordo orientale del Foro (figg. 2, 13).
Più difficile sarebbe ricostruire il luogo della vetus porta Palatii (o Mugonia), dove la riscossa dei Romani era cominciata, se la porta stessa non fosse stata scoperta dai nostri scavi nelle sue diverse versioni attraverso ottocentoventicinque anni. Se si riconosce questo luogo, si individua anche quello del templum con fanum di Giove Statore, creato da Romolo davanti a quella porta del Palatino (Palatium era allora il nome di un monte e non significava ancora “palazzo”) (fig. 10). Una aedes del dio verrà votata in quel templum/fanum solamente nel 294 a.C. da Attilio Regolo: nella battaglia di Luceria i Romani erano stati messi in fuga dai Sanniti, ma poi avevano ripreso a combattere, ancora una volta grazie a Giove Statore. Se nel segmento della Sacra via posto tra il limite est della bassura che diventerà Foro e la vecchia porta del Palatino Romolo non avesse prevalso sui Sabini, sostenuto da Giove Statore, Roma sarebbe morta in fasce.
Per una serie di connessioni di questa porta Palatina e di questo culto di Giove con altri monumenti importantissimi del cuore di Roma, scoprire il loro luogo significa trovare anche quello degli altri, consentendoci di ricostruire il paesaggio di questo luogo cruciale di Roma.
DOVE PASSAVANO LE MURA PALATINE? Romolo aveva inaugurato l’intero Palatino, monte principale del sito sul quale aveva fondato l’urbs, ottenendo da parte di Giove una benedizione del suolo entro il limite continuo segnato dal pomerium, all’esterno del quale verrà arato il sulcus primigenius, trasformato poi in un murus. Pomerium e murus avevano la forma di un quadrilatero posto alle radici del Palatino (Gellio, fonte 9.1). I quattro angoli del quadrilatero venivano identificati da quattro culti: 1) l’ara di Ercole (un poco eccentrica, sull’Aventino), 2) l’ara di Conso, 3) la sede delle Curie (Vecchie) sacra a Iuno Curitis, 4) il sacellum (recinto per ara) di Larunda, la Madre dei Lari. Foro e Campidoglio (con Arce) sono stati aggiunti al Palatino e al sistema dei rioni o curiae da Tito Tazio che li aveva conquistati (Tacito, fonte 19.1), trasformati – per accordo con Romolo – nel centro sacrale e politico della città-stato.
Per quanto riguarda la pendice settentrionale del Palatino, la linea delle mura è segnata dai tratti rinvenuti nei pressi della porta Mugonia, dalla porta stessa. Si trovano pertanto alla radice del monte ed erano grosso modo parallele all’asse della spectio auspicale che dall’auguraculum dell’Arce passava per la meta Sudans augustea fino a raggiungere il monte Albano che si ergeva nel cuore del Lazio antico. Tra la porta Mugonia e la Romanula il murus fletteva rispetto al suo normale andamento, per la posizione abnorme di quest’ultima porta dovuta sia alla conformazione del monte che in questo punto girava sia alla necessità di escludere il santuario di Vesta dall’urbs e di includerlo nel Foro. Di qui la ragione della posizione “fuori porta” del santuario (fig. 3).
DOVE ERA IL CENTRO DI GRAVITÀ DEL PALATINO? Eppure fermarsi a descrivere solo pomerium e murus è fuorviante, perché l’insediamento di Romolo non si trovava al centro del Palatino e neppure era diffuso ugualmente nel monte. Infatti il suo epicentro gravitava verso il limite occidentale del monte rivolto al Velabrum, ancora oggi chiamato Velabro. Gravitazioni analoghe si conoscono, per esempio, sia sull’Aventino, il cui settore più rilevante e ricco di templi era quello posto lungo il Tevere, sia sulla Velia, i cui culti e sedi regie – Penates, Vica Pota, Mutinus Titinus, Venus Calva, casa di Tullo Ostilio, prima casa di Valerio Publicola e seconda casa di Valerio Poplicola – si trovavano sub Veliis, presso il Foro e i Corneta.
IL PRIMO QUARTO DEL PALATINO. Il Palatino è divisibile in quattro quarti (fig. 4). La parte più rilevante del Palatino era racchiusa nel primo quarto (I), rivolto al Velabro e alle cui estremità erano due santuari connessi alla regalità: quello a una divinità femminile – una Iuno Sospita? – con vicino la casa (capanna) Romuli e la fossa/ara della fondazione e del primo fuoco regio e quello del fuoco indipendente e comune di Vesta, con vicino la domus delle Vestali, le domus regiae con i culti di Mars (Marte) e Ops, dei Lares e di Iuppiter Stator. In particolare quest’ultimo aveva connessioni sia con i culti del Velabro, dove era il culto di Larunda, la Madre dei Lari, sia con quelli della Velia: il Fascinus dell’aedes Vestae richiamava Mutinus Titinus, i Lari connessi alla domus Regia erano in rapporto con Vica Pota e con i Penates, e poi era stato Anco Marcio a istituire il culto alla Fortuna Barbata/Venus Calva, legato alla regina sua moglie (fig. 13).
In questo primo quarto del monte avevano abitato i mitici capi di questo luogo prima della città: Caco e Faustolo, a cui Romolo aveva tolto il Palatino. Qui si trovava anche la capanna del fondatore e la fossa con altare dove la città era stata fondata, unendo e celando terre e primizie di diverse provenienze, e dove era stato acceso il primo fuoco regio: tratto dal fuoco regio di Alba (Atlante, tav. 61)?
Le mura del Palatino erano dotate di tre porte rituali (figg. 3-4). Varrone (fonte 1.3) pone come terza quella di Giano, che però sta nel Foro; e Plinio prevede tre porte (fonte 16.2), come quelle di Gubbio. La prima, di cui ignoriamo il nome, è immaginabile vicino al santuario di Fauno Luperco o Lupercal, lungo le scale di Caco, che dalla valle Murcia portavano alla capanna di Romolo, al luogo dove Roma era stata fondata e al vicino santuario della divinità femminile. La seconda porta, chiamata Romanula, si trovava lungo una rampa all’angolo settentrionale del monte, in una posizione dovuta al monte che girava. Entrambe queste porte erano collocate nel primo e più rilevante quarto del Palatino. La terza porta, chiamata Mugonia o Palatii – quindi considerata principale – era collocata, secondo noi, sulla pendice settentrionale del monte, in posizione simmetrica rispetto a quella delle scale di Caco, al limite fra il primo e il secondo quarto del Palatino, lungo la strada principale che collegava le due suddette porte: il clivo Palatino A (figg. 9-10).
L’asse di questa strada coincideva con quello sud-nord della presa di possesso del Palatino da parte di Romolo, che in quella direzione aveva scagliato dall’Aventino la sua hasta o lancia – come un pater patratus che dichiara guerra –, hasta conficcatasi davanti alla capanna di Faustolo e presto trasformatasi in vivente corniolo. L’hasta aveva messo radici lì in segno di dominium. Il re fondatore aveva preso possesso del Palatino penetrandovi tramite le scale di Caco e avanzando per il clivo Palatino A, che portava al lato opposto del monte, verso la Velia, dove secondo noi era la porta Mugonia. La tesi della vulgata topografica è molto diversa, poiché ritiene che questa porta si trovasse tra il secondo e il terzo quarto del monte (tra II e III), quindi al centro del Palatino, lungo il clivo Palatino B, ma questo luogo era allora del tutto out-of-the-way, anche se compreso nel pomerium (figg. 4, 9).
Il primo quarto del Palatino, che si trovava tra il Velabro e il clivo Palatino A, era il più rilevante anche perché si rivolgeva a sud verso la parte più importante dell’Aventino, a ovest verso il Velabro e al Campidoglio dove era il culto civico di Giove Feretrio e a nord verso la parte della Velia più vicina al Foro dove si addensavano i culti principali e case di rango regio.
GLI ALTRI TRE QUARTI DEL PALATINO. Il secondo quarto del Palatino (II) si trovava tra il clivo Palatino A e il clivo Palatino B. All’estremità sud di questo quarto sorgeranno, di rimpetto alla casa Romuli, la casa di Ottaviano e la sovrastante casa di Augusto. Il clivo Palatino B, pur nella sua posizione centrale, si è trovato, fino alla seconda metà del I secolo d.C., in una periferia e infatti oltre il suo percorso erano gli ultimi due quarti del Palatino, i più marginali. Nel terzo quarto del Palatino (III) sorgerà la reggia di Nerone, quella dei Flavi e la aedes Iovis Victoris, cioè il complesso della domus Augustiana, enorme escrescenza, che si era radicata in quella che era stata la domus Publica di Augusto (come la domus Tiberiana nella domus di Tiberio). L’ultimo quarto (IV) rappresentava la periferia estrema del monte rivolta al Celio, che si troverà al di fuori della domus Augustiana.
QUANDO MUTA IL CENTRO DI GRAVITÀ SUL PALATINO? Il centro di gravità della Roma sul Palatino perdurerà per oltre ottocento anni. Cambierà solamente quando Nerone, fra il 54 e il 64 d.C., edificherà una propria casa proprio al culmine del clivo Palatino B, orientando su di esso l’intero edificio (Atlante, tav. 110). Il centro di gravità cambierà in modo più definitivo quando, dopo il 64 d.C., la domus Tiberiana verrà estesa da Nerone nei suoi giardini in modo da bloccare al pubblico l’uso del clivo Palatino A (Atlante, tav. 67). Contemporaneamente il clivo Palatino B, rettificato, porterà alla seconda reggia palatina di Nerone, anch’essa ugualmente riorientata, che è poi l’anteprima della domus Augustiana dei Flavi. Le due aule regie di Nerone e anche quella del palazzo flavio si troveranno tutte al culmine del clivo Palatino B, unico ormai a portare sul lato meridionale del monte. Ciò avveniva grazie al sussidio di un vicus tectus, che fasciava la domus Tiberiana e che aveva lo scopo di tenere sgombra di gente l’area Capitolina, diventata oramai la piazza delle cerimonie in cui l’imperatore entrava in rapporto con il popolo di Roma rivolgendogli un discorso; il vicus portava all’estremità sud del clivo Palatino A, reso inutilizzabile se non all’interno della domus Tiberiana. I palazzi imperiali stavano divorando la città.
SEGRETI DEL PALATINO: MITICITÀ, SACRALITÀ, SANTITÀ, RITUALITÀ E SOVRANITÀ. Per capire la struttura che può parere illogica del cuore dell’antica Roma bisogna risalire alle origini, cioè ai piccoli luoghi resi speciali dai loro culti, dalle case regie e sacerdotali, dai luoghi e dai percorsi connessi alle mitistorie e ai rituali della fondazione e del consolidamento della città e dai luoghi santi, cioè inviolabili, posti a protezione delle mura cittadine. Al contrario, se si parte da considerazioni di topografia astratta dai vincoli posti delle realtà religiose e istituzionali sopra ricordate, se cioè ci si fonda, semplicemente e ingenuamente, su un astorico e terra a terra buon senso ambientale – da colonizzatori moderni che creano dal nulla un insediamento regolare su mere ragioni di pratica utilità –, allora si finisce per annientare il percorso storico della città, proiettando ad esempio lo stato attuale delle rovine, cioè l’assetto voluto da Nerone e dai Flavi, su quello di Romolo e successivo, come ha fatto e continua tranquillamente a fare la vulgata topografica.
Il re fondatore non è penetrato nel Palatino insinuandosi tra il suo secondo e terzo quarto, dove facilmente si poteva accedere e trovarsi al centro di quel monte, là dove sarà il clivo Palatino B, che uno studioso ha definito come «the easiest access, a magnificent natural highway».5 Ha scelto invece l’“unsuitable place” rappresentato dalle ripidissime scale di Caco, che avevano sull’altro versante la ripidissima rampa della porta Romanula e quella meno ripida ma pur sempre poco agevole connessa alla porta Mugonia, simmetrica a quella legata alle scale di Caco; e quante altre rampe, anche più scomode, vi erano a Roma ed esistono ancora oggi (come la scalinata delle Tre Cannelle per salire sul Quirinale). Chi conosce le cittadelle e i paesini arroccati del nostro Paese certo non si spaventa per queste impervietà, clivi e rampe percorsi a piedi o su asini e muli… Ma lo studioso di biblioteca, avvezzo a trattar parole più che cose, costruzioni e strade, proietta sé stesso nel passato più lontano, cercando un ideale di comodità confacente a epoche progredite e attuali, al quale egli stesso è abituato. Ma sono le origini che hanno condizionato la topografia degli abitati non pianificati come il cuore di Roma prima di Nerone e il passato remoto è lontano dalle nostre abitudini legate al confort.
In conclusione, il centro di gravità di una città alle sue origini è legato non a ragioni secolari di pratica utilità, di semplice facilità insediativa, ma a ragioni che al non esperto di miti e di riti paiono irrazionali, da respingere, perché estranee al senso comune prevalente nei nostri comodi giorni. Invece il centro di gravità sacrale, rituale, istituzionale e politico dalla prima Roma fino a Claudio ha privilegiato luoghi per noi impervi, a scapito di altri molto più facilmente accessibili, ed è lì che tutto si è addensato – come in età cristiana le tombe comuni affollate intorno alla memoria del martire –, lasciando alle periferie funzioni meno importanti, come quella del semplice abitare nei diversi rioni.
ASSALITORI DELLE MURA, REMO E TITO TAZIO. Il cuore di Roma, gravitando tutto sul Palatino occidentale, ha condizionato la posizione delle porte delle mura – là dove Romolo ha sollevato l’aratro – e quindi anche dei loro assi stradali. Il primo asse est-ovest è rappresentato dalla Sacra via, che andava dall’Arce al sacellum di Strenia nel quartiere Carinae, o viceversa: una strada più antica della città. Il secondo asse sud-nord è rappresentato forse già dalla strada più importante dell’Aventino (vicus Armilustri), dal clivo Palatino A che andava dal ciglio delle scale di Caco alla porta Mugonia e infine alla “scorciatoia” per le Carinae (Dionigi di Alicarnasso, fonte 6.1). Come Romolo, che veniva dall’Aventino, era entrato dalle scale di Caco, così Tito Tazio, che veniva dall’Arce/Campidoglio aveva attaccato il Palatino dalla parte opposta, dalla porta settentrionale o Mugonia del clivo Palatino A. Probabilmente a lato del medesimo asse viario si era poi immaginato che Remo avesse violato il murus Romuli (vedi Note a margine, Le mura e una porta aggrediti da Remo e Tito Tazio).
I CIPPI DI REMO. I quattro cippi in forma di colonnine alte meno di un metro, di età giulio-claudia, con iscrizioni connesse a Remo sono stati rinvenuti: due sul Palatino in generale (MARSPITER cioè Mars pater, REMUREINE, che allude ai remores aves, ai Remoria e quindi a Remo) e due (FERTER RESIUS, re degli Aequiculi fondatore del diritto feziale o di guerra, ANABESTAS, personificazione dell’atto di anabainein, dello scavalcare le mura) in un punto più preciso: nello scavo di «una grande parte delle volte che sorreggono il piano più alto degli Orti Farnesiani soprastanti la via Sacra, a destra del clivo (Palatino B) e al di fuori (quindi a valle) della porta (cioè dell’arco di Domiziano) del palazzo (della domus Augustiana)».6 Pertanto i cippi non sono stati rinvenuti, seppure in posizione secondaria, lungo il clivo Palatino B, come sempre si è creduto, ma notevolmente più a ovest. P. Rosa precisa meglio il luogo di rinvenimento del cippo di Ferter Resius in una lettera a L. Renier del 20 agosto 1862:7 «Ho rinvenuto (il cippo) negli edifici sottoposti alla mia abitazione (nelle Uccelliere Farnesiane), al lato del clivo (Palatino B)». Sembra riferirsi a due corpi, il primo più a est sotto il pavimento del giardino delle Uccelliere e il secondo più a ovest, proprio sotto l’Uccelliera orientale, entrambi accessibili da sotto tramite tre aperture; il primo è piuttosto al lato che sottoposto all’Uccelliera e il secondo invece è letteralmente sottoposto a essa, per cui è il luogo più probabile del rinvenimento dei cippi (fig. 35). Lo scarico secondario in cui sono stati trovati due dei cippi, forse anche gli altri due provenienti latamente dal Palatino, si trova a m 106 circa del murus Romuli individuato al lato della porta Mugonia, di cui è stata individuata la fossa di spoliazione; davanti al murus, riproposti come memoria e quasi museificati, possiamo immaginare i due cippi della violazione (Remureine, Anabestas) e dietro le mura i due cippi della difesa (Marspiter, Ferter Resius) (fig. 36). Prolungando l’andamento delle mura verso il clivo Palatino B, nella sua versione anteriore al grande incendio, è possibile individuare un piccolo luogo, accanto all’ipotetico compitum, l’unico dove un tratto di muro avrebbe potuto essere riproposto, a m 118 circa dal luogo di rinvenimento. Ma in tutto il clivo Palatino né un murus Romuli né una porta Mugonia sono mai stati individuati (vedi Note a margine, Le mura e una porta aggrediti da Remo e Tito Tazio).
Remo ucciso vicino alla porta Mugonia e Tito Tazio respinto alla medesima porta rappresentano la memoria della salvezza di Roma dovuta a Romolo aiutato da Giove sia negli auspici che nella battaglia in cui ha votato il templum al sommo dio. Solo a un figlio di Marte e al parallelo a Roma di Ferter Resius, iniziatore del diritto di guerra, poteva riuscire una così fondamentale impresa. Una ripresa del diritto feziale ben si colloca nell’età tra Augusto e Claudio (Svetonio, Claudio, 25,5). In questa prospettiva, dal sapore fortemente antiquario, non sarebbe stato Numa o Anco Marcio a ereditare il sapere di questo re dell’Appennino centrale, ma lo stesso re fondatore di Roma. Era uso che il feziale portasse al confine (nemico) un’asta con puntale di ferro di corniola rossa resa aguzza dal fuoco. Orbene, non era stato Romolo a lanciare l’asta di corniolo dall’Aventino sul Palatino per prendere possesso di quel monte, quasi un primo re-augure che svolgeva anche la funzione di pater patratus, il feziale a cui spettava di dichiarare la guerra?
MUSEI DELLE ORIGINI SUL PALATINO. Non è un caso che i musei che a Roma commemoravano Romolo e le sue gesta fossero due: il primo si trovava sul Palatino rivolto all’Aventino, presso la porta alle scale di Caco, dove erano la capanna del re e la fossa con ara della fondazione; davanti a questo museo andrà ad abitare Ottaviano Augusto (Atlante, tav. 61); il secondo museo si trovava sul Palatino rivolto alla Velia, dove erano le riproposizioni arcaiche e tardo-repubblicane del murus Romuli e della porta Mugonia e il templum con fanum (in seguito dotato di aedes) di Giove Statore, davanti ai quali erano andati ad abitare i re Tarquini, alcuni Valeri e i pontefici massimi. Tutti i monumenti dei due musei erano stati fondati da Romolo, secondo Cicerone, grazie a medesimi auspici (fonte 2.4). Nel primo museo si celebrava la fondazione, nel secondo la custodia della città e la sua stabilizzazione nel tempo, basata sull’uccisione di Remo e sul respingimento di Tito Tazio, premessa della futura alleanza tra Sabini e Romani; nessuno di questi popoli era riuscito a prevalere, avendo mantenuto ciascuno le proprie posizioni, per cui alla fine si sono federati tra loro per portare a termine un progetto urbano di Roma congiunto, creando il fuoco comune di Vesta e il Foro con l’Arce e il Campidoglio come centro sacrale e politico della città-stato.
È interessante il fatto che Ottaviano Augusto abbia tralasciato il secondo museo delle origini e abbia voluto valorizzare l’altro, andando ad abitare davanti al luogo della fondazione della città; infatti il principe aveva interesse non a custodire Roma, essendo egli il solo uomo in cui il potere era ormai concentrato, ma a rifondarla come un principato. Voleva ricollegarsi cioè, non a Servio Tullio, ma a Romolo, cui il nome di Augusto rimandava. Questo spostamento del cuore del potere dal lucus Vestae alla casa/aedes Romuli faciliterà a Nerone la cancellazione e il seppellimento di questo cuore di Roma dopo il “provvidenziale” grande incendio.
NON UNO MA DUE CLIVI PER IL PALATINO. Seguiremo più in là due libri di due poeti che si muovono per Roma, entrambi per raggiungere il bibliotecario e la biblioteca della casa di Augusto sul Palatino, svelando i segreti dei due clivi che portavano a quel luogo così speciale. Vedremo che l’itinerario del libro di Ovidio e quello del libro di Marziale indicano il primo la prevalenza persistente del clivo Palatino A1b, anteriore a Nerone, e il secondo il nuovo prevalere del clivo Palatino B, posteriore all’avvento di Nerone (figg. 5, 6).
La sorte ha voluto che il clivo Palatino B sia stato scoperto già da molto tempo da P. Rosa, negli anni sessanta dell’Ottocento, rimasto l’unico clivo a condurre dalla Sacra via sul Palatino dal 64 d.C. fino alla fine dell’Impero. Al contrario il clivo Palatino A è stato scoperto da noi tardi, nel 2004, per cui per oltre centoquarant’anni la topografia romana è stata condizionata da questa insufficiente conoscenza delle rovine di questa zona di Roma, influenzata anche dal fatto che ancora oggi se dalla Sacra via si vuol raggiungere il Palatino si deve percorrere il clivo Palatino B. I vecchi stati di cose funzionano come i preconcetti: sono durissimi da superare, perché ciò che tradizionalmente si sa e si vede conta molto di più di quanto si conosce invece da poco, anche se di maggiore importanza per la maggior parte della storia di Roma antica.
Eppure già dagli inizi degli anni ottanta del Novecento, pur ignorando l’esistenza del clivo Palatino A, si è aperta una rivoluzione topografica che ha messo finalmente in lizza due teorie principali concorrenti, quella tradizionale e quella innovativa,8 rinnegata in seguito dal suo stesso autore,9 per cui essa viene oggi perfezionata e sviluppata soltanto dalla nostra scuola. D’altra parte, se scendendo per la Sacra via dalle Carinae la casa di Scauro, che sappiamo stare sul Palatino, si raggiungeva prendendo la prima (proxima) strada a sinistra (Asconio, fonte 14.2) – cioè il clivo Palatino B – significa che doveva esistere almeno un’altra strada a sinistra e più a valle – il clivo Palatino A –, la quale andava ricostruita dagli archeologi anche prima di essere stata materialmente scoperta, altresì per la scoperta della porta Mugonia arcaica e tardo-repubblicana, da intendersi come la memoria più volte riproposta della porta Mugonia alto-arcaica, originaria, anch’essa fortunatamente individuata (fig. 9).
DALLA SACRALITÀ INTEGRALE AGLI ALBORI DEL SECOLARISMO. Solo a partire dalla metà del VI secolo a.C., quando per la prima volta il pomerium è stato separato dallo stare a breve distanza dal murus e dietro di esso – per cui l’Aventino si è trovato dentro l’agger di Servio Tullio ma fuori dal suo pomerium –, la mentalità sacrale alto-arcaica ha cominciato a vacillare e poi gradualmente ad alterarsi, fino a non essere più correttamente intesa. Sono cominciate da allora a prevalere ragioni pratiche di urbanizzazione, come quando le case aristocratiche del 530 a.C. circa sono state costruite annientando un ampio tratto delle mura palatine, già suolo inviolabile, e la stessa porta Mugonia originaria, perché pomerium e agger erano stati spostati per comprendere l’intero abitato (fig. 9). Fu poco tempo dopo che la memoria di quelle mura e della loro porta è stata riproposta (fig. 10). Il clivo Palatino A1a terminava in due clivi a forcella, distanti fra loro una ventina di metri: uno connesso al clivo della porta Mugonia originaria e un altro connesso ad un clivo che portava invece a una postierla e che aveva finito per costeggiare la casa degli ultimi due re. Cominciò Servio Tullio a nobilitare questo clivo secondario erigendo accanto alla sua casa la porta Fenestella (si veda oltre), prodromo di quanto sarebbe accaduto al tempo del suo successore. Quando al tempo di Tarquinio il Superbo il clivo Palatino A originario e la sua porta furono seppelliti sotto le case aristocratiche datate al 530 a.C. circa, l’altro clivo della forcella (A1b), rimasto il solo disponibile, finì per diventare il principale e a cavallo di esso venne riproposta prima la porta Mugonia arcaica – a imitazione della precedente porta Fenestella? – e poi quella tardo-repubblicana. Fu allora che per la prima volta la casa di un re di Roma è apparsa strettamente congiunta a una porta tradizionale del Palatino.
Ma se la porta Mugonia era al limite nord del clivo Palatino A, dove è logico che fosse stata e dove ne abbiamo trovato i ripetuti resti, allora anche il templum/fanum di Giove Statore, poi con la sua aedes, doveva trovarsi lì davanti. Cosa di cui noi stessi ci siamo resi conto solo più tardi, rinvenendo il luogo di culto nel 2012 in un ultimo tratto di suolo rimasto non scavato.
Siamo arrivati al punto in cui occorre entrare in due vasti campi, prima in quello delle fonti letterarie che descrivono nel tempo questi luoghi di Roma e poi in quello delle scoperte archeologiche nel cuore della città, dovute principalmente al nostro scavo della pendice palatina durato trent’anni. Ora finalmente questo paesaggio urbano ci è chiaro in tutti i suoi periodi.
QUATTRO GRANDI TRASFORMATORI DI ROMA. I quattro grandi trasformatori di questo cuore della città sono stati Romolo, Servio Tullio, Augusto e Nerone. Se non si distinguono con cura almeno questi grandi periodi, articolati al loro interno in numerose fasi, invece di approdare in un porto si finisce in un pasticcio, dove cose mai vissute insieme si trovano tra di loro mescolate. È proprio perché insoddisfatto delle fonti letterarie, utilissime ma a volte di non facile interpretazione in quanto non offrono riferimenti spaziali certi, che chi scrive con la sua scuola ha dedicato il tempo di una generazione allo scavo di un ettaro della pendice settentrionale del Palatino, tra l’Arco di Tito e l’aedes di Vesta (non riesco a tradurre aedes, perché dimora è altisonante e casa o stanza è inadeguata). Ma mentre le fonti letterarie sono state trattate come capelli spaccati in quattro e quando non piacevano sono state screditate e molto liberamente emendate, i monumenti sono stati presi in considerazione profonda, cioè stratigrafica, e continua, cioè topografica, solamente dall’autore di questo libro, da Paolo Carafa, dai loro più validi collaboratori e dagli studenti.
***
INTERLUDIO. Male si conosce una persona solo attraverso lettere o qualche schizzo. Bisogna incontrarla per averne una impressione distinta – occhi specchio dell’anima, espressioni del volto come il sorriso e gesti dell’intero corpo –, ma ciò ad alcune persone incute paura: preferiscono una relazione meramente platonica e a distanza (ricordo lo storico Sir Moses Finley, che alla mia offerta di portarlo sui ponteggi che circondavano la colonna Traiana ha risposto che non lo interessava). Il mondo antico lo si incontra fisicamente solamente tramite lo scavo. E come le fonti letterarie vanno intese in modo filologico, così l’universo delle cose va inteso in modo tipologico (come si conviene con prodotti in serie), stratigrafico (seguendo l’anatomia del terreno) e topografico (in grande estensione e per fasi). Che storici e filologi si sentano in imbarazzo di fronte a costruzioni e a oggetti è fatto che intristisce, perché dovuto a ristrettezza disciplinare, ma che si può intendere. Paradossale è invece il fatto che pochissimi tra coloro che si autodefiniscono archeologi – essendo soprattutto antiquari o storici dell’arte – amino realmente i monumenti e le relazioni ch’essi intrattengono tra loro, che poi determinano i contesti attraverso il tempo. Di qui il grave sbilanciamento a favore degli oggetti mobili d’arte che affligge da sempre i nostri studi – i tedeschi rifilano generalmente tutto ciò agli architetti, che è come dire al di fuori degli studi umanistici! – e che porta ai ritardi che conosciamo (si pensi alla distanza temporale che intercorre fra la Forma Urbis di R. Lanciani, della fine dell’Ottocento, e il nostro recente Atlante di Roma antica, che ne è il succedaneo del tempo nostro (aggiornato nell’edizione in inglese della Princeton University Press, che verrà pubblicata nel 2017). Per noi architetture, costruzioni, spazi aperti come strade, piazze e cortili, contesti e paesaggi stanno al contrario al primissimo posto, rappresentando essi i contenitori di tutti gli apparati decorativi fissi e di tutte le cose utili e d’arte considerate mobili. Per non dire della moda scettica di oggi – imperversa perfino in una irriconoscibile Inghilterra –, che rifugge dal ricostruire le cose per quel che sono state – pratica ritenuta sostanzialmente impossibile – per dedicarsi esclusivamente ai “discorsi” svoltisi nel tempo su quelle stesse cose.10 Ma coloro che amano veramente i monumenti li analizzano sia nelle loro fasi antiche, sia nel loro progressivo rovinarsi, sia nei diversi modi in cui sono stati considerati fino ai giorni nostri sia nei loro rapporti contestuali antichi e moderni, ritenendo le congetture ricostruttive non solo possibili ma addirittura eticamente doverose per il nostro mestiere. Oggetti d’arte scissi da ogni contesto costruttivo nell’antichità non si danno; solo le merci hanno vagato per ogni dove, indifferenti a tutto il resto, come quelle ceramiche, che proprio per la loro straordinaria diffusione forniscono indici cronologici di amplissima portata, consentendo di datare ogni strato con il quale esse si trovino in stratigrafico rapporto.
In questo libro lo scavo di una strada come il clivo Palatino A, quello di una porta quale la Mugonia connessa a un tratto del murus Romuli e quello di un culto come quello di Giove Statore – tutti monumenti attribuiti a Romolo – e quello di vari altri monumenti connessi e vicini vorrebbe diventare un racconto rivolto a tutti i curiosi di un passato così lontano e fantasiosamente diverso da noi. Si vorrebbe anche spiegare come una scuola di archeologia, insolita in Italia – interessata non alla sola storia, alla sola antiquaria o alla sola storia dell’arte ma all’intero insieme della documentazione materiale – possa arrivare a scoprire il passato in tutta la sua consistenza, urbana e rurale, e a interpretarlo nel suo pieno significato, per dare aria, luce e prospettiva rinnovata alla storia di Roma, impigliata sovente solamente nelle fonti letterarie, che restano fondamentalmente sempre le stesse; mentre l’archeologia è in continua crescita… Per certi aspetti questo libro è un conciso manuale di archeologia applicata al fulcro della città cardine dell’intero Occidente; una introduzione alla disciplina basata su cose concrete ed esemplari.
VERITÀ INCERTE. Gli studiosi somigliano sovente a terroristi: cercano di far “esplodere” le casematte dell’avversario, che poi sono modeste e benigne ipotesi, a volte più giuste che errate e a volte il contrario, quasi che nel campo delle scienze storiche potessero esistere prove inconfutabili, falsificazioni indiscutibili, capaci di far saltare in aria congetture con la forza del due più due fa quattro. Noi lavoriamo, invece, su dati relativi alla vita umana, che sempre sorprende anche nelle società più regolate, documenti tutti e sempre da interpretare, per cui le ipotesi che avanziamo possono essere solamente più o meno probabili, argomentabili e verosimili, ma mai vere in assoluto, quindi per sempre e in ogni dove, per cui si tratta per la ricerca storica di un progredire a tratti, per tentativi ed errori, e gli errori non sono meno importanti dei raggiungimenti, in quanto loro genitori. Infatti, una parte della verità può trovarsi nelle nostre tasche, ma anche in quelle degli avversari (parlare di nemici qui è ridicolo, anche se fra gli studiosi le inimicizie irriducibili abbondano). Nessuno possiede mai l’intera verità, ma qualcuno può essere più abile di altri nel combinare fruttuosamente verità proprie e altrui, disponibili in un determinato momento, finché non si affaccia all’orizzonte qualcuno capace di far meglio, combinando efficacemente i dati a una immaginazione addestrata a capire le società di un determinato luogo e tempo.
ECCEZIONALE PLENUM DI FONTI. Abbiamo definito la zona della città da noi indagata “cuore di Roma”, perché in nessuna parte dell’urbe antica tanti monumenti, intimamente collegati fra loro e concentrati in uno spazio limitato, sono in sé e nel loro insieme altrettanto eloquenti riguardo alla storia mitico-sacrale, rituale, istituzionale, politica e urbanistica di Roma come in questa pendice del Palatino vicina al Foro, diventata in parte – per il santuario di Vesta – uno dei suoi epicentri sacrali insieme al culto di Vulcano al Comitium. Conoscevamo la zona nelle sue fonti letterarie e ora anche nelle sue grandi e minime strutture, per cui godiamo finalmente di una visione completa e organica di essa nel tempo, nello spazio e nello svolgersi dei suoi significati. Un tale eccezionale plenum di documentazione, che difficilmente ritroviamo nelle altre importanti città antiche – analogo al plenum musicale dell’organo – offre la migliore condizione per errare di meno e per cogliere meglio aspetti e momenti altrimenti inafferrabili di verità urbana. È anche la condizione ideale per esplicare l’archeologia in tutta la sua potenza straordinaria di azione e di comprensione, di fronte alla quale noi siamo in costante fase di apprendimento, di perfezionamento. Il massimo del raggiungimento si ottiene unendo il sapere umanistico alla tecnologia informatica, di cui non si tesserà mai a sufficienza le lodi (Mattia Ippoliti, ad esempio, è un piccolo maestro di Autocad). Questo libro si rivolge soprattutto ai giovani che hanno imboccato l’ardua strada della nostra disciplina, ormai ben regolata nei suoi metodi promiscui come in quelli più autonomi, e a tutti gli appassionati della storia più lontana (e la memoria riconoscente va a due amici scomparsi da cui tanto abbiamo appreso, il protostorico Renato Peroni e il medievista Riccardo Francovich).
***
DUE LIBRI PERCORRONO DUE CLIVI. Torniamo a Tito Tazio che, avanzando dall’Arce per la Sacra via conquista la bassura che sarà del Foro mirando a espugnare il Palatino dove Romolo ha fondato la sua urbs. La porta Romanula è per lui fuori luogo perché non si trova su quella via. Superato il Foro, due strade a destra della Sacra via portavano al Palatino: la prima era il clivo Palatino A e la seconda, più distante, il clivo Palatino B. Appare logico che il re sabino non volesse perdere la prima occasione di svoltare a destra, allontanandosi troppo dalla retrovia e rimandando la penetrazione nel monte al secondo clivo. Ne consegue che lo scontro in cui i Romani prevarranno finalmente sui Sabini davanti alla vetus porta Palatii si è dovuto svolgere all’imbocco della prima strada, il clivo Palatino A, il solo a portare direttamente al principale nucleo insediativo del monte, quello posto in cima alle scale di Caco, dove era la capanna di Romolo e il luogo dove Roma era stata fondata: quella era per Tito Tazio l’ambita meta (fig. 2).
Al tempo di Augusto dirigeva la biblioteca di Apollo, accolta nella propria casa, G. Giulio Igino, un liberto spagnolo educato ad Alessandria che Cesare aveva portato a Roma fin da bambino. Settantenne nel 10 d.C., era ancora lui a gestire la biblioteca, allorché un suo amico, il poeta Ovidio, gli ha indirizzato il libro dei Tristia perché potesse essere accolto nei venerandi scaffali, dove già erano custodite altre sue opere (fonte 12.5). Per raggiungere la casa di Augusto il libro di Ovidio segue un preciso itinerario: a) il Foro di Cesare, b) la Sacra via, c) l’aedes Vestae, d) la (domus) Regia di Numa: per Ovidio (fonte 12.1) sotto gli atria Vestae oppure per Servio (fonte 4.1) nella stessa aedes Vestae, mentre per Varrone (fonte 1.5) e per Plutarco (fonte 14.1) coincideva con la Regia presso la aedes Vestae. «Quindi, e) voltando dalla Sacra via verso destra (subito dopo gli atria Vestae verso il Palatino, quindi imboccando il clivo Palatino A): qui – dice – è f) la porta del Palatino (o Mugonia), ecco g) Giove Statore ed ecco h) il luogo dove da principio Roma è stata fondata e i) la dimora degna di un dio, … la casa di Giove (cioè la casa di Augusto assimilato al sommo dio), con la sua porta (analiticamente descritta), con il tempio di Apollo, con il portico delle Danaidi e con la biblioteca di Apollo (custodita da Igino, a cui il libro di Ovidio era indirizzato)» (fig. 5). Quindi il clivo Palatino A è, ancora in età augustea – potremmo aggiungere fino a Claudio – la via principale e normale per chi vuole inoltrarsi nel Palatino, diretto al suo epicentro sacrale, rituale e insediativo: il luogo della fondazione di Roma e la casa di Augusto. Per non dire che il clivo Palatino portava direttamente all’indirizzo, mentre il clivo Palatino B implicava un “giro pesca”.
Usando lo stesso espediente letterario, cioè personificando un proprio libro che diventa itinerante, Marziale chiede al primo libro dei suoi Epigrammi di portare i propri saluti alla splendida dimora in cui abita G. Giulio Proculo, che poi è la domus Augusti/Augustiana al tempo di Domiziano (fonte 18.1). Descrive quindi l’itinerario che il libro deve seguire, che però non è più quello descritto da Ovidio, perché nel frattempo il clivo Palatino A è stato chiuso al pubblico dall’espansione dei giardini della domus Tiberiana dovuta a Nerone. Ecco le tappe dell’itinerario: a) il tempio dei Castori (nel Foro), b) l’aedes Vestae e la casa delle Vestali, c) il clivo Sacro o Sacra via percorsa in direzione del Palatino (quindi salendo), d) il colosso del Sole (eretto da Vespasiano nel 69-79 d.C. in quello che era stato il vestibulum della domus Aurea, oramai demolita per dar luogo all’anfiteatro Flavio); e) giunto in cima al clivo Sacro, il libro svolta a destra e imbocca salendo il clivo Palatino B, poi f) incontra le statue di Domiziano (che ornano l’arcus che immetteva nell’area Palatina, g) imbocca e percorre il vicus tectus che bordava la domus Tiberiana verso l’area Palatina e sbocca finalmente all’estremità sud di quello che era stato il clivo Palatino A, h) quindi gira a sinistra (verso le scale di Caco) e perviene i) all’atrio della casa di Augusto, dove sono l) il culto di Bacco (addossato al muro esterno di quella casa) e m) il vicino culto di Cibele o della Magna Mater (fig. 6). Nella casa di Augusto era la biblioteca con sul retro l’abitazione di Proculo, un liberto della famiglia giulio-claudia, allo stesso modo di Igino e del suo successore Modesto, probabile custode della biblioteca di Apollo al tempo di Domiziano.
I due itinerari che dal Foro conducono i due libri alla casa di Augusto, il primo direttamente per il clivo Palatino A (dal fornix Fabianus alla casa di Augusto, m 424) e il secondo molto più indirettamente – in un “giro pesca” – per il clivo Palatino B (dal fornix Fabianus alla casa di Augusto, m 708), sono molto diversi tra loro sia nelle tappe che nella lunghezza.
Il problema della vulgata topografica è tutto qui: nel non aver inteso questi due modi successivi di raggiungere dal Foro il luogo della capanna di Romolo e della casa di Augusto, proiettando una condizione valida solamente a partire da Nerone e soprattutto successiva all’incendio del 64 d.C. in tutti i tempi precedenti, fino alle origini della città. È un difetto che in archeologia implica il confondere una pianta di fase con un’altra assai diversa, che viene modernizzata e assolutizzata come l’unica possibile. Invece le diverse fasi devono essere accuratamente distinte in tutti gli aspetti nelle diverse fasi stratigrafiche, le quali configurano altrettanti diversi assetti topografici. Solo una conoscenza analitica di tutti i luoghi in questione consente ciò, ché altrimenti si semplifica partendo dall’assetto tardo, logicamente rispecchiato anche nell’assetto ultimo e più leggibile delle rovine che oggi siamo in grado di percorrere. Ma quando mai, leggendo l’ultimo capitolo di un romanzo, si arriva a intendere i precedenti? Capire la storia significa intenderne le trasformazioni, i mutamenti. Ma ora dobbiamo allargare lo sguardo a tutto questo cuore di Roma considerato nelle sue fonti letterarie.
Sacra via
UNA VIA UNITARIA. Si tratta della strada principale del sito di Roma in direzione est-ovest o viceversa che dalle Carinae presso la Velia, rilievo dell’aggregato dei montes, conduceva all’Arce, rilievo legato da un lato al Campidoglio e dall’altro al Collis Latiaris, che apparteneva all’opposto aggregato dei colles. Questa importanza della Velia, dovuta al fatto che il caput della Sacra via si trovava in una sua propagine (le Carinae), fa pensare addirittura a una origine pre-urbana della via, quando tra i trenta populi legati ad Alba erano i Velienses, per cui saremmo tra la fine dell’XI, quando si è formato il gruppo etnico dei Latini, e la fine del X secolo a.C., quando hanno avuto inizio i processi di aggregazione proto-urbana.
Si trattava di una via che percorreva il fondovalle tra il Palatino e la Velia, i due monti principali del Septimontium, che è già una aggregazione protourbana. Essa poi costeggiava il limite settentrionale della bassura del Velabro, invasa stagionalmente dalle acque del Tevere, e raggiungeva infine la radice dell’Arce, alla quale si saliva tramite scalae (Gemoniae). Quando con la fondazione di Roma il Palatino si staccherà dalla Velia in quanto unico monte inaugurato e cioè benedetto da Giove, questa via chiamata Sacra, per via delle cerimonie che vi si svolgevano e per il foedus tra Romani e Sabini che era stato contratto sul suo percorso, è rimasta opportunamente esterna al pomerium che delimitava l’urbs, la quale per inviolabile tabù non poteva essere contaminata da uomini e armi macchiati di sangue, fossero essi in processione (come nell’ovatio) oppure in assemblea (come nel Comitium al Foro).
UNA VIA IN DUE TRATTI. Evidente è il significato originariamente unitario di questa via, forse già pre-urbana e più sicuramente proto-urbana. Ma con la creazione al suo lato meridionale del santuario di Vesta che includeva le case delle Vestali e dei re-auguri, con la definizione dei culti della Velia, con la configurazione del Foro e con il Comitium legato al santuario di Vulcano o Volcanal la via ha cominciato a essere distinta in due tratti, di circa pari lunghezza ma diversi per status: un primo tratto, molto significativo dal punto di vista mitico, sacrale, rituale, istituzionale e politico, posto tra il Foro e il limite est del santuario di Vesta o poco oltre, là dove cominciava la salita, e un secondo tratto, meno significativo, che proseguiva fino al caput che si trovava presso il sacellum di Strenia alle Carinae – qui erano gli accessi principali alla Velia, tra i quali la stradina che scende al vicus Cuprius dove era il giogo del tigillum Sororium –, dopo di che la Sacra via si trasformava in vicus Cuprius (fig. 7); questo secondo tratto perderà poi definitivamente di rilevanza quando non borderà più la zona sancta e cioè inviolabile esterna alle mura palatine e verrà circondata, su entrambi i lati, da domus private seppure dell’aristocrazia, che hanno preso il posto del murus Romuli intorno al 530 a.C. (figg. 14, 19). Così il tratto legato al centro sacrale, regale e politico della città ha cominciato a contrapporsi a un mero clivo per le Carinae, dal carattere eminentemente rionale e cioè insediativo. Nella città-stato sopra l’aristocrazia stavano gli dèi e la sovranità, che si trovano al culmine della gerarchia urbana.
COME DISTINGUERE I TRATTI. Il processo di differenziazione sopra descritto appare canonizzato nella descrizione della via da parte dei due massimi antiquari di Roma: Varrone e Verrio Flacco (in Festo). I suoi due tratti erano distinti anche orograficamente. Il primo era sostanzialmente dritto e in pianura e raggiungeva il suo termine al principio di salita: il primoris clivus di Varrone (fonte 1.2); il secondo tratto, invece, si muoveva con ampia curva, circondando le radici della Velia, e si configurava per la salita come un clivus. Il primo tratto era contraddistinto anche dal percorso rituale del re, che dalla sua casa nel santuario di Vesta si recava per attuare la politica al Comitium, dove incontrava i rioni o curiae riuniti in assemblea, posto ai piedi dell’Arce dove era l’Auguraculum da cui si osservava il volo degli uccelli che autorizzava o meno le riunioni; inoltre dal Comitium il re anche fuggiva nel Regifugium, per tornare nel santuario di Vesta e nella sua casa. Sanciva infine la conclusione del primo tratto l’incrocio fra la Sacra via e il clivo Palatino A a sud e la “scorciatoia” per le Carinae a nord; mentre il secondo tratto della Sacra via o clivus Sacer aveva finito per rappresentare la strada più lunga e agevole per le stesse Carinae.
I SEGMENTI DEL PRIMO TRATTO. Il primo tratto si articolava a sua volta in due primi segmenti tra la radice dell’Arce e il fornix Fabianus, in cui la via non spiccava, limitandosi a bordare il Foro, per cui avrà edifici solamente sul lato nord, e in un terzo segmento compreso fra il santuario di Vesta e la zona sub Veliis dove si trovavano i più rilevanti culti di quel monte, per cui la via qui appariva bordata su entrambi i lati da una serie di edifici e aree sacri e da case di sacerdotesse, di re sacerdoti e di sacerdoti, tutti dall’altissimo significato sacrale e pubblico. È questo nel suo insieme il tratto principale della via. Il terzo segmento coincideva con la parte summa, la più nota, della via, che si trovava subito a est del Foro (fig. 7). Esso presupponeva gli altri due segmenti, il primo coincidente con la parte infima o ima della via e il secondo che coincideva con la parte media della via (Dionigi di Alicarnasso, fonte 6.3). Erano queste parti meno note della summa, perché scomparivano rispetto alla preminenza del Foro. Ai segmenti del tratto più famoso della via corrispondevano probabilmente i tre Giani, imus, medius e summus (Cicerone, fonte 2.14; Schol. in Hor. Satire, 2.3.18-20, Epistole, 1.1.53-56) e il Foro infimo e quello medio, attestati in Plauto (Curculione, 4.1.10-23).
I SEGMENTI DI TITO TAZIO E DI ROMOLO. Infine il tratto preminente della via era delimitato dalla parte dei Rostra da una statua di Tito Tazio e dalla parte del Palatino da una statua di Romolo, da immaginare al limite fra il Foro con la media Sacra via e la summa Sacra via. Il Foro con i suoi culti lungo la Sacra via infima/ima e media, tutti attribuiti a Tito Tazio, appariva come una estensione verso il Palatino del Campidoglio/Arce, che veniva attribuita a re sabino (Dionigi di Alicarnasso, fonte 6.3; Tacito, fonte 19.1). Tra la fine del Foro e il clivo Palatino A era la parte più alta del tratto, la summa Sacra via, zona che gravitava sul e rientrava nel complesso del Foro, quindi dal carattere “fuori” porta, ma che orograficamente apparteneva al Palatino (Numa e Anco Marcio avrebbero abitato nel Palatino…) e questo segmento di via non poteva che essere presidiato, a uno dei suoi capi, da Romolo, che l’aveva preservato dall’attacco sabino grazie all’aiuto di Giove Statore. Insomma, il primo e principale tratto della Sacra via era quello miticamente rilevante per quanto riguardava l’episodio finale della guerra fra i due popoli, che aveva dimostrato la parità fra i due re. Tito Tazio aveva contribuito al facimento di Roma con il Campidoglio, l’Arce, il Foro e i primi due segmenti della Sacra via, da lui mai persi. Romolo ha contribuito con il Palatino, unico monte inaugurato, con il segmento sommo della Sacra via e concedendo al complesso del Foro parte del Palatino rimasto fuori porta, con il santuario di Vesta e la dimora ufficiale regia (la casa iniziale di Tito Tazio era immaginata sull’Arce come quella di Romolo sul Palatino/Cermalus). Ben più prosaico e meramente funzionale era il secondo tratto della Sacra via che portava alle Carinae con il suo clivo divenuto eminentemente insediativo.
SUMMA SACRA VIA. Secondo Varrone e Verrio Flacco (in Festo) la summa Sacra via si estendeva tra il limite est del Foro – si può prendere come riferimento il fornix Fabianus (Cicerone, fonte 2.8) oppure la Regia/fanum ospitante i sacraria di Marte e Ops (Verrio Flacco in Festo) – e il primoris clivus (Varrone) oppure la casa del re dei sacrifici (Verrio Flacco in Festo), l’antico re-augure ridotto ad sacra, il più importante sacerdote della città istituito probabilmente da Tarquinio Prisco, sovrano di transizione tra gli antichi re-auguri e i tyrannoi che furono Servio Tullio e Tarquinio il Superbo. Le indicazioni dei due antiquari sostanzialmente coincidono, anche se il primoris clivus (Varrone) sembra cominciare oltre la casa del re dei sacrifici (Verrio Flacco in Festo) e cioè all’incrocio della Sacra via con il clivo Palatino A e con la “scorciatoia” per le Carinae, per cui rimane lo spazio per un altro edificio (la casa dei Tarquini/domus Publica), che Verrio Flacco non può più nominare perché al suo tempo era stato demolito da Augusto che si era costruito una domus Publica nella sua casa, sul versante opposto del Palatino. Augusto aveva poi conferito la casa del re dei sacrifici alle Vestali, perché aveva un muro in comune con il loro edificio (Cassio Dione, fonte 25.2). Il fatto ha grandi conseguenze topografiche perché presuppone che la casa del re dei sacrifici (Verrio Flacco in Festo) e il corrispondente primoris clivus (Varrone) – entrambi al culmine della summa Sacra via – si trovassero vicino alla casa delle Vestali (non sulla sella tra Palatino e Velia, come da sempre ha voluto la vulgata topografica). I re dei sacrifici e i loro predecessori, i re-auguri, dovevano abitare pertanto nel santuario perché dovevano esercitare la patria potestas sulle Vestali (ma come esercitarla se le loro case si trovavano lontane, sulla sella tra Velia e Palatino, come vuole la vulgata topografica?). La presenza nel santuario del re dei sacrifici ha permesso di abitare subito fuori del santuario (seppure come vedremo in collegamento con esso tramite uno stretto passaggio) prima ai Tarquini, che volevano alleggerire il peso sacrale per aumentare la propria potenza politica e militare, e poi – nella medesima casa da Regia (dimora dei re) a Publica (dimora del pontefice massimo) – ai pontefici massimi, che la Repubblica aveva posto al vertice dell’ordine sacerdotale: unici ormai a esercitare la patria potestas sulle sacerdotesse di Vesta; intanto i re dei sacrifici erano stati relegati al fondo dell’ordine sacerdotale (figg. 14, 15).
ESTREMITÀ DELLA VIA. Per i due grandi antiquari la descrizione della via muove sempre da ovest a est, probabilmente perché la via summa è il tratto finale del tratto più rilevante, composto anche della via infima e dalla media. Essi ci fanno sapere altresì che solo la via summa era quella comunemente conosciuta, cioè nota al volgo. Anche Plutarco (fonte 17.5) considera la via da ovest a est, mentre fa il contrario solamente Galeno: dal tempio di Roma ai Fori (fonte 24.1). Dal 64 d.C. buona parte del secondo tratto della via, tra la sella che legava Velia e Palatino e le Carinae, è finita sotto il vestibulum della domus Aurea, per cui non si fanno più le vecchie distinzioni e la Sacra via non è più che il vialone rettificato e porticato che porta dal Foro al Colosso/tempio di Roma, o viceversa. Di fatto, ogni strada ha due estremità per cui ha un significato ancipite. Infatti, per gli antiquari (Varrone, fonte 1.2; Festo, fonte 28.3), cose sacre venivano portate mensilmente all’Arce (a partire dalle Carinae), mentre viceversa dall’Arce e in direzione opposta si muovevano gli auguri. Il segmento sommo del primo tratto della via coincideva sostanzialmente con il santuario di Vesta da una parte e con la zona dei culti della Velia dall’altra, per cui appariva come un tratto eccellentissimo, mentre i segmenti infimo e medio, anch’essi parte del primo tratto, si confondevano con la piazza del Foro; mentre il secondo tratto della via, coincidente con il clivo Sacro per le Carinae, riguardava una zona priva di monumenti sacri e pubblici, a carattere meramente residenziale e quindi rionale.
ARCUS IN SUMMA SACRA VIA. La collocazione della summa Sacra via appare confermata anche dalla posizione dell’unico arco archeologicamente ben documentato in tutto il percorso della Sacra via rettificata, allargata e porticata a partire da Nerone, nel quale sta l’unica possibilità di riconoscere l’arcus in summa Sacra via del rilievo degli Haterii (fig. 8). La figurazione dell’arco è troppo diversa dall’arco di Tito, che per di più si affaccia non sulla Sacra via bensì sul clivo Palatino B, per cui è fuori questione. Si tratta di un arco previsto ed edificato da Nerone, dopo il 64 d.C., funzionale a un accesso alla sua domus Tiberiana dotato di grandiosa scalinata. Ma la decorazione dell’arco è del tempo di Domiziano, ed essa bene si inserisce nel portico della Sacra via, là dove si imboccava la penultima variante del clivo Palatino A (A2a), la quale però a quel tempo portava a un lato secondario di quella domus (fig. 18). L’arco non era più una porta – Mugonia o Palatii, anche se latamente ne era l’erede –, perché si affacciava sulla Sacra via, collegata non più al ricordo delle mura ma appunto al porticato strettamente connesso a quel vialone di regime. D’altra parte il clivo Palatino A non conduceva più sul lato opposto del Palatino ma oramai solo a quello che era diventato un lato oscuro della domus Tiberiana. Infatti gli ingressi principali di questa domus a carattere strettamente privato si aprivano ora verso l’area Palatina, cui si perveniva tramite il clivo Palatino B, e tramite le rampe connesse alla grande aula domizianea e al templum Minervae situati vicino al Foro. Del clivo Palatino A, già principale accesso al Palatino, restava una inutile ombra, definitivamente superata, con i Flavi, dal clivo Palatino B, la cui importanza la vulgata topografica ha voluto proiettare, contro ogni storia, anche negli ottocentoventi anni in cui il clivo Palatino A aveva indefessamente prevalso. Nel rilievo degli Haterii l’arcus appare al fianco dell’aedes Iovis Statoris, che nella nostra ricostruzione si trovava quasi di fronte (la distanza fra i due assi è di m 22), per la prima volta in summa Sacra via dopo lo spostamento del culto nella regione IV (figg. 18, 37). Comunque appare abbastanza straordinario che il segmento iniziale dell’ormai magniloquente clivo Sacro Neroniano-Flavio potesse essere ancora distinto come summa Sacra via, rispecchiando così nella Roma risorta una realtà del cuore antico della città, in verità finito sotto terra.
TENDE PER L’OMBRA SULLA VIA. Infine è da ricordare che Cesare ha voluto ombreggiare (suppongo con tende) la Sacra via, a partire dalla sua casa (ancora la domus Publica?), fino al Foro e oltre, per la salita che portava al Campidoglio (fig. 15). Aveva deciso di coprire tutto il tratto principale della Sacra via (Plinio, fonte 16.3), ma ha escluso, invece, il tratto secondario della via, come per dire: se lo ombreggino, se vogliono, le grandi famiglie che ci vivono ai fianchi… Così il volgo si era dimenticato della Sacra via unitariamente concepita, i potenti e i colti più non se ne curavano e solo gli antiquari ricordavano stati di cose tramontate. I seguaci della vulgata topografica non vogliono intendere tutto ciò, perché è doloroso rinunciare alle proprie idee, specie quando si cristallizzano in credenze accademiche identitarie. Un poco come certe ideologie, che la storia ha ampiamente smentito, e che tuttavia animano segretamente le menti di certi indefessi ritardatari.
Nova via
UNA VIA BREVE E DI NON LUNGA DURATA. Mentre la Sacra via era una strada probabilmente più antica di Roma, lunga circa 630 metri, di cui il tratto primo e principale era lungo 306 metri, la Nova via – Nova rispetto alla Sacra – è stata creata solamente quando, entro un bosco in grande parte sanctus perché immediatamente al di fuori delle mura (il limite era fissato dal promoerium, corrispettivo esterno del pomerium), è stata aperta una radura o lucus per consacrarla a Vesta intorno alla metà dell’VIII secolo a.C. (fig. 13). La strada aveva il suo caput infimo al Velabro, dove presso il sacellum/sepulcrum di Larunda era un approdo; infatti il Velabro era in origine navigabile ai piedi del Palatino e da questo suo approdo più interno si poteva raggiungere in barca l’Aventino (Varrone, fonte 1.1; Festo, fonte 28.2), dove era l’approdo di Roma sul Tevere presso l’ara Maxima di Ercole. Da questo approdo fluviale si poteva navigare nelle acque interne da una parte fino ai piedi delle scale di Caco e dall’altra fino al fondo del Velabro e lì si era a due passi dalla casa del re di Roma. Il caput sommo di questa via era invece dove essa si congiungeva al clivo Palatino A, all’altezza del templum con fanum di Giove Statore. La via si disponeva in modo da seguire la curva del monte, bene rispecchiata anche dal vicus Vestae e dal suo confluire nella summa Sacra via. Se la Nova via, invece di accostarsi alla Sacra via, avesse puntato verso est, conservandosi fino in fondo parallela alla Sacra via, in direzione del clivo Palatino B, come vorrebbe la vulgata topografica, sarebbe penetrata nel pomerium, fatto non consentito a una via, che doveva tenersi al di fuori della città inaugurata.
Si trattava di una via molto più corta (m 192) della Sacra via (m 630), inferiore anche al solo suo tratto principale (m 306). Ciò nonostante si articolava in due parti: infima tra Velabro e grosso modo la casa delle Vestali e summa grosso modo tra il culto dei Lari e quello di Giove Statore. Intorno alla metà del VI secolo a.C. la via è stata accorciata e interrotta a est dalla costruzione ampliata della domus Regia, sede prima di Servio Tullio e di Tarquinio il Superbo, poi di alcuni Valeri e infine dei pontefici massimi (fig. 14). Intorno al II secolo a.C. la via è stata poi interrotta anche a ovest dalla edificazione delle scalae (Graecae, Anulariae?) che hanno sostituito la primitiva rampa che portava alla porta Romanula, per cui l’ultimo segmento della Nova via infima, quello più prossimo al Velabro, è rimasto da allora separato dal restante percorso, oramai esclusivamente interno al santuario di Vesta. Con il 64 d.C. la Nova via sparisce per sempre. Non esiste pertanto una Nova via posteriore a quella data, se non nel breve tratto tra le scalae per la porta Romanula e il Velabro (fig. 9).
FALSA NOVA VIA. La falsa Nova via posteriore al grande incendio è l’erede di tutt’altra strada, cioè di un tratto di quella che passava al disopra il nemus Vestae, da noi chiamata vicus sopra il nemus Vestae a est della sua prosecuzione verso est, percorsi a noi noti dal 530 a.C. circa. Si trattava pertanto di una strada a monte delle mura, quindi interna a esse, la cui distanza dalle mura oscillava, procedendo da ovest verso est, tra gli oltre 45 e gli oltre 20 metri. Tutto ciò ha la conseguenza che questo percorso segna il limite tra la X e la VIII regione, nella parte che includeva il santuario di Vesta e probabilmente anche la domus Publica, ma più a est, oltre il clivo Palatino A, non segnava affatto il limite fra la regione X e la IV, che passava invece lungo il limite sud della Sacra via, per poi proseguire lungo il limite nord del vicus Curiarum (fig. 9).
Da strada principale di accesso agli edifici del lucus Vestae, la Nova via è diventata in seguito un percorso interno al santuario, reso sostanzialmente inutile da una Sacra via che intorno alla metà del VI secolo a.C. è stata ricostruita, dotata di fogna con fognoli laterali provenienti dagli edifici, al di sopra del fossato riempito, per cui è diventata il percorso ideale per accedere agli edifici posti a sud del suo percorso, che hanno rivolto su di essa le loro facciate e ingressi principali (fig. 9).
FONTI LETTERARIE SULLA NOVA VIA. Per Cicerone (fonte 2.10), il lucus Vestae – da intendersi piuttosto come il nemus Vestae – scendeva dalle radici del Palatino fino alla Nova via. Varrone (fonti 1.1, 1.3-4) attesta che dal sacellum Velabrum – da identificare probabilmente con il sacellum di Larunda, la Mater Larum – si accedeva salendo all’infima Nova via; testimonia inoltre che la porta Romanula aveva una gradinata sulla Nova Via che conduceva al sacellum di Volupia (lo stesso di quello di Larunda?); ricorda infine che i sacerdoti offrivano nel Velabro un sacrificio funebre ad Acca Larentia, sempre la Mater Larum, al suo sepulcrum, posto vicino alla porta Romanula, da dove si saliva alla infima Nova via (figg. 12-15). Ovidio (Fasti, 6.395-397) scrive: «tornando dalla festa di Vesta, sono passato per caso dove attualmente la Nova via si congiunge con il Foro» (tramite il vicus Tuscus o il passaggio esistente tra il tempio dei Castori e la fonte di Giuturna). Gellio (fonte 1.6) testimonia che per Varrone l’ara di Aius Locutius si trovava nell’infima Nova via e Livio (fonte 8.5) precisa che il sacellum si trovava sopra l’aedes Vestae, quindi tra la aedes e la Nova via; si trattava forse di un templum/fanum (fonti 8.6-7).
LA NOVA VIA E I SUOI CULTI. Questo insieme di fonti indica che la infima Nova via congiungeva il Velabro con il santuario di Vesta, nel quale penetrava dietro all’aedes Vestae dove era il culto di Aius Locutius. Era una via che collegava i culti in origine marginali, paganici e protettivi delle mura, legati al mondo infero del Velabro e alla fine dell’anno, tra i quali spiccava Larunda/Tacita, la Madre dei Lari, a quelli interni al santuario di Vesta e cioè Vesta stessa con Lari. È interessante notare che Romolo, terminato il sulcus primigenius, sul quale sorgerà il murus, prega una triade divina, Giove, Marte e Vesta, nella quale Quirino è stato sostituito dalla dea del fuoco comune. Come le tre porte di Gubbio erano protette da Giove, Marte e Vofiono (dio locale corrispettivo di Quirino), così le tre porte di Roma erano probabilmente così protette: la Mugonia da Giove Statore, quella sul lato opposto del Palatino da Marte coadiuvato da Fauno (gli dèi del Lupercal) e la Romanula da Vesta, coadiuvata da Larunda e dai suoi figli i Lari (il cui dies natalis coincideva con quello di Giove Statore).
LA VIA CHE PORTA AL LUCUS VESTAE. Sappiamo poi che la casa di Tarquinio Prisco, eretta su un lotto donatogli da Anco Marcio, era situata presso la porta Mugonia e presso il templum con fanum di Giove Statore e si trovava anche supra la summa Nova Via, con ingresso e finestre della facciata rivolti a essa (Varrone, fonte 1.5; Livio, fonte 8.3); per cui il retro della casa era rivolto alla Sacra via, allora ancora infossata. Siccome il templum con fanum di Giove Statore si trovava al principio della Sacra via per chi andava (dal Foro) al Palatino (Plutarco, fonte 17.5), se ne deduce che la summa Nova via, con la porta Mugonia e con il templum e fanum di Giove Statore, si trovava vicino alla e in corrispondenza della summa Sacra via, da intendersi nella accezione di Varrone e Verrio Flacco (in Festo) e quindi all’inizio per chi andava per la Sacra via (dal Foro) verso il Palatino descritto da Plutarco; non più lontano verso est, alla sella tra Velia e Palatino, come da sempre ha voluto la vulgata topografica.
Porta Mugonia, culto di Giove Statore, casa degli ultimi re/domus Publica
PORTA MUGONIA/VETUS PORTA PALATII. Nel descrivere i monumenti si procede da est verso ovest. La porta Mugonia (figg. 10-11) si trovava vicino al templum con fanum di Giove Statore (Livio, fonte 8.9) e portava dalla Sacra via al Palatino (Dionigi di Alicarnasso, fonte 6.4). Era posta a cavallo del clivo Palatino A, che a quel monte portava, mentre la Sacra via bordeggiava a settentrione il Palatino, senza mai entrarvi, per terminare alle Carinae. Più precisamente, il templum/fanum di Giove Statore era stato istituito da Romolo «davanti alla bocca (o ingresso) del monte Palatino» (Ovidio, fonte 12.4), quindi di fronte alla porta Mugonia/Palatii – come si conviene a un culto che aveva difeso quella porta, per cui doveva trovarsi tra la Sacra via e la porta stessa, proprio alla radice del monte (Pseudo-Cicerone, fonte 26.1; l’autore pone a quella stessa radice anche il culto di Victoria, influenzato forse dal fatto che i culti di Giove Statore e di Vica Pota/Victoria si trovavano al suo tempo vicini e nella stessa IV regione).
TEMPLUM/FANUM DI GIOVE STATORE. Il templum/fanum di Giove Statore era il primo monumento a trovarsi senz’altro nella regione X Palatium, dato che il lucus Vestae e la domus Tarquiniorum/Publica rientravano verosimilmente nella regione VIII includente il Foro. I Fasti di Priverno pongono il culto in Palatio (fonte 7.1). Se la casa di Tarquinio Prisco aveva la facciata rivolta alla Nova via (Livio, fonte 8.3), perché a quel tempo il fossato di fondovalle, includente la Sacra via, non era stato ancora riempito, allora il clivo Palatino A, con la porta Mugonia/Palatii e con il templum/fanum di Giove Statore, doveva passare lungo il lato orientale di questa ultima domus Regia e la summa Nova via doveva confluire nel clivo Palatino A tra la porta e la Sacra via, all’altezza del templum/fanum di Giove Statore, quindi oltre porta e murus, come a una via si conveniva. Un tale confluire di tre strade non è immaginabile altrove in tutta Roma, a meno di inventarsi una falsa Nova via, mai realmente esistita.
DOMUS REGIA TARQUINII PRISCI, SERVII TULLII, TARQUINII SUPERBI. La casa di Tarquinio Prisco, dove era stato concepito e dove era stato allevato come un figlio Servio Tullio la cui madre era la serva Ocrisia, è stata poi ricostruita estendendola verso sud dagli ultimi due re, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo (le loro dimore gentilizie sull’Esquilino non rappresentavano la sede regia ufficiale). Questa ultima domus Regia è stata probabilmente la prima con atrium a Roma e anche la prima ad avere la facciata rivolta alla summa Sacra via, rifatta a una quota più elevata dopo il riempimento del fossato. È possibile ma non sicuro che nella casa degli ultimi due re fosse esistita, non solo una Fortuna Privata nel thalamos (si veda oltre), ma anche una Fortuna Equestris nel vestibulum. Vi era stato solo il precedente di Anco Marcio e della regina da lui fatta raffigurare come una Venus Calva, ma fuori dal santuario, sub Veliis e cioè quasi di fronte (a m 20 di distanza circa). Intanto i culti di Marte e Ops erano stati spostati da Tarquinio Prisco in una Regia/fanum oltre il vicus Vestae. Questi nuovi re greco-etruschi volevano nuovi divini protettori e soprattutto la dea Fortuna procuratrice di sovranità. Anche le regine del tempo contavano moltissimo, devote a Fortuna, come la moglie di Anco Marcio, Tanaquil sposa di Prisco e la terribile Tullia coniugata al Superbo. Erano loro e la dea a fare e a disfare i re. Era un modello mentale e cerimoniale orientale in cui era la regina/dea a gestire il passaggio del potere regale, e ciò avveniva nella camera da letto della reggia. Si ricordi la moglie del re di Lidia Candaules che costringe Gige, scoperto nella camera da letto che la guardava nuda, a morire o a uccidere il re e a succedergli (Hdt 1.8). Ciò accadeva alla fine dell’VIII o agli inizi del VII secolo a.C.
STATUA DI CLELIA/VALERIA. Nel 508 esisteva nel vestibulum della casa che era stata di Tarquinio il Superbo una statua equestre dell’eroina repubblicana Valeria (Annio Feziale, in Plinio, fonte 16.4); la statua era visibile dalla summa Sacra via (Livio, fonte 8.4), cioè nel segmento risalendo il quale si andava al Palatino (Plutarco, fonte 19.8) e scendendo il quale si andava al Foro (Dionigi di Alicarnasso, fonte 6.7). Ma per Plinio e Plutarco si trattava invece di una statua di un’altra eroina repubblicana, Clelia, oppure di Valeria. Per Feziale/Plinio il vestibulum e la statua equestre che lo adornava si trovavano davanti (contra) all’aedes di Giove Statore, votata entro il suo templum/fanum nel 294 a.C. Cosa abbastanza vera, ma solo in parte, ché l’aedes si trovava di lato e non di fronte a quella casa; ma forse è intervenuta qui una confusione con la situazione topografica posteriore al grande incendio, nota a Plinio, quando l’aedes, già sul Palatino, era stata spostata nella regione IV (fonti 36.1-2), cioè ai piedi della Velia, probabilmente davanti alla biblioteca del Templum Pacis, non lontano dall’arcus in summa Sacra via rappresentato vicino sul rilievo degli Haterii, davanti a dove era stata la casa del Superbo. Dopo il grande incendio la statua di Clelia o una sua copia poteva essere stata ricollocata proprio di fronte a quell’aedes spostata di regione (Seneca, fonte 13.2), ed era ancora visibile nel IV secolo d.C. (Servio, fonte 31.2). L’idea che si trattasse di Valeria e non di Clelia potrebbe spiegarsi con il fatto che alcuni Valeri si erano probabilmente insediati, tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C., nel punto più eccellente del Palatino, probabilmente da interpretare come la casa che era stata dell’ultimo re e che era stata ricostruita a pubbliche spese. Si trattava di M. Valerio Voleso console nel 505 e di M. Valerio Massimo dittatore nel 494 (Varrone, fonte 1.8; Dionigi di Alicarnasso, fonte 6.8; Plinio, fonte 16.5; Plutarco, fonte 17.4). Non era andato Valerio Publicola, padre di Valeria, ad abitare dove era sorta la dimora gentilizia di Tullo Ostilio sulla Velia (Cicerone, fonte 2.7), poi abbattuta e ricostruita sub Veliis, probabilmente all’incrocio tra la Sacra via e la “scorciatoia” per le Carinae? Forse la casa già di Publicola era rimasta per secoli una proprietà pubblica ed è forse nel suo lotto che si potrebbe immaginare la casa dove Cesare imperator era andato ad abitare nel 45 a.C., quasi una foresteria di stato. Se la casa di Tarquinio il Superbo si affacciava sulla summa Sacra via, vuol dire che questo segmento del tratto principale della via non si arrestava alla casa del re dei sacrifici (come sostenuto da Verrio Flacco in Festo), ma includeva anche la domus di Tarquinio il Superbo/Publica, per cui la fine della summa Sacra via e il limite della Regio VIII coincidevano, come è logico pensare, con il clivo Palatino A, quindi proprio al primoris clivus menzionato da Varrone, da intendersi come culmine della summa Sacra via. La akmé di Verrio Flacco è fissata all’8 d.C. e ciò fa pensare ch’egli abbia usato la casa del re dei sacrifici come limite della summa Sacra via perché la domus Publica, che si trovava subito più a est, era stata rasa al suolo da Augusto e sopra era stato edificato un prosaico horreum (figg. 15-16). Il dato è confermato da Plutarco (fonte 17.5), per il quale il luogo sacro a Giove Statore si trovava al principio della Sacra via per chi andava (dal Foro) verso il Palatino, passo che riconduceva alla summa Sacra via come descritta da Varrone. Confermano ciò Marziale, con il suo libro che sale da Vesta al Colosso per andare al Palatino e alla casa di Augusto (fonte 18.1) e Appiano (fonte 27.1) per il quale il Foro era vicino al culto di Giove Statore. Ciò contrasta con la aedes di Statore identificata dalla vulgata topografica in un basamento presso l’arco di Tito: perché quel luogo non è vicino al Foro, perché il basamento non ha a che fare con la Sacra via, perché si trova di lato e non davanti a una porta da immaginarsi a cavallo del clivo Palatino B (ma che non esiste realmente) e perché, conoscendo oramai il percorso delle mura alla radice del Palatino, il basamento verrebbe a trovarsi entro e non fuori di esse (quindi non nella IV regione). Il templum/fanum di Giove Statore, nella sua posizione originaria, si trovava sul Palatino, all’angolo tra il clivo Palatino A e la Sacra via già in salita. Le aste pubbliche che vi si svolgevano meglio poi si collocano vicino al Foro. Siamo pertanto al clivo Palatino A, imboccando il quale a destra della Sacra via, subito dopo l’aedes Vestae e la supposta Regia di Numa, si vedevano la porta Palatii e l’aedes di Giove Statore (secondo Ovidio, nei Tristia). Si noti infine che tra i monumenti distrutti dall’incendio del 64 d.C. Tacito (fonte 19.2) nomina la aedes di Giove Statore accanto alla Regia di Numa e all’aedes Vestae, per cui siamo ancora una volta lontani dalla sella tra Velia e Palatino. Per allontanare la casa del Superbo dalla Sacra via, la vulgata topografica ha dovuto immaginare l’improbabile e cioè che la statua di Clelia non fosse la stessa di quella di Valeria connessa alla casa del Superbo, contro l’opinione di numerosi autori (Livio e Dionigi per Clelia; Plinio, Plutarco per Clelia e Valeria; Feziale per Valeria).
LA PORTA MUGONIA/PALATII NELLE SUE VERSIONI. È assurdo voler collocare la porta Mugonia a cavallo del clivo Palatino B, similmente all’arco di Domiziano che marcava l’ingresso all’area Palatina e ai palazzi imperiali. Lungo questo percorso nessuna porta è mai stata rinvenuta, ma per la vulgata topografica l’assenza di un monumento non solo equivale alla sua presenza, ma addirittura primeggia su ogni altra materiale testimonianza. Noi invece abbiamo individuato (figg. 10-11): a) la porta Mugonia nelle sue varianti dell’VIII, del VII e del VI secolo (775-550 a.C.), a cavallo di una delle due forcelle che menavano al clivo Palatino A, e l’ultima versione coincide con il rifacimento già memoriale delle mura da parte di Servio Tullio che un papiro ben descrive (fonte 38); b) la porta Mugonia spostata leggermente a ovest (m 32), all’altra forcella che portava allo stesso clivo e che originariamente conduceva a una postierla; c) la porta Mugonia della prima metà del II secolo a.C. eretta sopra il pilone est della precedente porta; d) l’arcus in summa Sacra via, nuovissima creazione dal vetusto toponimo, posto a cavallo del clivo Palatino A spostato ancor più a ovest (m 34), per armonizzarlo con la scalinata della domus Tiberiana di Nerone, la cui facciata era rivolta alla Sacra via; e) il clivo Palatino A spostato più a est (m 9), per l’edificazione del grande oecus con i sei cubicula delle Vestali: una estensione dell’atrium Vestae al tempo di Traiano. Oramai il Palatino era solo più un aggregato di palazzi imperiali.
LA CITTÀ SI MUOVE. Gli spostamenti del clivo Palatino A non devono sconvolgere. Roma non è immota mummia, ma un organismo vivente che si muove. Muove culti sul Campidoglio salvo quelli di Iuventas e Terminus, menzionati come eccezioni e muove perfino di regione l’aedes di Giove Statore. Ragioni varie, dovute allo spostamento del pomerium e all’abolizione della sanctitas delle mura palatine al tempo di Servio Tullio, che hanno consentito una più ampia urbanizzazione del monte, oppure modificazioni di percorsi come le diverse fasi della Sacra via, come il clivo Sacro rettificato che portava alla domus Aurea e come il clivo Palatino A spostato non sono che variazioni su un unico tema. Così la principale salita al Palatino fino a Nerone e ai Flavi, il clivo Palatino A, cederà il passo al clivo Palatino B, che condurrà ai palazzi palatini: domus Tiberiana, domus Augustiana, domus Augusti (fig. 9). A tutta questa straordinaria e diacronica documentazione i fautori della vulgata continuano a preferire le loro monumentali nullità.
SERVIO TULLIO, LA FORTUNA E LA DOMUS REGIA SUL PALATINO. Plutarco narra una leggenda affascinante. La dea Fortuna, che aveva dato la sovranità a Servio Tullio aiutata dall’abilissima etrusca Tanaquil, moglie di Tarquinio Prisco morto ammazzato, si univa al re scendendo nella sua casa, probabilmente nel thalamos Fortunae, forse il tablinum che si apriva sull’atrium, visto che in esso generalmente si trovava il lectus Genialis. La dea penetrava in casa tramite una finestrella che ha dato il nome alla porta Fenestella, evidentemente comunicante con la domus di quel tiranno, posta a cavallo di una delle due forcelle che portava al clivo Palatino A. Esisteva sul Palatino un luogo sacro o sacrarium alla Fortuna Privata, molto probabilmente coincidente con lo stesso thalamos Fortunae che si trovava accanto alla porta Fenestella. Già Anco Marcio aveva eretto una statua di Fortuna Barbata/Venus Calva sub Veliis e ora che la domus Regia più non accoglieva i culti regi tradizionali di Marte e di Ops aveva dato spazio a Fortuna, la dea allora più in voga alla corte dei Tarquini. Si trattava pertanto non della casa di Servio sull’Esquilino, pure dotata di un altro culto a Fortuna, ma della residenza ufficiale del re sul Palatino (Ovidio, fonte 12.3; Plutarco, fonti 17.6-7; fig. 14), poi divenuta la casa di Tarquinio il Superbo. La porta Fenestella è da immaginarsi appoggiata al lato lungo orientale della dimora e in comunicazione con essa. Sostituiva una antica postierla e solo con Tarquinio il Superbo viene ricostruita, è diventata la nuova porta Mugonia, a cavallo dell’unica forcella rimasta per raggiungere il clivo Palatino A, dopo che nel frattempo la porta nella sua posizione originale, la sua forcella e le sue mura erano state sepolte sotto le case aristocratiche del 530 a.C. circa, poste a est del templum/fanum di Giove Statore e affacciate sul clivo Sacro, il tratto secondario della Sacra via, dopo che pomerium, agger e sanctitas erano stati spostati da Servio Tullio in modo da includere tutto l’abitato. Si trattava di prime case aristocratiche ad atrio, che probabilmente avevano preso a modello la domus Regia dell’ultimo Tarquinio. Il ritardo nell’urbanizzazione di questa zona non è stato dovuto pertanto alla natura argillosa del pendio, come pure semplicisticamente si è creduto, ma alla sanctitas che aveva protetto una striscia dietro e davanti alle mura e che verso la metà del VI secolo a.C. era stata spostata (figg. 10-11).
AUGUSTO PONTEFICE MASSIMO. Nel 12 a.C. Augusto succede a Lepido come pontefice massimo. I pontefici massimi dovevano avere sede in una domus Publica. È stato allora che la domus Publica, che aveva occupato il lotto della casa di Tarquinio il Superbo e che dal V al I secolo a.C. aveva ospitato i pontefici massimi e i loro annali, è stata distrutta e sopra di essa è stato costruito un horreum (figg. 15-16). Si trattava di un’antica proprietà regia, divenuta pubblica con la Repubblica. Essa non rientrava nel lucus Vestae, per cui Augusto ha potuto obliterarla, avendo deciso di edificare la sua domus Publica a est del tempio di Apollo, in posizione simmetrica rispetto alla sua casa privata, posta a ovest dello stesso tempio. Eliminata quella che era stata la domus Regia dei Tarquini e poi la domus Publica, che fare della domus Regia, prima dei re latino-sabini e poi dei reges sacrorum? La casa non aveva bisogno di essere obliterata, per dar luogo a un suo doppio altrove: infatti il sacerdozio persisteva, seppure molto diminuito, sempre insediato all’interno del lucus Vestae. Augusto ha deciso di affidare quel complesso alle Vestali, con le quali aveva in comune un muro. In realtà il muro in comune apparteneva all’aedes Larum, ma il culto era sempre stato strettamente connesso alla più antica domus Regia e in particolare alla casa di Anco Marcio, ultimo re-augure di Roma che vi aveva abitato, prima che la dimora fosse stata ristrutturata come casa del re dei sacrifici. Nel lucus Vestae erano esistiti pertanto due complessi: uno delle Vestali con il culto di Vesta e uno dei re e poi dei re dei sacrifici con il culto dei Lari.
DOMUS PUBLICA DEI PONTEFICI MASSIMI. La casa che era stata dei re e poi dei re dei sacrifici era una Regia e come Regia era nota anche la casa pubblica dei pontefici massimi, in quanto edificata sullo stesso lotto della casa dei Tarquini. Regia era anche il fanum che dai Tarquini aveva accolto i sacraria di Marte e Ops, probabilmente prima ospitati nella domus Regia dei re-auguri; quel nome derivava forse dal fatto che lì alcuni pensavano che fosse stata la Regia del re Numa – per Virgilio anche quella di Evandro – e anche perché i culti regi lì ospitati provenivano da una Regia e solo in una Regia potevano essere spostati. Queste tre Regie – una sola nel santuario e due ai suoi margini – non vanno confuse tra loro, come è facile fare. Non le confonde Cassio Dione (fonte 25.2), ma le confonde invece Servio (fonte 4.2), che nell’unificare le prime due Regiae – scomparse da tre secoli, ma di cui rimaneva la memoria antiquaria – è costretto a immaginare qualcosa di insensato e cioè che il re dei sacrifici e il pontefice massimo abitassero la medesima casa, mentre i tre Flamini maggiori abitavano ciascuno in case distinte. Il ragionamento di Servio è il seguente: a) la domus Publica era nota anche come Regia; b) Regia era per definizione la casa del re (fonte 4.2) e quella del re dei sacrifici; c) ne consegue che la domus publica equivale alla domus del re dei sacrifici, perché entrambe note come Regia. Ma se così fosse stato davvero, chi mai avrebbe abitato la casa posta tra quella del re dei sacrifici e il clivo Palatino A? La confusione nasce da un astratto principio analogico, denunciato da Servio stesso.
PASSAGGIO RIVELATORE. Un dettaglio aiuta a risolvere il problema e riguarda uno stretto passaggio. Infatti dal VI al I a.C. la domus degli ultimi due re e poi la domus publica sempre sono state dotate di un passaggio stretto, che consentiva di penetrare direttamente dalla casa esterna al santuario nel santuario stesso, subito dietro al fanum/sacellum di Orbona, che si trovava presso l’aedes Larum (Cicerone, fonte 2.12; Plinio, fonte 16.1; figg. 14-15). Il passaggio consentiva ai due ultimi re e ai pontefici massimi, fino a Lepido, di esercitare la patria potestas sulle Vestali, potendole ispezionare in qualsiasi momento del giorno e della notte. Il passaggio è dunque la prova che il lotto era quello donato da Anco Marcio a Tarquinio Prisco, che vi aveva edificato una prima casa, diventata poi, ristrutturata e estesa verso sud, la casa di Servio Tullio e di Tarquinio il Superbo, abitata poi da almeno due Valeri e infine dai pontefici massimi della Repubblica. La domus Tarquiniorum era diventata la domus Publica come la villa dell’ager Tarquiniorum, futuro Campo Marzio, era diventata la villa Publica.
Casa dei re-auguri, poi dei re dei sacrifici, culto dei Lari
DOMUS ANCI MARCI. La casa di Anco Marcio, ultimo dei re auguri latino-sabini, si trovava in summa Sacra via (Varrone in Nonio, fonte 30.1; Monumentum Ancyranum 10.1), più precisamente alle falde del Palatino vicino alla porta Mugonia. Vi si arrivava scendendo (la Sacra via in direzione del Foro) e lungo questa via (si trovava) a sinistra (Varrone in Nonio, fonte 30.1). L’indicazione è determinante, al punto che la vulgata topografica è stata costretta a dover smentire Nonio, che avrebbe male riassunto Varrone, confondendo la casa di Anco Marcio con quella di Tarquinio il Superbo (così come descritta da Varrone in Solino); per di più il passo di Nonio è stato male interpretato dalla vulgata topografica: «Ancum in Palatio, ad portam Mugionis, secundum (Novam) viam», mentre nel passo si allude evidentemente alla summa Sacra via (Varrone in Solino). Siamo nel campo della più completa arbitrarietà, che consente di non dover mai mutare opinione. È interessante notare che la parte di pendice inclusa nel lucus Vestae e poco oltre, anche se apparterrà all’VIII regione riguardante il Foro, rimaneva orograficamente connessa al Palatium.
DOMUS REGIS SACRORUM. Se il culmine della summa Sacra via era occupato, da est a ovest, dalla casa dei Tarquini/domus Publica e dalla domus Regia/casa del re dei sacrifici, la casa di Anco Marcio, ultimo dei re auguri latino-sabini, doveva trovarsi nel lotto dove è poi sorta la casa del re dei sacrifici, cioè del re ridotto ad sacra, perché il potere politico e militare era andato a un altro re, di un genere diverso, che nel lucus Vestae non poteva e non voleva più abitare; riducendo il tasso di sacralità, il nuovo sovrano aumentava il proprio potere in senso politico e militare e quindi secolare. Solo in quello stesso lotto potevano aver avuto la loro casa: Romolo, Numa (immaginato a torto nell’aedes di Vesta o nel fanum di Marte e Ops, che mai case sono state), Tullo Ostilio (la cui dimora gentilizia sulla Velia aveva fatto dimenticare la sede ufficiale) e Anco Marcio (ricordato invece dalle fonti in quanto ultimo re-augure che ha abitato nel lucus Vestae). Di conseguenza l’aedes Larum, connessa alla casa di Anco, doveva trovarsi tra quest’ultima e la casa delle Vestali (con la quale aveva un muro in comune). Il rapporto tra i Lari e Vesta è attestato sia da fonti letterarie (Virgilio, fonte 4.1; Silio Italico 3.566) sia da monumenti (come molti Lararia di Pompei).
SACELLUM/AEDES LARUM. Evidente è lo stretto nesso fra la domus Regia di Anco Marcio (e dei re-auguri che lo avevano preceduto) e il culto dei Lares, trasformatisi nel tempo: dai Grundiles (già di Romolo), ai Familiares (dei Tarquini), ai Publici (della Repubblica), ai Lares di Augusto. Il luogo era particolarmente adatto ai Lares, perché vicino al sacellum/ara e sepulcrum di Larunda, la loro Madre, e nei pressi del culto posto sub Veliis di Vica Pota (Asconio, fonte 1.8), la dea delle vicinitates e dei vici la cui festa coincideva con la conclusione della festa dei compita legata ai Lari. In età alto-arcaica si è trattato di focolari, probabilmente entro un recinto o sacellum, in età arcaica di una piccola aedes e nella tarda Repubblica di una aedes di forma particolare, sul genere dei templi a insula (o Hoftempeln), quindi con tabernae su fronte e fauces di accesso. Basta pensare a Marzabotto (Tinia), a Pompei (Giove Melichio, Lari Pubblici, Vespasiano, Iside e Bona Dea) e ai simili templi collegiali di Ostia. Nel caso di questo cuore di Roma, si trattava di culti a carattere domestico, generalmente non aperti al pubblico, cui potevano accedere solo sovrani e sacerdoti. L’aedes ha disposto, fino ad Augusto escluso, di un Lararium sotterraneo, entro penetralia illuminati da un oculus, con mensa per offerte incruente e pozzo/silos, cui poi si è aggiunta una cella bipartita. Infatti i Lari erano esseri sovraumani dal carattere infero, come la loro madre Larunda. Nessun senso avrebbe avuto un loro culto lontano da un tale organico contesto, quale la sella tra Velia e Palatino, come ha voluto la vulgata topografica. Non è quindi il caso di immaginare l’aedes Larum come un tempio isolato, imminente sulla Sacra via, e infatti essa aveva tabernae sulla summa Sacra via occupate da intrecciatori di corone e di fiori (Ovidio, fonte 12.4). In sintesi, sulla summa Sacra via, dopo l’aedes Vestae e la domus virginum vestalium, erano, da ovest a est, il culto dei Lares e la domus Regia dei re auguri divenuta poi la casa dei re dei sacrifici. Qui il lucus Vestae terminava. Subito oltre, ma sempre in summa Sacra via, era la casa del primo Tarquinio, quella ingrandita di Servio Tullio e dell’ultimo Tarquinio, ristrutturata poi a spese pubbliche probabilmente per accogliere alcuni Valeri, e infine per accogliere i pontefici massimi, casa a cui era stata addossata, fin dal tempo dell’ultimo Tarquinio, una riproposizione della porta Mugonia. Oltre il clivo Palatino A – ormai fuori del contesto forense e in pieno contesto palatino anche dal punto di vista anninistrativo – era il templum/fanum con ara e poi anche con aedes di Giove Statore, il quale già si affacciava sul tratto meno rilevante della Sacra via, che a partire di qui si presentava nella forma di un clivus che fino al grande incendio ha portato alle Carinae, che con Nerone, interamente ristrutturato, ha portato alla domus Aurea, che con Vespasiano ha portato al colosso di Sol e che con Adriano ha portato al tempio della dea Roma (fig. 17).
Non è il caso di soffermarsi sulla casa delle Vestali e sull’aedes Vestae, perché la loro posizione non è mai stata messa in discussione.
Tra clivo Palatino B e vicus Fabricius
DOMUS SCAURI. Per completare il discorso topografico bisogna spostarsi dalla summa Sacra via, verso il clivus Sacer, là dove incontrava il clivo Palatino B. La casa di M. Emilio Scauro, famosa per aver l’atrio più grande di Roma e per essere stata abitata da Clodio, si trovava in quella parte del Palatino che si incontrava scendendo per la Sacra via (in direzione del Foro) e prendendo la prima strada a sinistra, cioè il clivo Palatino B (Asconio, fonte 14.2). Il termine proximus implica che di strade a sinistra lungo la Sacra via ve ne doveva essere almeno un’altra: il clivo Palatino A. Infatti alla sella tra Velia e Palatino, la Sacra via si accostava a quest’ultimo monte, consentendo d’imboccare il clivo Palatino B. La casa di Scauro è stata individuata dagli scavi, con il suo basamento – pieno di celle per schiavi, con Lararium e balneum –, il quale poteva reggere le quattro colonne alte ben m 11,23 (38 piedi, Plinio, Storia naturale, 36.24). Si trovava all’angolo fra la Sacra via e clivo Palatino B, dove essa aveva i suoi ingressi connessi a un sistema di rampe (per questo le fonti non nominano la Sacra via). A sud di questa casa ve ne era un’altra, molto più piccola, che si trovava all’angolo della falsa Nova via. Per sbarazzarsi di questa casa che sappiamo sorgeva sul Palatino bisognerebbe spostarla addirittura a sud della falsa Nova via, in modo di concedere lo spazio tra Sacra via, clivo Palatino A, clivo Palatino B e falsa Nova via tutto alla IV regione, che è quanto vorrebbe la vulgata topografica. Infatti solo arretrando il Palatino il basamento presso l’arco di Tito, erroneamente identificato come aedes di Giove Statore, può rientrare nella regione IV indicata per quel culto dai Cataloghi regionari.
CURIAE VETERES E TEMPLUM DIVI AUGUSTI. La casa di Scauro presuppone che il Palatino e la sua X regione si trovassero lungo il limite sud della Sacra via e più a est, oltre il clivo Palatino A, lungo il limite sud del vicus Curiarum (Atlante, tav. 66). Al fondo di questo vicus stavano infatti a nord la meta Sudans augustea e il compitum Fabricium appartenenti alla regione IV e a sud la sede delle curiae Veteres la casa natale di Augusto con il sacrarium/templum del divus, emerso dagli scavi, che si trovavano nella regione X del Palatium (Plinio, Storia naturale, 12.94), più precisamente ad capita Bubula.
Non ha senso alcuno spostare il limite della regione X alla pendice alta del Palatino, oltre i 20 e i 45 metri più a sud, lungo il vicus ai piedi della Vigna Barberini e la falsa Nova via, dove la vulgata topografica ha ricostruito con grande fantasia le mura palatine proprio dove ormai dimostrabilmente esse non sono. Infatti si trovavano alla radice del Palatino, come vogliono Messalla (Gellio, fonte 23.1) e i tratti delle mura ritrovate. Tutto questo spostamento incongruo serve al solito e unico fine: arretrare il più possibile la X regione e fare avanzare il più possibile la IV regione onde potervi includere la base di tempio presso l’arco di Tito in cui da sempre la vulgata topografica ha identificato la aedes di Giove Statore, che solo dopo il grande incendio nella IV regione si trovava (come indicano i Cataloghi regionari), mentre in origine era in Palatio, come attestano i Fasti Privernati.
Gli edifici in summa Sacra via: troppi o giusti?
LOTTI E MONUMENTI RINVENUTI. La vulgata topografica ha usato il seguente argomento: troppi monumenti in troppo poco spazio e così per diradarli molti di essi – aedes Larum, domus Anci Marci, domus Tarquininiorum, domus Publica, porta Mugonia – sono stati da essa spostati sulla sella tra Velia e Palatino. Torneremo su questo argomento inconsistente. Si dà il caso che tutto il cuore di Roma sia attualmente perfettamente noto dal punto di vista dei resti materiali, grazie a una generazione di nostri scavi. Dopo aver trattato principalmente le fonti letterarie, con solo brevi accenni ai realia, è venuto il momento di riassumere seppure in breve i nostri ritrovamenti, che a loro volta ci hanno aiutato a meglio intendere le fonti letterarie ed epigrafiche (fig. 12).
Non è il caso di soffermarsi sul primo lotto, contenente l’aedes Vestae (le cui fasi più tarde hanno distrutto le prime) e la casa delle Vestali (nota invece fino da una prima capanna della metà dell’VIII secolo a.C.). Segue un lotto (2a), interno anch’esso al santuario, contenente prima focolari, per lo più dentro recinti o sacella, poi un silos/pozzo e probabilmente anche una piccola aedes e infine, dalla tarda Repubblica, una aedes vera e propria, per cui siamo certamente in presenza di un luogo di culto. Si ha poi un altro lotto (2b), interno anche questo al santuario, con una casa che dura, nelle sue numerosissime fasi, dalla metà dell’VIII secolo a.C. fino al 64 d.C. Deve trattarsi di una domus Regia, perché nessun cittadino se non un re poteva abitare nel santuario di Vesta. Si ha poi, immediatamente oltre il santuario, un lotto (4a-b) con una seconda casa durata dalla fine del VII secolo a.C. fino al 64 d.C.; dalla metà del VI secolo a.C., quando viene ristrutturata e ampliata, e poi nella tarda Repubblica, quando viene interamente riconcepita, questa casa è dotata di un passaggio stretto che porta al nemus/lucus Vestae, per cui deve trattarsi di una seconda domus Regia, affiancata alla prima, abitata da autorità aventi la patria potestas sulle Vestali, come re e pontefici massimi. Seguono, in due diverse ma prossime collocazioni, una serie di porte connesse a mura, che sembrano varianti di una unica entità monumentale. Oltre la porta con la sua strada, si ha infine un’area (lotto 6) con una serie di sacella/templa e di arae sovrapposti e infine con una piccola aedes, per cui sembra trattarsi di un’area e di un luogo di culto, durato dalla metà dell’VIII secolo a.C. al 64 d.C.; l’area sacra è stata occupata, almeno dalla tarda repubblica, da un edificio con grande passage antistante la aedes, evidentemente funzionale a quel culto. Dopo questa rapida descrizione, possiamo passare alla interpretazione dei monumenti succedutisi nei diversi lotti.
LOTTI E MONUMENTI INTERPRETATI. La aedes Vestae e la domus virginum vestalium con i culti di Aius Locutius e dei Lares Praesites erano ospitate nelle articolazioni di un unico lotto che si affacciava sul vicus Vestae e non sulla summa Sacra via. Subito a nord, oltre il vicus Vestae, era il lotto della regia/fanum ospitante i sacraria di Marte e Ops (ritenuta erroneamente dagli antiquari antichi il luogo della casa di Numa); era questo il primo lotto ad affacciarsi sulla summa Sacra via. Su questo stesso segmento di via si affacciavano, più a est, il lotto che accoglieva il sacellum e poi la aedes Larum, con il vicino fanum/sacellum di Orbona, che si trovava probabilmente nel lotto retrostante del nemus Vestae, dove un sacellum è stato rinvenuto. Seguivano il lotto ospitante la domus Regia dei re-auguri e poi dei re dei sacrifici e subito dopo il lotto della domus Tarquiniorum, Valeriorum, pontificum maximorum, con annessa porta Mugonia posta a cavallo del clivo Palatino A. Oltre il clivo veniva infine il lotto del templum/fanum, poi con aedes, di Giove Statore, con annesso edificio per una attività pubblica presidiata da quel culto, presso il quale era la riproposizione di un tratto del murus Romuli congiunto alla porta Mugonia (provengono forse da qui i quattro cippi di Remo); ma questo complesso monumentale già si trovava oltre la summa Sacra via, affacciandosi esso ormai sul clivus (Sacer) che portava alle Carinae.
***
Conclusioni
LOTTI/MONUMENTI E SPAZIO A DISPOSIZIONE. Come si è visto, i lotti che si affacciavano sulla summa Sacra via erano soltanto quattro, perfettamente congrui per questo segmento del tratto principale della Sacra via, lungo m 130, per cui esso disponeva, in media, m 32,5 di fronte-strada per ciascun lotto. La vulgata topografica, ponendo aedes Larum, domus Anci Marci, domus Tarquiniorum, domus Publica e porta Mugonia sulla sella tra Velia e Palatino, più che sfoltire un assembramento eccessivo, ha creato un vuoto incolmabile lungo la summa Sacra via. Infatti i m 130 del segmento sommo della via, tolti i m 32,5 attribuibili alla Regia/fanum/sacraria di Marte e Ops, lasciano vuoti m 97,5, pari a ben tre lotti che mancano. Forse che la nostra aedes Larum e le due domus Regiae tra loro confinanti, una nel santuario e l’altra al di fuori ma comunicante con esso tramite un passaggio, possono essere interpretate come dimore private qualsiasi?
REGALITÀ SOPRAVVISSUTA IN DUE CASE. È da notare che la più antica domus Regia è una casa che dura ininterrottamente per ottocentotrenta anni – caso unico nella storia dell’archeologia classica – e qualcosa di simile avviene per la domus Regia vicina e più recente, che dura per oltre seicento anni. Non è mai esistita dimora regia ufficiale dei primi re-auguri che non coincidesse con la domus Regia accolta entro il santuario di Vesta. Con i Tarquini viene istituito un nuovo sacerdote, il rex sacrorum, inteso come primo sacerdote della città-stato, che va ad abitare, conseguentemente, dove prima erano vissuti i re-auguri, e infatti la casa continua ad essere abitata, senza interruzioni, dalla metà dell’VIII secolo a.C. fino al 64 d.C. I Tarquini, che sono monarchi greco-etruschi di un nuovo genere, hanno scelto di vivere accanto ma fuori del santuario, anche se in collegamento diretto con esso tramite uno stretto passaggio; ciò, al fine di svincolarsi dalla sacralità regia originaria e di rafforzarsi come sovrani secolari dal carattere eminentemente politico-militare, secondo il modello greco dei coevi tyrannoi. A entrambe le domus Regiae vengono sottratti i sacraria di Marte e Ops, culti regi che vengono ora relegati in una succursale della domus Regia, una Regia/fanum: un luogo che mai ha ospitato la dimora di un re. Intanto nella nuova domus Regia è penetrato il culto innovativo di Fortuna. Insomma, le domus Regiae durano anche dopo la fine dei re-auguri e dei re tyrannoi, la prima per ospitare un re ridotto ad sacra e la seconda per ospitare i pontefici massimi, eredi dei re nell’esercitare la patria potestas sulle Vestali. La regalità muore, eppure continua in sacerdozi dalle caratteristiche regie. Il potere politico e militare dei consoli non avrà sede fissa, fino ad Augusto che nel suo palazzo sul Palatium cumulerà in sé tutti i poteri, compreso quello del pontificato massimo.
LA STORIA SI RIFLETTE NEL CUORE CITTADINO. È straordinario come le architetture e anche i minimi dettagli di questo cuore della città antica riflettano i mutamenti costituzionali di Roma: dall’ordinamento curiato a quello centuriato e soprattutto dai re-auguri, ai re dei sacrifici (privi di poteri politici) e ai re tyrannoi, potentissimi politicamente e militarmente proprio perché svincolati da troppi legami sacrali che rimandavano a un tempo trascorso. Che poi la domus dei Tarquini diventi la domus Publica del più alto sacerdote della città-stato, il pontefice massimo, torna con la trasformazione della villa dei Tarquini nel loro ager – futuro Campo Marzio – nella repubblicana villa Publica, come già si è visto. Anche il principato augusteo implicherà conseguenze rilevanti in questo centro cittadino: si pensi ai Lari di Augusto consegnati alle Vestali e alla aedes Larum dotata di due celle, una per i Lari pubblici e una per i Lari di Augusto (altare del Belvedere; CIL 6.30954, iscrizione trovata vicino all’aedes Larum); si pensi alla casa del re dei sacrifici donata alle Vestali e alla domus Publica distrutta, su cui viene eretto un horreum (fig. 16). Il delirio di potenza di Nerone seppellirà interamente questo intero cuore urbano (fig. 17). Si salveranno solamente l’aedes Vestae e l’atrium Vestae, interamente ricostruito e riorientato, contenente forse anche il culto dei Lari (edicola dei Lares praestites, aula absidata all’interno dell’atrium). Si potrebbe interpretare come un vago ricordo della porta Mugonia l’arcus in summa Sacra via con il suo nuovo clivo Palatino A. L’aedes Iovis Statoris viene invece spostata sulla Velia, nella regione IV, tra la summa Sacra via e la più vicina biblioteca del templum Pacis; in età tardo-antica il culto verrà probabilmente riambientato nel cosiddetto tempio di Romolo. La casa del re dei sacrifici, antica sede dei primi re, scompare invece del tutto e per sempre, come già era accaduto alla tradizionale domus Publica. Il potere si è spostato definitivamente sull’opposto versante del Palatino. Una nuova Roma geometrica e simmetrica come una città ellenistica, innervata dal grande clivo Sacro che puntava su Nerone assimilato a Sol, colosso che Nerone non arrivò a erigere anche se rientrava nel progetto megalomane della sua domus Aurea. Muore anche ciò che restava del clivo Palatino A, sostituito da ultimo e in tutto dal clivo Palatino B (figg. 17-18).
Il culto di Giove Statore, fulcro di un sistema
Sarebbe bello poter illustrare tutti i monumenti sopra menzionati. Non li abbiamo dimenticati a livello topografico, dato lo stretto sistema di relazioni che tra loro intrattengono. Siamo invece obbligati a dimenticarli dal punto di vista stratigrafico dato il poco spazio di cui qui disponiamo, per cui rimandiamo alle pubblicazioni dello scavo.11 Possiamo fare una eccezione solo per il culto di Giove Statore, connesso strettamente a una postierla del Palatino – identificata intorno al 530 a.C. con la porta Mugonia (Palatii) – e all’ultimo scontro mitistorico tra Romani e Sabini nel quale il sommo dio aveva salvato il Palatino dall’assalto di Tito Tazio.
SCOPERTA DI UNA AEDES, DI GIOVE STATORE? Restavano nella zona intorno alla porta Mugonia due spazi non scavati. Scavando nel primo abbiamo scoperto nel 2004 l’imbocco sulla Sacra via del clivo Palatino A, che ha rivoluzionato l’intera interpretazione di questo centro di Roma; scavando nel secondo spazio abbiamo scoperto nel 2012 – era già direttore dello scavo Paolo Carafa – un tempietto con antistante recinto per l’ara, edificato in opera quadrata con fondazioni in cementizio larghe m 2 e datato agli inizi del II secolo a.C.
L’idea che potesse trattarsi di una seconda fase dell’aedes di Giove Statore è venuta quando, all’interno del recinto, è stata individuata una obliterazione rituale di un altare e l’ara stessa in tufo, riusata nella prima fase dell’aedes, simile a quella soprastante la fossa di fondazione di Roma preservata sul versante opposto del Palatino. L’altare in tufo, anteriore all’edificio, faceva intendere che esistevano fasi precedenti del culto, a cominciare dal III secolo, all’inizio del quale l’aedes era stata votata e costruita, come sappiamo da Livio (fonte 8.9).
È stato allora che Carafa e io abbiamo notato che la piccola aedes si trovava davanti alla porta Mugonia, lungo il lato orientale del clivo Palatino A, tra la suddetta porta e la Sacra via, proprio di fronte allo sbocco della summa Nova via, quindi non più nella regione VIII, in cui sicuramente stava l’aedes Vestae, la domus vestalium e probabilmente l’intero santuario, compresa forse la domus Regia/Publica posta subito al di fuori di esso, ma nel Palatino e quindi nella regione X, dove appunto si trovava l’aedes Iovis Statoris (fonte 7.1).
SFIDE DA AFFRONTARE. Se il luogo e le circostanze topografiche erano perfetti per il culto di Giove Statore come è stato descritto dalle fonti, due erano le sfide. Prima sfida: 1a) se l’aedes era quella di Giove Statore, trattandosi di un culto romuleo i precedenti del culto avrebbero dovuto raggiungere, senza soluzione di continuità, non solo il III secolo a.C. ma addirittura la metà dell’VIII secolo a.C. ed essere in qualche modo in relazione con la salvaguardia del murus palatino; 1b) a ciò si aggiunga la non conservazione dell’aedes del 294, che era da spiegare (doveva trattarsi di una costruzione in opera quadrata senza fondazioni in cementizio, per qualche ragione smontata e ricostruita un secolo dopo ad un livello superiore, magari con gli stessi blocchi e nella stessa forma). Seconda sfida. 2a) Il tempio era piccolo e se ciò bene si accordava con le misure dei tempietti riferibili alle origini di Roma, come quello di Giove Feretrio sul Campidoglio, quello di Giano al Foro rivestito di bronzo e l’edicola, anch’essa bronzea, originariamente alle Camene, male si accordava al fatto che Cicerone vi aveva riunito il senato l’8 novembre del 63 a.C.; infatti nel suo piccolo spazio potevano entrare le ventisette vergini che nel 207 a.C. vi avevano provato un canto di Livio Andronico ma non il senato; 2b) inoltre l’aedes si accompagnava a un edificio gravitante su un passage, che in un primo tempo ci era parso di carattere meramente utilitario quale un horreum, per cui pareva incongruo rispetto alla aedes. Ma quando abbiamo inteso che la funzione esplicata nell’edificio era non pratica e mercantile bensì relativa a una pubblica amministrazione, per di più connessa al culto di un Giove che legittima la proprietà della città-stato e quando abbiamo compreso che l’area in quel tempo era non solo un fanum consacrato a Giove Statore ma anche un templum (Livio, fonte 8.9) coincidente oramai con il fanum, dal 530 circa di forma quadrangolare, l’incongruità è scomparsa e si è risolto anche il problema posto dalla riunione del senato, visto che non solo l’aedes ma anche l’antistante passage e il suo complesso edilizio insistevano su suolo inaugurato, almeno a partire dal III secolo a.C.
Sciolti i suddetti problemi, l’interpretazione topografica generale che abbiamo proposto risultava confermata anche nel suo principale caposaldo, il templum/fanum di Statore. Gli autori di questo libro, che pur conoscono i risultati finali dell’indagine, rivivono con il lettore la passione durante la ricerca: era possibile trovare, per la prima volta a Roma, tracce di un culto durato oltre otto secoli? Vene e polsi hanno tremato di fronte a questo “giallo” archeologico. Se quella immensa durata del culto non veniva confermata, saltava una fondamentale pedina interpretativa e con essa varie altre. Dovevamo forse tornare all’interpretazione della vulgata topografica? Tutto il lavoro da noi svolto nel corso di una generazione andava in fumo? Così palpitando siamo entrati nella scena, o meglio nella sala operatoria, dove dai muri in opera quadrata in tufo si andava ai muri in argilla cruda sostenuta da pali. Per vedere i primi basta una occhiata, mentre per individuare i secondi serve una abilità di scavo che l’archeologo classico normalmente non possiede. Ma noi per fortuna ci eravamo allenati a un tale cimento. Mattia Ippoliti racconta come ha fatto a individuare realtà che sono macchie nel terreno di colore leggermente diverso. La terra quando si secca è grigia e uniforme, come la noia. Ma poi, pulendola con la cazzuolina inglese o trowel, levando cioè lo sporco e il secco, emerge la multiforme varietà del suolo, lavorato incessantemente dall’uomo per abitarvi, e così diventa affascinante. Allora la superficie dello scavo somiglia a un quadro astratto, composto di vari colori, uno distinto dall’altro. Identificate queste diverse porzioni di terra grazie alla loro consistenza e colore, si è finalmente in grado di scavarle nell’ordine inverso in cui si sono sovrapposte, come avviene con i bastoncini nel gioco di Shangai. Il ritrovamento della sequenza del culto fino alla metà dell’VIII secolo, la fase delle mura romulee e, sotto un cumulo di terra pura, le capanne anteriori a Roma attribuibili al Septimontium, hanno confermato pienamente la nostra ipotesi e l’intera ricostruzione di questo cuore della città.
AMMAESTRAMENTO BASILARE. L’ammaestramento che si può trarre da questa esperienza è il seguente: mai si deve disquisire, manipolando fonti letterarie ed epigrafiche, circa un complesso archeologico la cui consistenza tipologica, stratigrafica e topografica, dalla tarda antichità al suolo vergine, è in gran parte ignota. Un simile errore è già stato compiuto riguardo al culto di Vesta, datato troppo tardi, ed è stato poi ripetuto per l’intero cuore di Roma, la cui origine è stata spostata al tempo dei Tarquini. Nessun chirurgo discetterebbe dell’anatomia di un abitante di Marte, di cui avesse solamente sentito dire da un esploratore spaziale. Sono le ossa, i muscoli e gli organi soprattutto a contare, almeno per il chirurgo. Il problema è che negli studi su Roma antica spesso si tratta di cose che assai male si conoscono, sia per approssimazione e sia perché ancora non scoperte, sperando che i bagliori che si colgono su di esse grazie alle testimonianze letterarie possano bastare. Nessuna polizia si basa più su descrizioni scritte di persone da individuare; serve per lo meno la fotografia e tra poco neppure quella basterà, per cui s’indagheranno pupille e impronte digitali. Homo sapiens e homo videns devono procedere congiunti e l’archeologo ha l’obbligo di saper leggere ma altrettanto di saper vedere e di saper scavare.
Questo libro insegna a saper vedere non un quadro, una scultura o un bronzetto ma porzioni di una città, che sono porzioni di secoli di avvenimenti, costruzioni e distruzioni. Sono quanto resta delle vite umane trascorse che vogliamo risuscitare, per vivere in modo pieno la nostra vita, che, al contrario degli animali, riesce a spaziare per tutti i tempi e i luoghi della propria specie. Mente e occhi sono di oggi, sapere e cose riguardano il passato, ma uniti insieme danno molte soddisfazioni, regalano anche momenti di felicità, perché spiegano luoghi e momenti ricchissimi di vita.
1. Carandini 2013; Carandini 2008a.
2. Coarelli 1983.
3. Carandini, Carafa 2000; Carandini, Papi 2005; Carandini, Carafa, Filippi 2016.
4. Carandini, Carafa 2012.
5. Ziolkowsky 2004.
6. Rosa 1862; 1866.
7. Tomei 1999.
8. Coarelli 1983.
9. Coarelli 2012.
10. Carandini, Carafa, Filippi 2016.
11. Carandini, Carafa, Filippi 2016.
TAVOLE – PRIMA PARTE
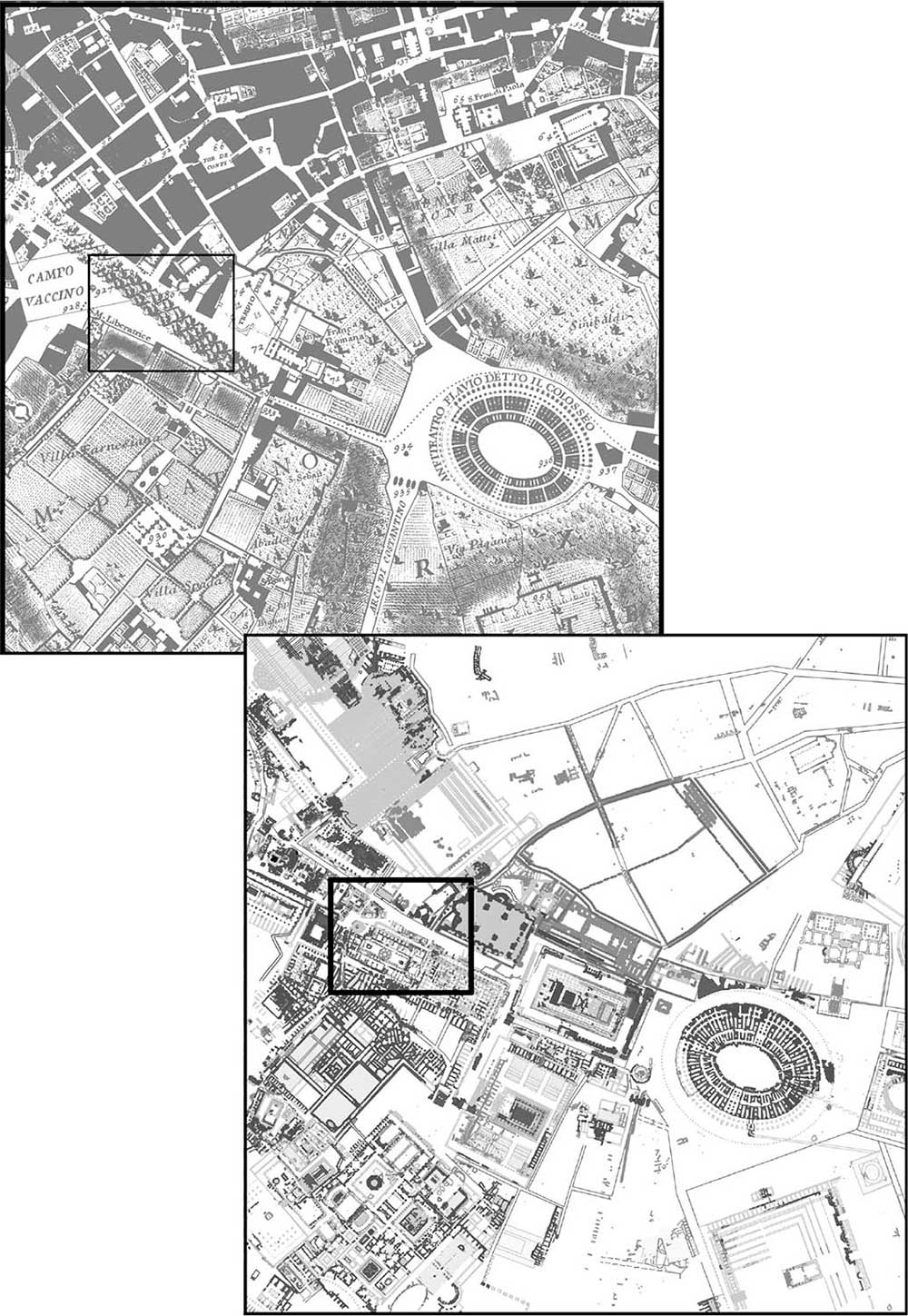
Fig. 1 – a) Il cuore di Roma nel 1748 (pianta di Giovanni Battista Nolli).
b) Il cuore di Roma nel IV-VI secolo d.C. (Atlante di Roma antica, tav. fuori testo 19).
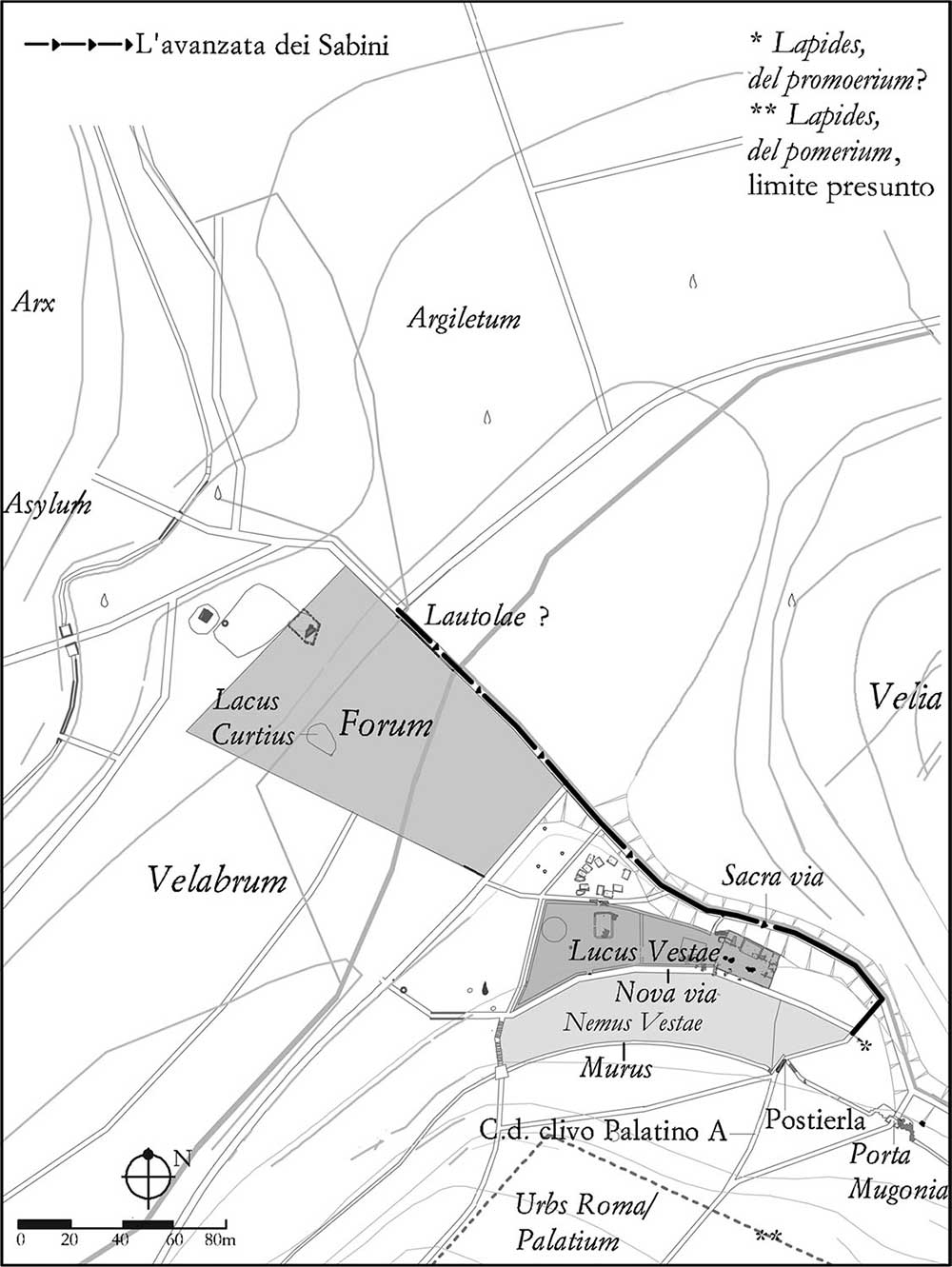
Fig. 2 – La guerra romano-sabina al tempo di Romolo e Tito Tazio. Il limite della bassura al quale i Sabini sono stati respinti corrisponde al bordo orientale del Foro.

Fig. 3 – Le mura del Palatino (VIII secolo a.C. e 530 a.C. circa).

Fig. 4 – Il Palatino diviso in quattro quarti.

Fig. 5 – Un libro di Ovidio (Tristia) va dal Foro di Cesare alla biblioteca della casa di Augusto tramite il clivo Palatino A (post 8 d.C.).
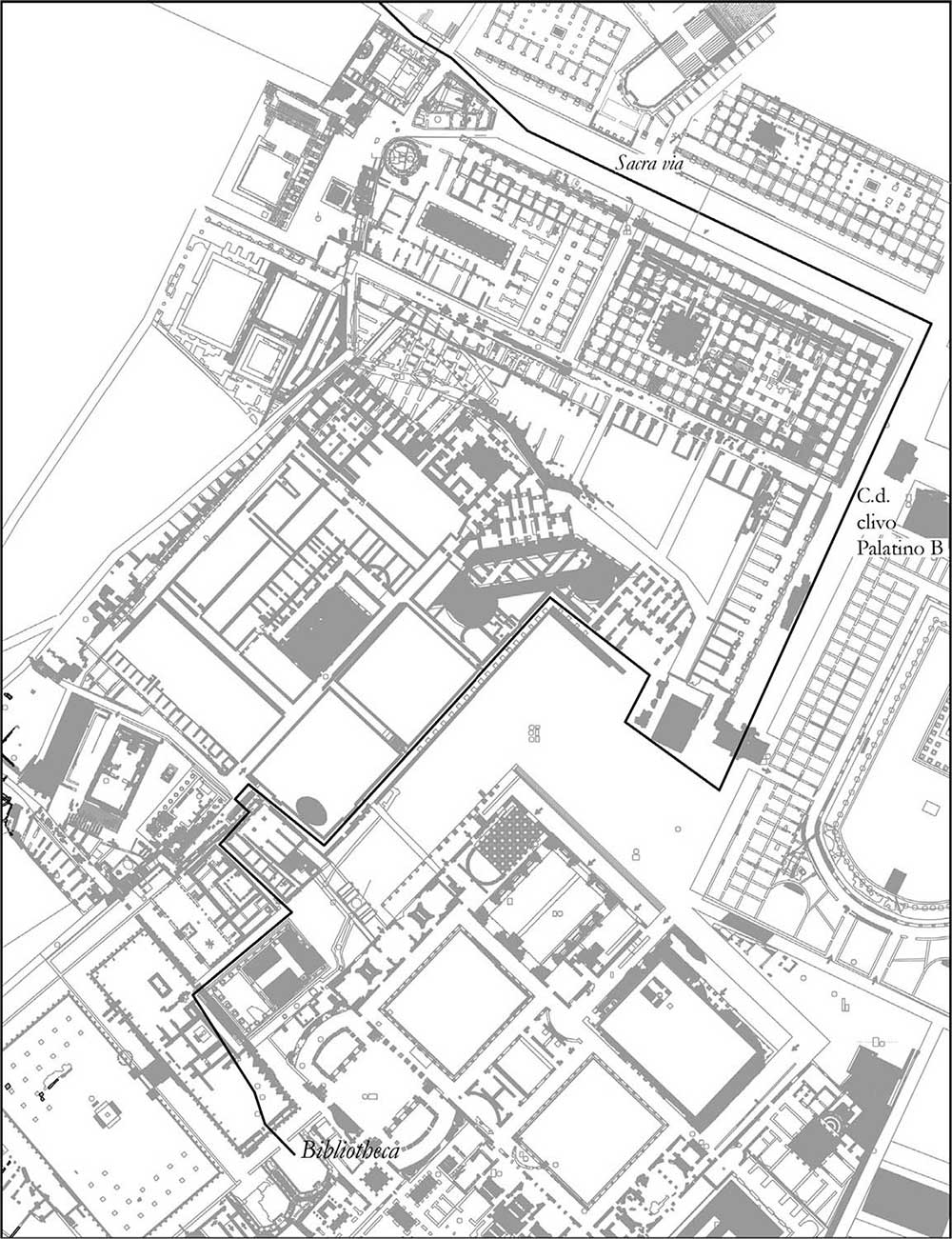
Fig. 6 – Un libro di Marziale (Epigrammi I) va dal Foro di Cesare alla biblioteca della casa di Augusto tramite il clivo Palatino B (86-96 d.C. circa).
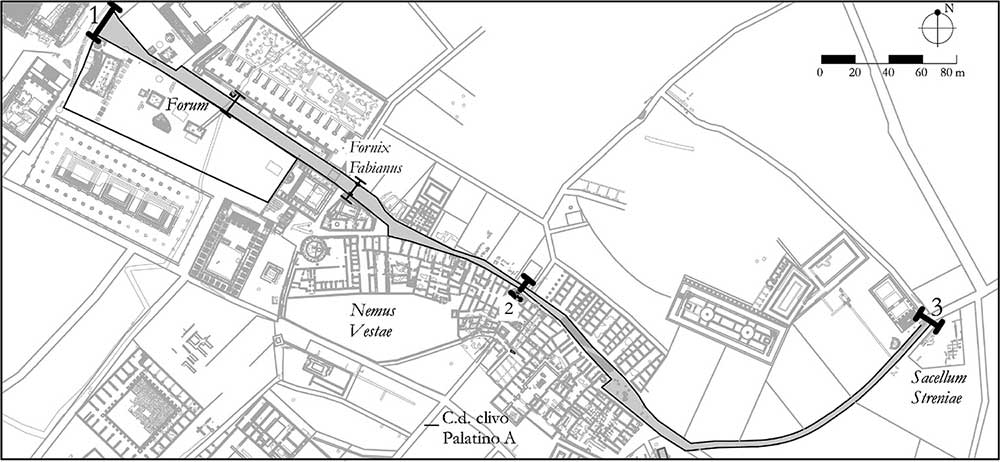
Fig. 7 – La Sacra via divisa in un primo (1-2) e in un secondo tratto (2-3). Il primo tratto diviso in tre segmenti: infima, media, summa Sacra via.
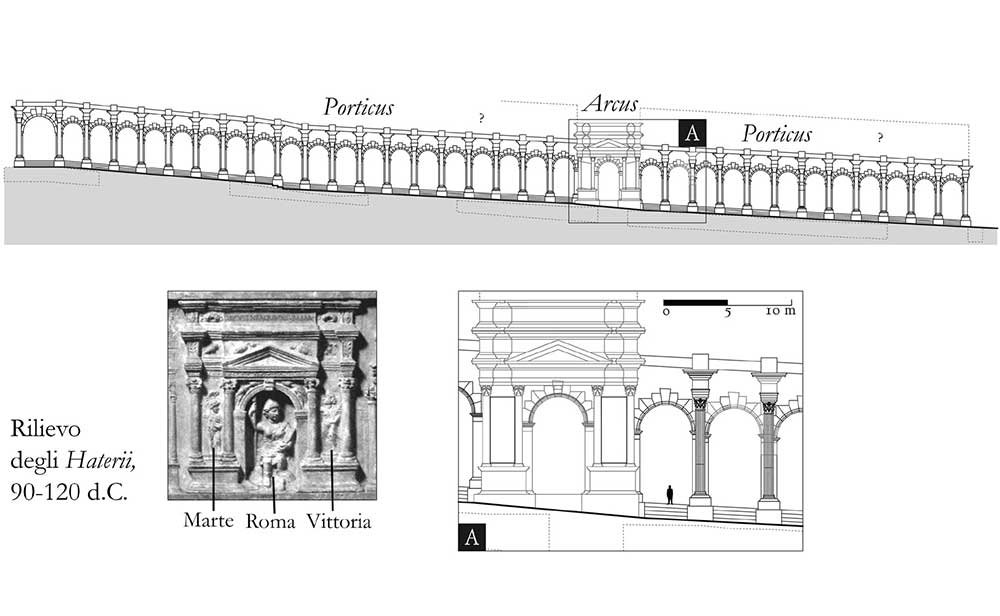
Fig. 8 – L’arcus in summa Sacra via (64-96 d.C.).
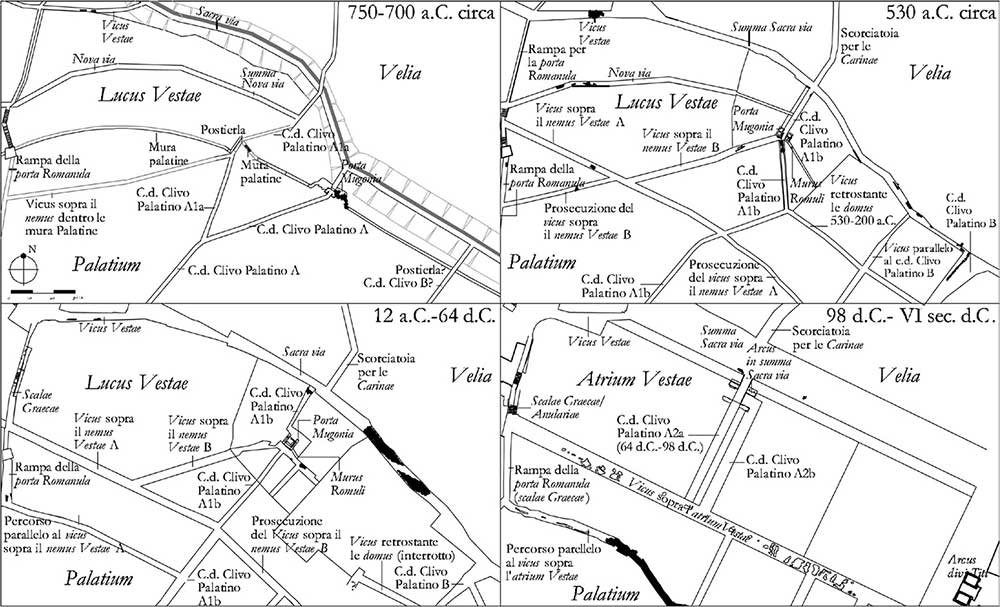
Fig. 9 – Il cuore di Roma, le strade in quattro periodi differenti.
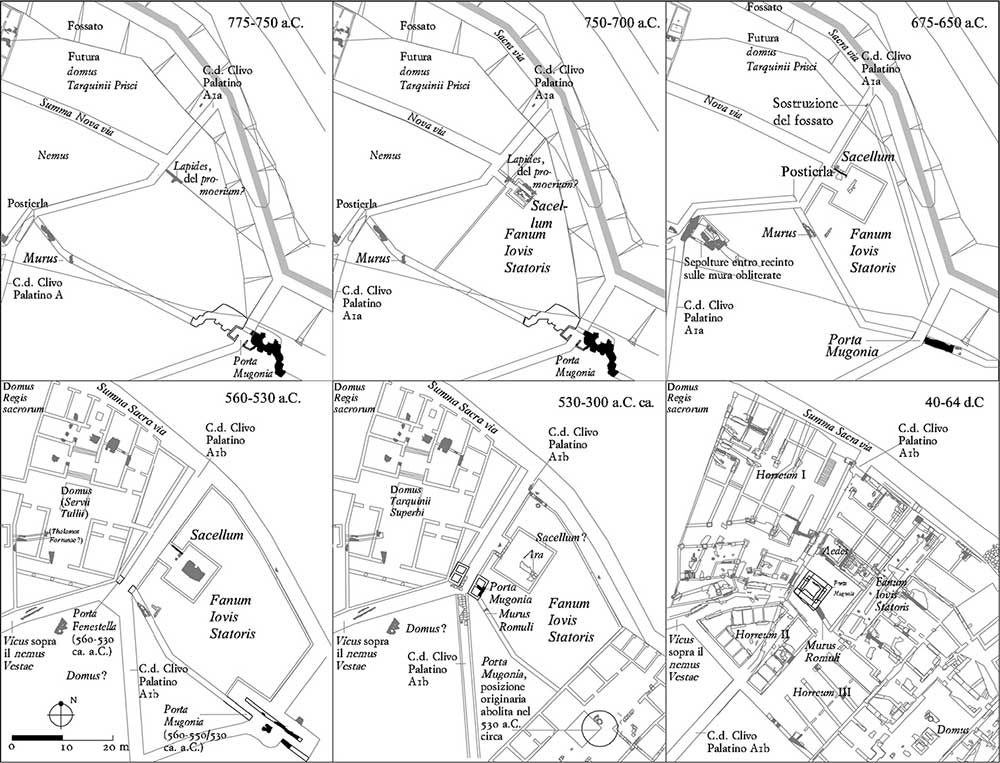
Fig. 10 – Le porte del Palatino rivolte alla Sacra via (postierla, porta Fenestella, porta Mugonia in due collocazioni).
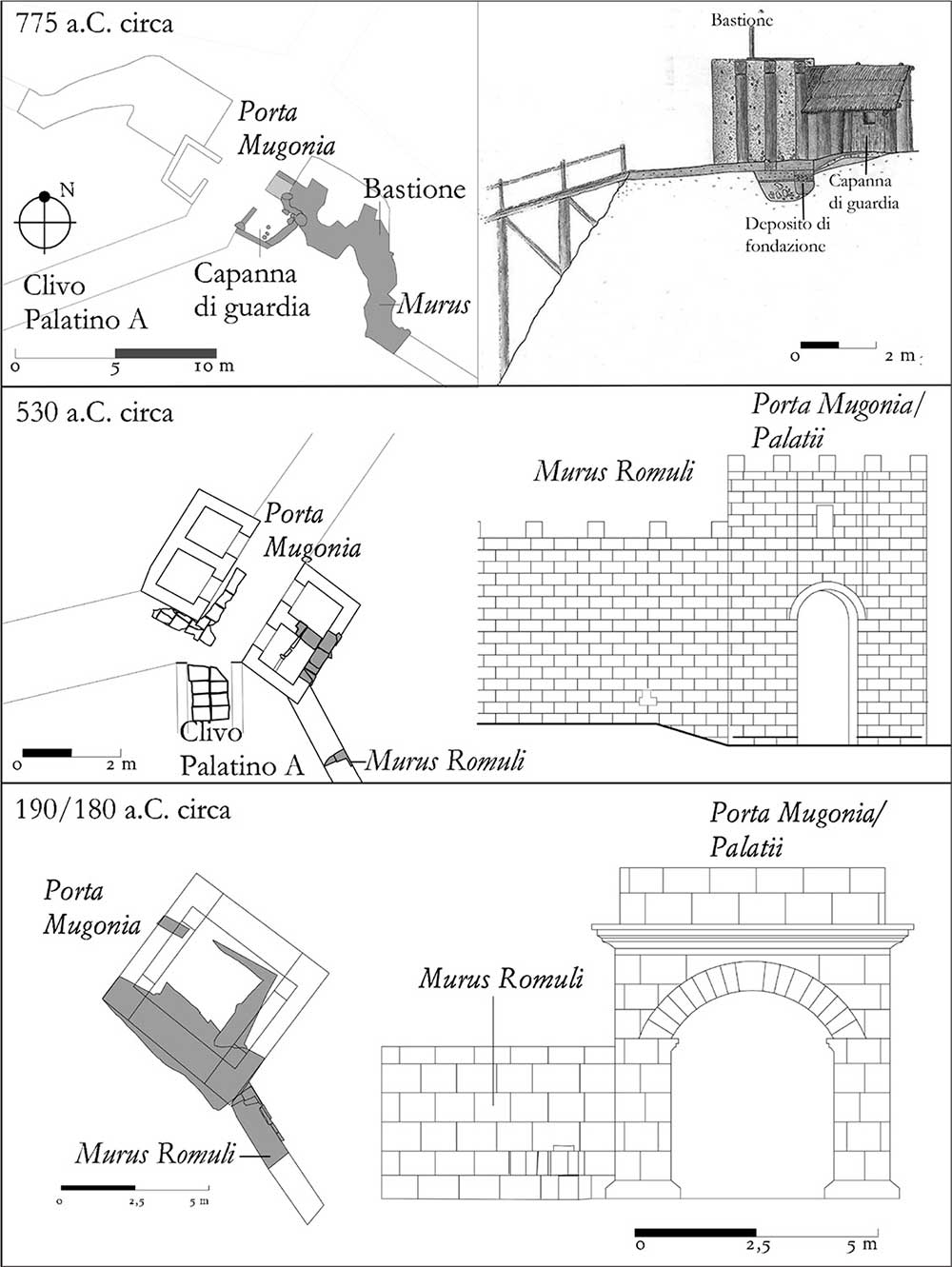
Fig. 11 – La porta Mugonia nei suoi tre periodi principali.
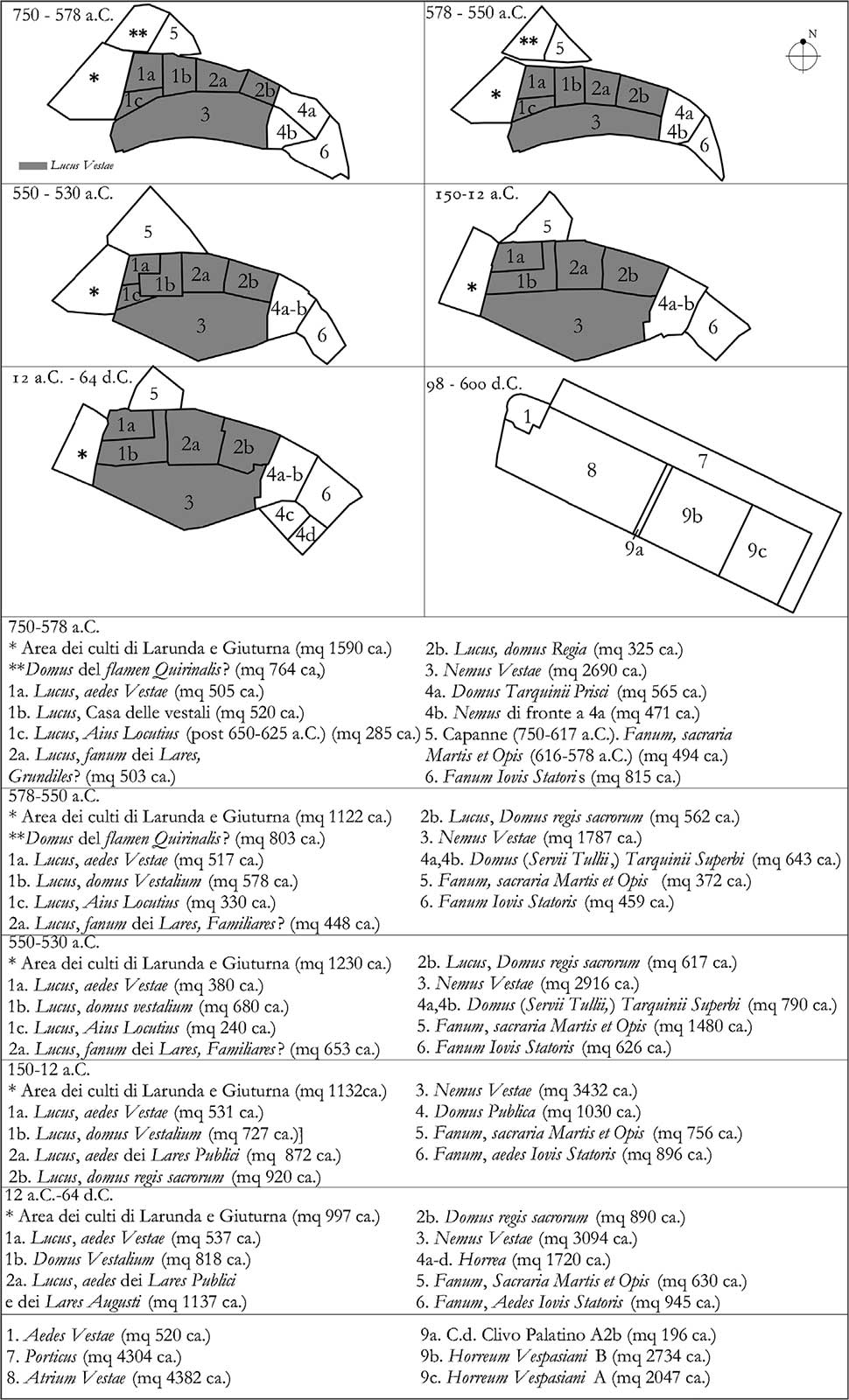
Fig. 12 – Il cuore di Roma e i suoi lotti articolati in sei periodi.

Fig. 13 – Il cuore di Roma, topografia, 750 a.C. circa (elaborazione da Filippi 2016).

Fig. 14 – Il cuore di Roma, topografia, 530 a.C. circa (elaborazione da Filippi 2016).
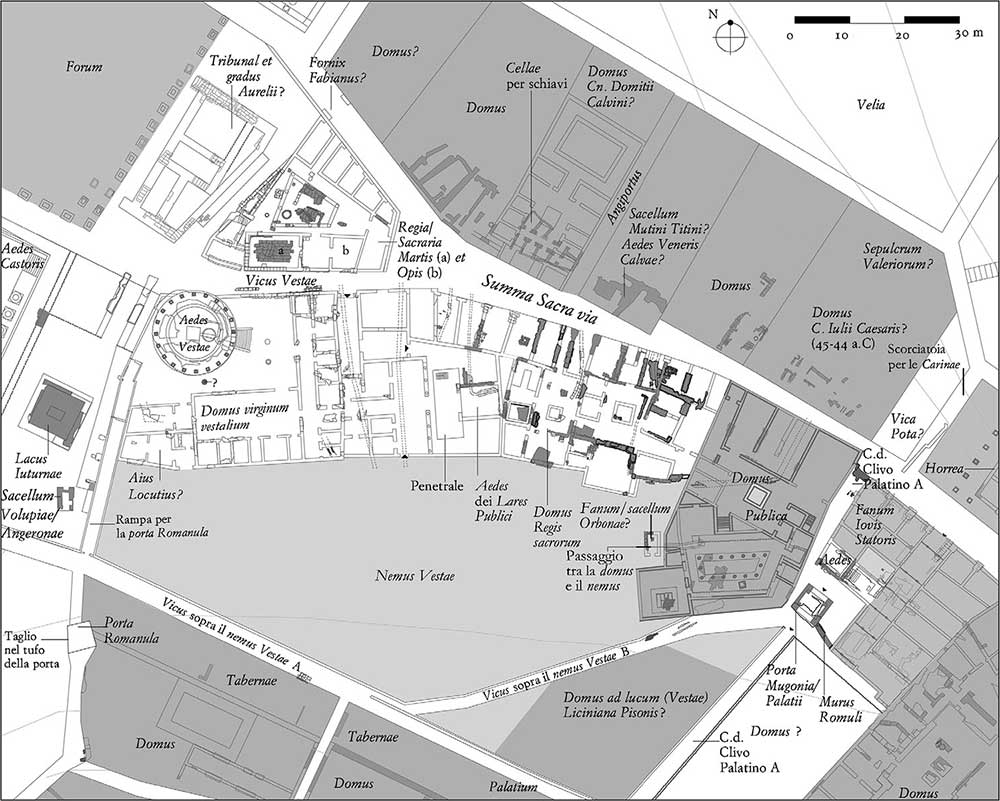
Fig. 15 – Il cuore di Roma, topografia, 44 a.C. (elaborazione da Filippi 2016).
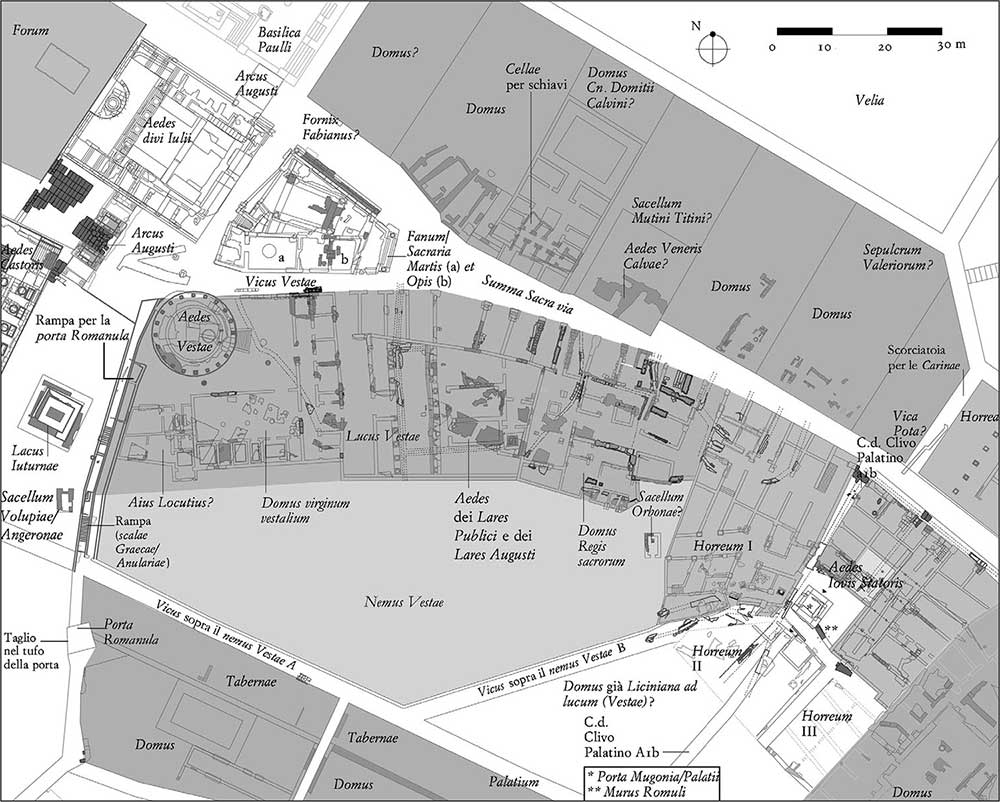
Fig. 16 – Il cuore di Roma, topografia, 14 d.C. circa (elaborazione da Fraioli 2012).
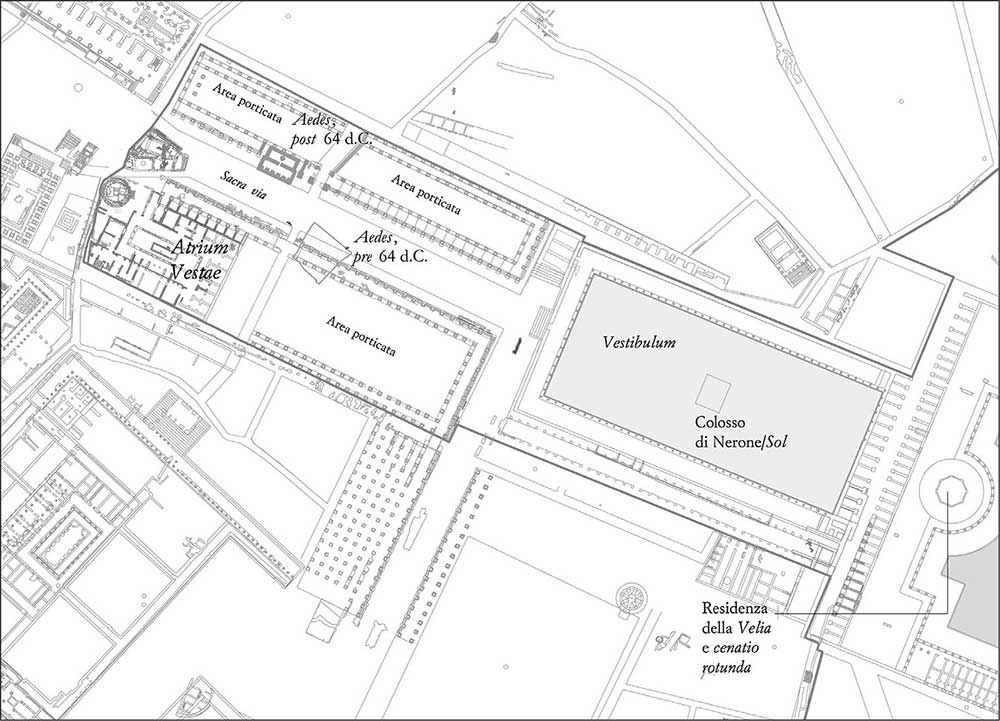
Fig. 17 – Il cuore di Roma, topografia, 64-68 d.C. (elaborazione da Filippi 2016).
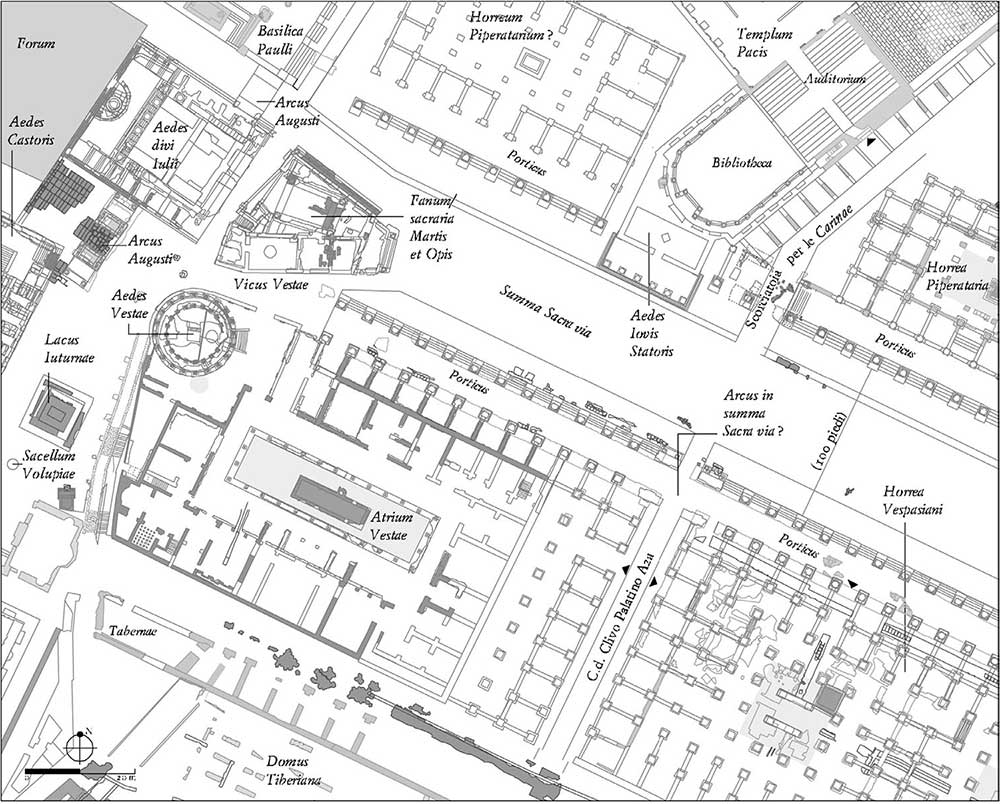
Fig. 18 – Il cuore di Roma, topografia, 80 d.C. circa (elaborazione da Filippi 2016).
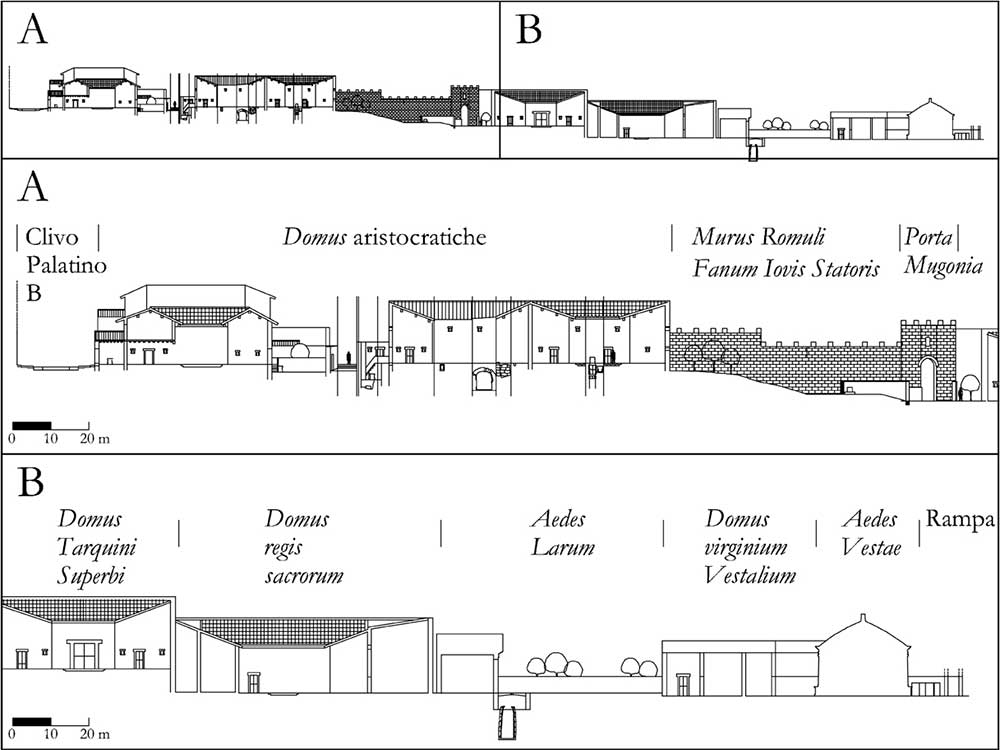
Fig. 19 – Il cuore di Roma, 530 a.C. circa. Sezione est-ovest.
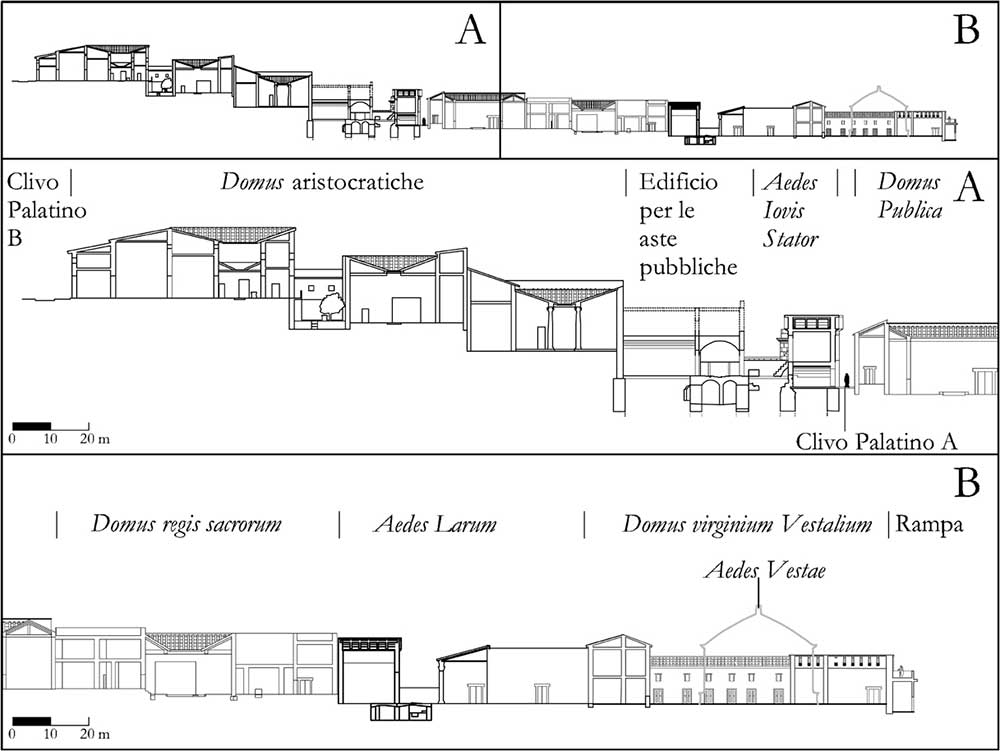
Fig. 20 – Il cuore di Roma, 44 a.C. circa. Sezione est-ovest.