Capitolo quinto
Tenere lo stato a distanza: il popolamento delle alture
La pagoda è terminata; il paese è in rovina.
Proverbio birmano.
Quando una comunità in crescita conquista nuovi territori ed espelle i loro vecchi occupanti (o alcuni di loro) invece di assimilarli nel proprio tessuto sociale, quelli che se ne vanno possono diventare, nel nuovo territorio in cui si diffondono, un nuovo tipo di società.
OWEN LATTIMORE, The Frontier in History.
La Commissione d’indagine sugli attentati dell’11 settembre 2001 alle Torri gemelle di New York in una relazione sul suo operato ha richiamato l’attenzione sulla nuova localizzazione della minaccia terroristica: non arriva piú da uno stato-nazione ostile ma da quelli che i membri della Commissione chiamano «santuari», nel senso di «luoghi di rifugio e protezione», situati in «vaste regioni non presidiate», «poco governate, fuori dal controllo della legge», «remote», e «con un territorio molto impervio»1. In particolare vengono citati due di questi luoghi, le regioni Tora Bora e Shah-i-Kot lungo il confine tra Pakistan e Afghanistan, e le isole a sud delle Filippine e dell’Indonesia «in cui è difficile mantenere l’ordine». La Commissione era consapevole che queste aree sono ostili all’esercizio del potere da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati a causa della lontananza geografica, del terreno proibitivo e, soprattutto, della relativa assenza di potere statale, ma non ha osservato che buona parte della popolazione si è stabilita lí perché storicamente erano zone rifugio dal potere dello stato.
Proprio come una regione remota e relativamente fuori dal controllo dello stato ha fornito un luogo di rifugio e protezione a Osama bin Laden e al suo seguito, cosí la vasta regione montuosa del Sud-est asiatico continentale che abbiamo chiamato Zomia ha fornito un luogo di rifugio storico per i popoli che fuggivano dallo stato. Se adottiamo una prospettiva di lungo periodo – e per «lungo» intendo millecinquecento o duemila anni – è molto sensato considerare i popoli delle alture di oggi come i discendenti di un lungo processo di marronage, come fuggitivi dai progetti di creazione dello stato nelle valli. Le loro pratiche agricole, l’organizzazione sociale, le strutture di governo, le leggende e in generale la loro organizzazione culturale portano tracce consistenti di pratiche di evasione e di presa di distanza dallo stato.
Questo modo di considerare le alture come zone popolate, fino a tempi molto recenti, da un processo migratorio di evasione dallo stato è in netto contrasto con una visione piú antica che fa ancora parte delle credenze popolari degli abitanti di valle. Questa visione considerava il popolo delle alture una popolazione aborigena che, per qualche ragione, non era riuscita a passare a un modo di vivere piú civilizzato: nello specifico, fare i coloni, coltivare riso irriguo, praticare la religione delle pianure e appartenere (come suddito o come cittadino) a una grande comunità politica. Nella versione piú rigida di questo modo di vedere, il popolo delle alture era una popolazione immutabilmente aliena che viveva in una sorta di pozzo culturale delle montagne e quindi inadatta a prospettive di avanzamento culturale. Nella visione piú caritatevole, ormai prevalente, tali popolazioni sono state «lasciate indietro» culturalmente e materialmente (forse sono anche i «nostri antenati viventi») e quindi devono essere oggetto di programmi di sviluppo che li integrino nella vita culturale ed economica della nazione.
Se invece si considera la popolazione di Zomia come un complesso di popolazioni che, in un momento o nell’altro, hanno scelto di trasferirsi fuori dall’immediata portata del potere statale, allora la sequenza implicita nella vecchia visione evoluzionistica diventa insostenibile. Vivere nelle alture diventa, invece, in gran parte un effetto dello stato, il tratto distintivo di una società creata da coloro che per qualunque motivo hanno lasciato l’ambito del potere diretto dello stato. Come vedremo, questa visione dei popoli delle alture come società «stato-repellenti» – o persino società antistatali – dà molto piú senso alle pratiche agricole, ai valori culturali e alla struttura sociale delle regioni montuose.
La logica complessiva del popolamento demografico delle alture è ragionevolmente accertata, nonostante le prove relative ai periodi piú antichi siano poco chiare e lacunose. Il sorgere di potenti stati risicoli superiori militarmente e demograficamente alle società piú piccole portò a un doppio processo di assorbimento e assimilazione, da una parte, e di espulsione e conflitto, dall’altra. Le società minori assorbite sparirono come società distinte, anche se prestarono il loro colore culturale all’amalgama che venne a rappresentare la cultura di valle. Le società che furono espulse o decisero di fuggire si spinsero in remoti luoghi di rifugio nei territori periferici, spesso ad altitudini elevate. Le zone di rifugio in cui riparavano non erano certo disabitate ma, nel lungo periodo, il peso demografico dei migranti in fuga dallo stato e dei loro discendenti ha finito col prevalere. Visto in una prospettiva storica di lungo raggio, il processo era caratterizzato da un andamento a singhiozzo. Nei periodi di pace dinastica ed espansione commerciale, o di espansione imperiale, la popolazione che viveva sotto l’egida dell’autorità dello stato aumentava. Si potrebbe dire che queste epoche siano caratterizzate dalla narrazione standard del «processo di civilizzazione», anche se questo non è stato benigno o volontario come implicano le versioni piú rosee. Ma in tempi di guerra, perdita del raccolto, carestia, tassazione schiacciante, contrazione economica o conquista militare, i vantaggi di un’esistenza sociale fuori dalla portata dello stato di valle erano molto piú allettanti. Il flusso delle popolazioni di valle in queste aree, spesso le alture, dove l’attrito del territorio forniva rifugio dallo stato, ha giocato un ruolo molto importante nel popolamento di Zomia e nella costruzione delle società «stato-repellenti». Migrazioni di questo genere hanno avuto luogo a scale piccole e grandi nel corso degli ultimi duemila anni e ogni nuova ondata migratoria incontrava quelli che erano arrivati prima e quelli che si erano stabiliti nelle regioni montuose già da tempo. La complessità etnica di Zomia in larga misura è dovuta al processo di conflitto, amalgama e riformulazione di identità in questo spazio poco governato. Tale processo è stato raccontato raramente perché non ha trovato posto nei testi di autorappresentazione degli stati di valle, ma è stato molto comune fino al XX secolo e, come vedremo, continua a scala minore ancora oggi.
Uno stato in particolare è stato piú degli altri la forza propulsiva che ha spostato moltitudini di persone e ne ha assorbite altrettante. A partire almeno dall’espansione della dinastia han verso sud fino al Fiume Azzurro (202 a.C. - 220 d.C.), quando lo stato cinese divenne per la prima volta un grande impero agrario, e continuando a singhiozzo fino alla dinastia Qing e ai suoi successori, la Repubblica e la Repubblica popolare cinese, le popolazioni che cercavano di sfuggire all’assimilazione si sono spostate a sud, a ovest e poi a sud-ovest all’interno di Zomia – nello Yunnan, nel Guizhou, nel Guangxi e nel vero e proprio Sud-est asiatico. Altri stati risicoli, sorti piú tardi, hanno imitato lo stesso processo a scala minore e a volte hanno rappresentato un ostacolo strategico all’espansione cinese; i piú importanti erano gli stati birmano, siamese, trinh e tibetano, ma erano sempre stati di serie B, mentre una grande quantità di stati risicoli ancora piú piccoli, che per un certo periodo hanno giocato un ruolo simile – Nanzhao, Pyu, Lamphun/Haripunjaya e Kengtung, per citarne solo alcuni – è caduta nell’oblio. Come macchine produttrici di forza lavoro, hanno catturato e assorbito popolazioni e, allo stesso modo, hanno espulso quelle che fuggivano dallo stato verso le alture e creavano la propria frontiera «barbara».
L’importanza delle alture come luogo in cui rifugiarsi dai molti oneri imposti sui sudditi dello stato non è passata inosservata. Come ha notato Jean Michaud: «In una certa misura i montanari si possono considerare rifugiati di guerra che hanno scelto di rimanere fuori dal diretto controllo delle autorità statali, autorità che cercavano di controllare il lavoro e le risorse tassabili e di assicurarsi l’accesso a popolazioni da cui potevano reclutare soldati, servi, concubine e schiavi. Questo significa che i montanari sono sempre stati in fuga»2. Se esaminata alla luce delle prove storiche, agro-ecologiche ed etnografiche, l’osservazione di Michaud diventa una potente griglia di lettura attraverso cui Zomia appare come una vasta periferia di resistenza allo stato. Lo scopo di questo e dei successivi due capitoli è delineare un ragionamento che sostenga questa interpretazione.
Altre regioni di rifugio.
La prospettiva che proponiamo per comprendere Zomia non è nuova. Una logica simile è stata osservata in molte regioni del mondo, piccole e grandi, dove regni in espansione hanno costretto popolazioni minacciate a scegliere tra assimilazione e resistenza. Dove la popolazione minacciata è organizzata in forme statali, la resistenza può diventare un confronto militare in seguito al quale gli sconfitti vengono assorbiti o costretti a migrare altrove. Nel caso la popolazione sotto minaccia sia senza stato, le sue scelte in genere si riducono all’assimilazione e alla fuga, quest’ultima spesso accompagnata da schermaglie di retroguardia e incursioni3.
Un ragionamento di questo tipo è stato condotto circa trent’anni fa da Gonzalo Aguirre Beltrán a proposito dell’America Latina. Nel suo libro dal titolo Regiones de Refugio sostiene che in regioni remote e inaccessibili, lontano dai centri di controllo spagnolo, fosse rimasta una sorta di società pre-conquista. La collocazione di queste zone era determinata da due fattori: primo, erano territori di scarso interesse economico per i colonizzatori spagnoli; secondo, erano aree geograficamente proibitive in cui l’attrito della distanza era particolarmente forte. Aguirre Beltrán parla di zone di «campagne aspre, isolate dalle vie di comunicazione da barriere fisiche, con un paesaggio duro e rese agricole molto scarse». Tre ambienti che corrispondono a queste caratteristiche sono i deserti, le giungle tropicali e le montagne, tutti «ostili o inaccessibili al movimento umano»4. Secondo Aguirre Beltrán, la popolazione indigena era in gran parte costituita da superstiti, perché fuggiti o costretti a insediarsi in queste zone, ma soprattutto ignorati dagli spagnoli, per i quali il territorio non aveva un interesse economico e non rappresentava una minaccia militare.
Aguirre Beltrán tiene conto del fatto che, a causa dell’appropriazione delle terre da parte degli spagnoli, una parte della popolazione indigena sia stata costretta ad abbandonare i campi e ritirarsi nella sicurezza rappresentata dalle regioni meno desiderate dai colonos ladinos5, ma le ricerche successive hanno allargato enormemente il ruolo giocato dalla fuga e dalla ritirata. In una prospettiva di lungo periodo, sembrerebbe che alcuni, se non la maggior parte dei popoli «indigeni» di cui parla Aguirre Beltrán, in realtà una volta fossero coltivatori sedentari che vivevano in società fortemente stratificate, e che furono costretti dalla pressione degli spagnoli e dal massiccio crollo demografico causato dalle epidemie a riformulare le loro società in modo da accentuarne le caratteristiche di adattamento e mobilità. Perciò Stuart Schwartz e Frank Salomon scrivono di «variazioni verso il basso della dimensione del modulo del gruppo, [minore] rigidità delle organizzazioni di parentela e [minore] centralizzazione socio-politica», il che ha trasformato gli abitanti di sistemi complessi collocati lungo sponde fluviali in «popoli di villaggio riconosciuti separatamente». Quindi, una popolazione che piú tardi potrebbe essere considerata tribale e arretrata, persino neolitica, deve essere invece vista come l’adattamento storico a una minaccia politica e a un contesto demografico radicalmente nuovo6.
L’interpretazione contemporanea, come documentata da Schwartz e Salomon, parla di massicci spostamenti di popolazione e rimpasto etnico. In Brasile, i nativi che fuggivano dalle reducciones coloniali e dal lavoro forzato delle missioni – «superstiti di villaggi sconfitti, meticci, disertori» – spesso si raggruppavano alla frontiera, a volte venivano identificati con il nome del popolo nativo tra cui si erano insediati e a volte assumevano una nuova identità7. Come gli stati risicoli asiatici, anche i progetti di dominio spagnoli e portoghesi avevano bisogno di controllare la forza lavoro disponibile nello spazio statale. Il risultato finale della fuga provocata dall’insediamento forzato è stata la creazione di una distinzione tra zone statali, da una parte, e popolazioni che resistevano allo stato, geograficamente remote e spesso ad altitudini elevate, dall’altra. A parte il massiccio crollo demografico, specifico del Nuovo Mondo, la somiglianza con lo schema del Sud-est asiatico è notevole. Schwartz e Salomon, a proposito della reducciòn del 1570, affermano che gli spagnoli
per fronteggiare il declino della popolazione e la necessità di forza lavoro delle colonie, insediarono forzatamente le popolazioni in nuclei parrocchiali, il che provocò lo spostamento di migliaia di indiani e la loro redistribuzione nei territori prima dominati dagli Inca. Il progetto di concentrare insediamenti agro-pastorali sparsi in cittadine tutte uguali di tipo europeo venne attuato solo raramente, ma le sue conseguenze furono estese, se non uniformi, e comprendono la duratura antitesi tra i territori montuosi esterni dei nativi e i centri parrocchiali «civilizzati». […] Il declino della popolazione, l’inasprimento dei tributi e il regime delle quote di lavoro forzato spinsero migliaia di persone a lasciare la propria terra e rimescolarono intere popolazioni8.
Almeno nelle Ande, il forte contrasto tra centri civilizzati e «territori esterni dei nativi» sembra aver avuto un parallelo prima della Conquista nella distinzione tra corti inca e popolazione che resisteva allo stato nei territori periferici. Ma la relazione con l’altitudine era rovesciata: i centri degli Inca erano in alto e la periferia in basso, nelle umide foreste equatoriali i cui abitanti avevano resistito a lungo al potere degli Inca. Questo rovesciamento è un importante richiamo al fatto che la chiave della costruzione premoderna dello stato è la concentrazione di terre coltivabili e forza lavoro, non l’altitudine di per sé: nel Sud-est asiatico, le distese di terra coltivabile a riso irriguo piú vaste sono in basso; mentre in Perú buona parte della terra coltivabile si trova sopra i duemilasettecento metri di altezza, dove prosperano le colture di mais e patate, gli alimenti principali del Nuovo Mondo9. Nonostante il rovesciamento del rapporto con l’altitudine, sia lo stato inca sia quello spagnolo hanno creato una periferia «barbara» di resistenza allo stato. Nel caso spagnolo, l’aspetto piú notevole e istruttivo è che buona parte della periferia barbara era composta da transfughi da società piú complesse e organizzate che si allontanavano dai pericoli e dalle oppressioni dello spazio statale. Farlo spesso significava abbandonare le coltivazioni permanenti, semplificare la propria struttura sociale e dividersi in bande piú piccole e mobili. Ironicamente, sono anche riusciti a prendere in giro in modo ammirevole la precedente generazione di etnografi che ha creduto che i popoli sparsi sul territorio come gli yanomamo, i sirionó e i i tupo-guarani fossero quello che restava delle originarie popolazioni primitive.
Le popolazioni che per un certo periodo sono riuscite a sfuggire dal controllo europeo hanno finito per rappresentare zone di insubordinazione. Queste shatter zones, specialmente se con abbondanti risorse di sussistenza, erano come calamite che attraevano individui, piccoli gruppi e intere comunità che cercano un luogo di rifugio e protezione fuori dalla portata del potere coloniale. Schwartz e Salomon dimostrano che divennero una calamita di questo genere i jívaro e i vicini záparo, che avevano combattuto gli europei e controllavano diversi tributari dell’alta Amazzonia10. La conseguenza inevitabile dell’afflusso demografico diede origine alle caratteristiche della maggior parte delle zone di rifugio: un mosaico di identità, etnie e amalgama culturali incredibilmente complessi.
In Nordamerica alla fine del XVII secolo e per gran parte del XVIII, quando Britannia e Francia lottavano per la supremazia sui loro alleati nativi americani, soprattutto gli irochesi e gli algonchini, la regione dei Grandi Laghi divenne una zona di rifugio e di afflusso. La zona brulicava di fuggiaschi e rifugiati da molte aree e origini diverse. Richard White chiama questa zona «un mondo fatto di frammenti»: villaggi con le provenienze piú svariate che vivevano fianco a fianco e altri insediamenti di popolazioni miste messe insieme dalle circostanze11. In questa situazione, l’autorità era debole anche al livello del singolo piccolo villaggio e ogni insediamento era in sé radicalmente instabile.
Il guazzabuglio delle etnie nelle zone di rifugio del Nuovo Mondo è ulteriormente complicato dai fuggitivi provenienti da una nuova popolazione importata proprio per compensare il fatto di non riuscire a tenere sul posto la popolazione nativa: gli schiavi africani. Anch’essi, ovviamente una popolazione poliglotta, come schiavi in fuga si ritrovarono in zone di rifugio già occupate dai popoli nativi. In luoghi come la Florida, il Brasile e la Colombia e in molte zone dei Caraibi, l’incontro diede origine a popolazioni ibride molto complesse. Ma la promessa di una vita lontano dallo stato non attirava solo gli schiavi e i popoli nativi: ad aumentare l’incredibile complessità di questi spazi arrivarono anche avventurieri, commercianti, fuorilegge e reietti – i personaggi tipici di molte frontiere.
Qui possiamo distinguere un approssimativo andamento storico: l’espansione dello stato, quando implica forme di lavoro coatto, favorisce (condizioni geografiche permettendo) zone extra-statali di fuga e rifugio; gli abitanti di tali zone spesso sono una composizione di fuggitivi e popoli che erano già stabiliti lí. L’espansione coloniale europea sicuramente fornisce le migliori prove documentali di questo schema, che però è ugualmente applicabile alla stessa prima Europa moderna: un esempio su cui torneremo piú tardi è la frontiera cosacca creata da chi fuggiva dalla servitú della gleba della Russia dal XV secolo in avanti.
Ma c’è un secondo esempio particolarmente istruttivo: il «corridoio fuorilegge» della fine del XVII secolo tra gli stati agrari di Prussia e Brandeburgo e le potenze marittime di Venezia, Genova e Marsiglia12. La rivalità tra gli stati agrari per l’arruolamento forzato provocava costanti rastrellamenti per catturare «vagabondi» – in pratica chiunque non aveva fissa dimora – per soddisfare le draconiane quote di reclutamento. Gli zingari, gli itineranti poveri piú stigmatizzati e perseguitati, vennero criminalizzati e fatti oggetto della famosa caccia agli zingari. A sud-ovest c’era una rivalità altrettanto feroce tra gli stati marittimi per accaparrarsi schiavi per le galee, anch’essi arruolati forzatamente tra i vagabondi. In entrambe le zone la schiavitú nell’esercito o sulle galee era un’alternativa riconosciuta alla pena di morte, e le razzie per catturare i vagabondi erano strettamente collegate alla richiesta di forza lavoro militare.
Tra queste due zone di servitú forzata, però, esisteva una fascia di relativa immunità in cui fuggivano molti migranti poveri, in particolare gli zingari. Questa terra di nessuno, questa stretta zona di rifugio, divenne nota come «corridoio fuorilegge»: semplicemente una concentrazione di migranti «tra il Palatinato e la Sassonia, troppo lontana sia dalla zona di reclutamento di Brandeburgo-Prussia che dalla zona del Mediterraneo (in quest’ultimo caso, il valore degli schiavi non copriva i costi di trasporto)»13. Come nel caso delle zone di rifugio di Aguirre Beltrán e in generale delle comunità degli schiavi fuggitivi, il corridoio fuorilegge era un effetto dello stato e, nello stesso tempo, uno spazio sociale di resistenza allo stato modellato in base a una risposta deliberata di rifiuto della subordinazione14.
Prima di tornare alla vera e propria Zomia, meritano un breve accenno due esempi di rifugi «sulle alture» dal controllo statale nel Sud-est asiatico. Il primo – il caso dell’altopiano di Tengger nella parte orientale di Giava – è un esempio in cui, tra i motivi della migrazione, sembra avere una particolare importanza la sopravvivenza culturale e religiosa15. Il secondo è quasi un caso limite: la parte settentrionale dell’isola di Luzon, in cui la zona di rifugio dove hanno riparato i fuggiaschi era praticamente disabitata.
I monti di Tengger si distinguono per essere la principale roccaforte del culto indú-scivaista a Giava, l’unico culto esplicitamente non islamico sfuggito all’ondata di islamizzazione che seguí il crollo dell’ultimo importante regno indú-buddista (Majapahit) all’inizio del XVI secolo. Secondo i resoconti locali, parte della popolazione sconfitta fuggí a Bali, mentre una frazione cercò rifugio nelle montagne. Come osserva Robert Hefner, «è curioso che l’attuale popolazione dei monti Tengger abbia mantenuto un forte attaccamento al culto indú ma abbia completamente abbandonato caratteristiche dell’induismo come le caste, le corti e l’aristocrazia»16. La popolazione delle montagne era periodicamente alimentata da nuove ondate di migranti che fuggivano dagli stati di pianura. Il regno di Mataram, sorto nel XVII secolo, mandò ripetute spedizioni nei Tengger per catturare schiavi, spingendo chi era scampato alla cattura ancora piú in alto, dove era relativamente piú al sicuro. Negli anni Settanta del 1600 un principe madurese si rivoltò contro Mataram, ormai sotto la protezione olandese; quando la rivolta fu repressa, i ribelli allo sbando fuggirono ai loro inseguitori olandesi sulle montagne. Piú tardi, l’ex schiavo Surapati, un altro ribelle e fondatore di Pasuruan, fu a sua volta sconfitto dagli olandesi, ma i suoi discendenti continuarono a resistere per anni nelle loro roccaforti. Il caso dei monti Tengger, un prodotto di quella che Hefner chiama 250 anni di violenza politica, è una straordinaria concentrazione di fuggitivi – da schiavitú, sconfitte, tasse, assimilazione culturale e coltivazione forzata sotto gli olandesi.
Alla fine del XVIII secolo, buona parte della popolazione si era spostata alle altitudini piú elevate, meno accessibili e piú difendibili, anche se economicamente piú precarie. La storia della fuga è ricordata ogni anno dagli abitanti dei Tengger non musulmani che gettano offerte nel vulcano in ricordo di quando scapparono dall’esercito islamico. La loro tradizione distintiva, nonostante il suo contenuto indú, è culturalmente codificata in una forte tradizione di autonomia del nucleo famigliare, autosufficienza e spinta antigerarchica. Il contrasto con i modelli di pianura colpí moltissimo un funzionario forestale alla sua prima visita: «Non si distinguono i ricchi dai poveri. Tutti parlano nello stesso modo con chiunque nonostante la loro posizione. I bambini parlano con i genitori e persino con il capo del villaggio usando il normale ngoko. Nessuno si inchina di fronte a qualcuno»17. Come osserva Hefner, l’obiettivo prioritario degli abitanti dei Tengger è evitare di «ricevere ordini»; un’aspirazione deliberatamente in contrasto con le elaborate gerarchie e i codici sociali delle pianure giavanesi. Sia la demografia sia l’etica dei monti Tengger, allora, si possono definire un effetto dello stato – un luogo geografico popolato per mezzo millennio da rifugiati in fuga dallo stato, provenienti dalle pianure, con valori egalitari e riti indú consapevolmente in contrasto con quelli degli abitanti delle pianure, islamici e osservanti dei ranghi18.
Un secondo caso storico del Sud-est asiatico insulare che strutturalmente assomiglia al caso che spero di dimostrare per Zomia in generale è quello della zona montuosa a nord di Luzon. Insieme ai monti Tengger, Luzon del Nord si può interpretare come una Zomia a piccola scala, popolata soprattutto da persone che sono fuggite dalla subordinazione della pianura.
Nell’accurata documentazione di Ethnohistory of Northern Luzon, Felix Keesing si è dato il compito di rendere conto delle differenze etniche e sociali tra i popoli di montagna e quelli di pianura. Respinge i resoconti che hanno come premessa una differenza essenziale e primordiale tra le due popolazioni – premessa che porterebbe alla necessità di storie di migrazione separate per spiegare la loro presenza a Luzon – per sostenere, invece, che le differenze si possono far risalire al lungo periodo spagnolo e alle «dinamiche ecologiche e culturali che hanno operato tra una popolazione originariamente comune»19. Ancora una volta l’immagine complessiva è una fuga avvenuta piú di cinquecento anni fa.
Una parte della popolazione dell’isola si stava spostando all’interno anche prima dell’arrivo degli spagnoli nel XVI secolo, per sfuggire ai mercanti di schiavi musulmani che razziavano le coste. Chi rimaneva vicino alla costa spesso costruiva torri di avvistamento per poter dare l’allarme in caso di incursioni schiaviste. Ma le ragioni per sfuggire alla schiavitú aumentarono notevolmente con la presenza spagnola. Come per lo stato risicolo, la chiave per la costruzione dello stato era l’imperativo di concentrare popolazione e produzione agricola in uno spazio limitato20. Le proprietà dei missionari, come le reducciones dell’America Latina, erano sistemi basati sul lavoro forzato con una patina di «civilizzazione cristiana» a mo’ di giustificazione ideologica. Era da queste «serre a crescita forzata» del potere di pianura che le persone fuggivano nei territori periferici e sulle alture, che, secondo Keesing, fino ad allora erano quasi spopolate. Le prove documentali, afferma, «dimostrano come i gruppi accessibili dovessero scegliere tra la sottomissione al controllo straniero e la ritirata nei territori interni. In seguito alle periodiche rivolte contro il dominio spagnolo, qualcuno fuggiva all’interno e altri successivamente si ritiravano sulle montagne. […] In tutti e nove gli studi di area, la fuga nelle montagne sotto il dominio spagnolo è un tema fondamentale dell’epoca storica»21.
La maggior parte dei montanari una volta era gente di pianura la cui fuga alle altitudini piú elevate diede inizio a un complicato processo di differenziazione22. Nei loro nuovi sistemi ecologici i vari gruppi di rifugiati adottarono nuove routine di sussistenza. Per gli ifugao questo significò elaborare un sofisticato sistema di terrazzamenti ad altitudini elevate, che permise loro di continuare a coltivare riso irriguo. Per gran parte degli altri gruppi significò passare dall’agricoltura stanziale a quella itinerante e/o alla raccolta. Quando, molto piú tardi, entrarono in contatto con gli stranieri, questi gruppi vennero ritenuti popoli fondamentalmente diversi che non si erano evoluti oltre tecniche di sussistenza «primitive». Ma, come avverte Keesing, non ha senso assumere semplicemente che popoli che oggi sono raccoglitori facessero necessariamente la stessa cosa cento anni fa: potrebbero essere stati altrettanto facilmente coltivatori. I tempi diversi delle molte ondate migratorie, la loro localizzazione secondo l’altitudine e le tecniche di sussistenza spiegano la rigogliosa diversità del paesaggio etnico delle regioni montuose rispetto a quello delle valli. Keesing suggerisce un modello schematico del modo in cui questa differenziazione etnica può aver avuto luogo: «L’immagine teorica piú semplice […] è quella di un gruppo originario, di cui una parte resta nelle pianure e una parte si sposta sulle montagne. Ognuna delle due parti subisce conseguenti riformulazioni etniche, per cui diventano diverse. Il contatto continuo, ad esempio tramite il commercio o anche la guerra, le influenzerà reciprocamente. Il gruppo che è migrato sulle montagne potrebbe dividersi e insediarsi in sistemi ecologici diversi – ad esempio a varie altitudini – diversificando le possibilità di riformulazione etnica»23. La dicotomia tra montagne e valli è stabilita dal fatto storico della fuga dallo stato di pianura da parte di una porzione della sua popolazione. La diversità culturale, linguistica ed etnica nelle alture è creata sia dai conflitti sia dalla grande varietà di sistemi ecologici e dal loro relativo isolamento, causato dall’attrito del territorio.
Come nella maggior parte dei casi, gli stili di vita delle montagne e delle valli erano caricati e codificati culturalmente. A Luzon la gente di pianura era associata con cattolicesimo, battesimo, sottomissione (tasse e lavoro di corvée) e «civilizzazione». La valle invece associava le alture a paganesimo, apostasia, natura selvaggia e ferocia primitive e insubordinazione. Per molto tempo il battesimo è stato considerato come un atto pubblico di sottomissione ai nuovi dominatori e la fuga una forma di insurrezione (quelli che scappavano venivano chiamati remontados). Come altrove, nei centri di valle si facevano distinzioni tra popoli delle alture «selvaggi» (feroces) e «domestici» (dociles), un po’ come la cavalleria degli Stati Uniti faceva differenza tra «pellerossa amichevoli» e «ostili». A Luzon quella che era una popolazione comune lacerata da una scelta fondamentalmente politica tra diventare suddito di un sistema di governo piú gerarchico o preferire una vita relativamente autonoma sulle alture è stata riconfigurata come differenza essenziale e primordiale tra una popolazione avanzata e civilizzata, da una parte, e un popolo arretrato e primitivo dall’altra.
Il popolamento di Zomia: la lunga marcia.
Il termine selvaggi, usato da cosí tanti autori per definire le tribú delle alture dell’Indocina, è molto impreciso e fuorviante: molte di queste tribú sono piú civilizzate e umane degli abitanti dei territori pianeggianti del paese. Oberati dalle tasse, non sono altro di quel che resta di imperi una volta grandiosi.
ARCHIBALD ROSS COLQUHOUN, Amongst the Shans, 1885.
Il popolamento di Zomia è stato soprattutto un effetto dello stato. Neanche persone molto piú competenti di me riuscirebbero a fare un semplice resoconto dello spostamento, durato quasi duemila anni, dei popoli provenienti dai bacini fluviali del Fiume Azzurro e del Fiume delle Perle e dagli altopiani del Sichuan e del Tibet. Le teorie e le leggende abbondano, ma i fatti verificabili sono scarsi, non da ultimo perché i «popoli» in questione erano designati con cosí tante etichette diverse e contraddittorie che non si è mai del tutto sicuri a chi si riferiscano. Ad esempio, non c’è ragione di ritenere che il gruppo chiamato miao – che comunque è un esonimo – nel XV secolo abbia necessariamente una relazione con il gruppo chiamato miao da un amministratore han nel XVIII secolo. E la confusione non si ferma alla terminologia: nella ridda delle continue migrazioni e collisioni sociali, i gruppi, uno dopo l’altro, si mescolavano e trasformavano cosí di frequente che non c’è nemmeno ragione di supporre che questi popoli abbiano una qualche continuità genealogica o linguistica di lungo periodo.
Di fronte alla totale incertezza riguardo alle identità, è possibile azzardare qualche ampia generalizzazione sullo schema generale del movimento.
Tabella 2.
Insurrezioni nella Cina sud-occidentale divise per province, come riportate dalla Grande enciclopedia cinese fino alla metà del XVII secolo.
|
722-207 a.C. |
206 a.C. - 264 d.C. |
265-617 d.C. |
618-959 d.C. |
960-1279 d.C. |
1280-1367 d.C. |
1368-1644 d.C. |
|
|
Sichuan |
0 |
2 |
1 |
0 |
46 |
0 |
3 |
|
Hunan |
5 |
20 |
18 |
10 |
112 |
6 |
16 |
|
Guangxi |
0 |
0 |
0 |
14 |
51 |
5 |
218 |
|
Guangdong |
0 |
4 |
3 |
5 |
23 |
17 |
52 |
|
Yunnan |
1 |
3 |
3 |
53 |
0 |
7 |
2 |
|
Guizhou |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Fonte: Herold J. Wiens, China’s March toward the Tropics: A Discussion of the Southward Penetration of China’s Culture, Peoples, and Political Control in Relation to the Non-Han-Chinese Peoples of South China in the Perspective of Historical and Cultural Geography (Shoe String, Hamden, Conn., 1954), p. 187.
L’espansione dei regni han al di fuori del loro territorio d’origine, non risicolo, nella zona del Fiume Giallo interessò zone in cui sorgevano stati risicoli – vale a dire, i bacini del Fiume Azzurro e del Fiume delle Perle e, verso ovest, lungo il corso dei fiumi e nelle pianure. La popolazione che viveva in queste zone di espansione aveva tre scelte: assimilazione e assorbimento, ribellione o fuga (spesso dopo aver cercato invano di fare resistenza). Il ritmo variabile delle rivolte a seconda della provincia e della dinastia fornisce un approssimativo indicatore geografico e storico dell’espansione dello stato han: in genere le insurrezioni avevano luogo nelle regioni in cui la pressione espansiva han era piú forte; la tabella delle rivolte, abbastanza ampia da rientrare nella Grande enciclopedia cinese, è suggestiva.
La Tabella 2 rispecchia la grande spinta durante la prima dinastia Tang nello Yunnan e i successivi tentativi da parte dei Song di controllare Sichuan, Guangxi e Hunan. Un momento di tregua relativa, almeno in questa regione, alla fine del XIV secolo fu seguito da una massiccia invasione Ming: circa trecentomila soldati e coloni dell’esercito che dovevano sconfiggere gli oppositori Yuan. Molti invasori si stabilirono da coloni come avevano fatto gli Yuan prima di loro e questo provocò numerose rivolte, soprattutto tra i miao e gli yao in Guangxi e Guizhou24. Anche se non compare nella tabella, nelle stesse zone l’invasione imperiale e la resistenza armata continuò sotto i Manchu/Qing, la cui politica di passare da un dominio tributario e indiretto all’amministrazione diretta da parte degli han provocò ulteriori disordini e fughe. Tra il 1700 e il 1850 circa tre milioni di coloni e soldati han entrarono nelle province sud-occidentali, portando la proporzione degli han rispetto ai venti milioni di abitanti della regione al 60 per cento25.
A ogni fase dell’espansione han, una parte, grande o piccola, della popolazione preesistente cadeva sotto l’amministrazione han e alla fine veniva assorbita come sudditi e contribuenti fiscali del regno. Questi gruppi lasciarono il loro segno, spesso indelebile, su ciò che significava essere «han» in quell’area, ma sparirono come gruppi etnici distinti e auto-identificati26. Ma ovunque ci fossero territori aperti dove chi voleva restare fuori dallo stato han poteva fuggire, l’emigrazione rimaneva una possibilità sempre presente. I gruppi abituati alla coltivazione delle risaie, soprattutto i tai/lao, cercavano di trovare piccole valli nei territori montuosi piú favorevoli all’agricoltura del riso irriguo; altri gruppi si rifugiavano sui pendii e nelle gole piú remoti in cui avevano una buona possibilità di restare indipendenti perché gli han consideravano quei territori fiscalmente sterili e poco promettenti dal punto di vista agricolo. Questo sembra essere il processo principale attraverso il quale, nei secoli, si sono popolate le alture di Zomia. Come riporta approfonditamente Herold Wiens, il primo che ha raccontato questa enorme migrazione:
L’effetto di queste invasioni fu la colonizzazione, in fasi successive, del Sud-ovest della Cina da parte degli han/cinesi dalle valli del Fiume Azzurro verso sud-ovest fino alle frontiere con lo Yunnan e lo sradicamento dei popoli tribali della Cina meridionale dai loro vecchi territori e dai terreni piú favorevoli all’agricoltura. Il movimento dei popoli tribali determinati a conservare il loro modo di vivere si diresse verso territori di frontiera scarsamente insediati dove l’ambiente piú sfavorevole – vale a dire, regioni caldo-umide e malariche – scoraggiava la rapida avanzata degli han/cinesi. Un secondo movimento fu in senso verticale, verso gli ambienti piú sfavorevoli dei territori di alta montagna, per lo piú inadatti alla coltivazione del riso e non ambiti dagli agricoltori han/cinesi. La prima direzione fu intrapresa dai popoli tribali tai, che amavano l’acqua, abitavano nelle valli e coltivavano il riso; la seconda direzione dai nomadi delle montagne o dai coltivatori itineranti, i miao, gli yao e i lolo e i gruppi di agricoltori a essi collegati. Ma i profughi che si rifugiarono nei territori montuosi non trovarono spazi sufficienti, cosicché anche tra loro ci furono migrazioni verso i territori di frontiera a sud e sud-ovest e persino oltre le frontiere del Vietnam-Laos e della Birmania del Nord e della Thailandia del Nord27.
La grande barriera all’espansione del potere dello stato e alla colonizzazione han sono le montagne dello Yunnan, del Guizhou e del Guangxi occidentale e settentrionale, dove i movimenti sono ostacolati da un forte attrito della distanza. La topografia impervia continua verso sud, attraverso quelli che sono diventati confini internazionali, nei settori settentrionali degli stati del Sud-est asiatico continentale e dell’India nord-orientale, quindi anche queste zone devono essere considerate parte di quello che chiamiamo Zomia. È proprio verso questo bastione geografico contro l’espansione statale che si sono spinte le popolazioni che cercavano di sfuggire all’assimilazione. Nel corso del tempo si sono adattate all’ambiente montano e, come vedremo, hanno sviluppato strutture sociali e routine di sussistenza adatte a evitare l’assimilazione, ma per questo ora sono viste dai loro vicini di pianura come popolazioni tribali povere e arretrate, incapaci di civilizzarsi. Ma, spiega Wiens, «Non c’è dubbio che gli antichi predecessori delle “tribú delle montagne” dei giorni nostri occupassero anche le pianure. […] La netta distinzione di miao e yao come abitanti delle montagne è apparsa solo molto piú tardi. Per le tribú che volevano sfuggire alla dominazione e all’annullamento questa dinamica non è stata una questione di preferenze ma una necessità»28.
Dare conto in modo approfondito e accurato della storia della migrazione di ogni particolare popolo è un’impresa piena di difficoltà, in parte a causa delle molte riformulazioni identitarie dei gruppi. Wiens ha comunque provato ad abbozzare la storia del grande gruppo conosciuto dagli han come miao, una parte del quale chiama se stesso hmong. Sembra che intorno al VI secolo, i «miao-man» («barbari»), con la propria aristocrazia, rappresentassero una seria minaccia militare per le valli han a nord del Fiume Azzurro e che, tra il 403 e il 610, avessero fomentato piú di 40 rivolte. Quando, alla fine, vennero sconfitti, si pensò che quelli che non erano stati assimilati fossero diventate genti disperse e disaggregate, senza una nobiltà. Con il tempo, il termine miao finí per essere applicato indiscriminatamente a quasi tutti i gruppi acefali alla frontiera dello stato han – quasi un’abbreviazione di «barbaro». Negli ultimi cinquecento anni, sotto i Ming e i Qing, le campagne per l’assimilazione o per «la soppressione e lo sterminio» furono quasi continue. Le campagne di soppressione seguite alle rivolte del 1698, del 1732, del 1794 e soprattutto all’insurrezione del 1855 nel Guizhou, dispersero i miao in direzioni diverse in tutto il Sud-ovest della Cina e nelle regioni montuose del Sud-est asiatico continentale. Per Wiens, queste campagne di espulsione e sterminio furono paragonabili al «trattamento degli Indiani da parte degli americani»29.
In conseguenza della loro fuga precipitosa, i miao si sparsero ampiamente in tutta Zomia. In genere si stabilirono ad altitudini elevate per coltivare mais e oppio, ma i miao/hmong si possono trovare anche ad altitudini intermedie a coltivare riso irriguo, a fare i raccoglitori o gli agricoltori itineranti. Wiens spiega questa diversità con la tempistica dell’apparizione dei hmong in una particolare località e con la forza nei confronti dei gruppi rivali30. Se chi arriva dopo è superiore dal punto di vista militare, di solito si impadronisce dei territori di valle e costringe i gruppi preesistenti a spostarsi piú in alto, spesso innescando una sorta di reazione a catena31. Se invece chi arriva dopo è piú debole, è costretto a occupare le nicchie rimaste, spesso sulle pendici piú alte. In un caso o nell’altro, su ogni catena o sistema montuoso si forma una sovrapposizione verticale di «etnie». Cosí, nello Yunnan sud-occidentale ci sono mon che vivono sotto i millecinquecento metri, i tai sono negli altopiani fino a millesettecento metri di altezza, i miao e gli yao sono ancora piú in alto e infine gli akha, probabilmente il gruppo piú debole, vivono vicino alle creste delle montagne fino a milleottocento metri di altezza.
Tra i popoli e le culture che si sono spinti a sud e a sud-ovest nelle regioni montuose di Zomia, i piú numerosi sembrano i tai, che oggi costituiscono il gruppo piú rilevante. La grande comunità linguistica tai comprende i thai e i lao delle pianure, gli shan della Birmania, gli zhuang della Cina sud-occidentale (la principale minoranza della Repubblica popolare cinese) e vari gruppi collegati dal Vietnam settentrionale fino allo stato indiano dell’Assam. Il tratto distintivo di molti tai (ma non di tutti) rispetto agli altri popoli di Zomia è che, a quanto pare, sono sempre stati creatori di stati; in altri termini, praticano da molto tempo la coltivazione del riso irriguo e hanno una struttura sociale – basata sul dominio dispotico, l’abilità militare e, in molti casi, sulla pratica di una religione secolare – che facilita la formazione dello stato. In effetti, storicamente sarebbe piú accurato considerare l’«essere tai» come l’«essere malese», vale a dire, il prodotto di una tecnologia creatrice di stato nata da uno strato superiore di élite/aristocrazia militare nella quale, con il tempo, sono stati assimilati molti popoli diversi. Le loro piú grandi imprese di creazione dello stato sono state il regno di Nanzhao e il successivo regno di Dali nello Yunnan (737-1153) che respinse le invasioni tang e per un periodo riuscí a impadronirsi di Cheng-du, la capitale del Sichuan32. Prima di essere distrutto dall’invasione mongola, questo centro di potere aveva conquistato il regno Pyu della Birmania centrale ed esteso la sua influenza all’interno del Laos e della Thailandia settentrionali. La vittoria mongola causò un’ulteriore dispersione in gran parte delle regioni montuose del Sud-est asiatico e oltre: nelle alture, ovunque ci fosse una pianura adatta alla coltivazione del riso, era probabile trovare un piccolo stato sul modello tai. A parte situazioni particolarmente favorevoli come Chiang Mai e Kengtung, la maggior parte di questi stati erano poco rilevanti, a causa dei loro limiti ecologici ristretti. Di solito erano in competizione tra loro per attirare popolazione e controllare rotte commerciali, tanto che un osservatore britannico descrisse giustamente le alture della Birmania orientale come «una baraonda di stizzosi stati shan»33.
A Zomia, come in qualunque altra shatter zone di lunga durata, le complessità di migrazione, riformulazione etnica e modelli di sussistenza sono sconfortanti. Anche se un certo gruppo all’inizio può essersi spostato sulle alture per scappare, ad esempio, alla pressione dello stato han o birmano, esiste ogni sorta di ragioni per innumerevoli spostamenti e frammentazioni successivi – ad esempio, rivalità con altri popoli delle alture, scarsità di terre per il debbio, attriti all’interno del gruppo, una serie di sfortune che indica che gli spiriti del luogo sono avversi, fuga dalle razzie e cosí via. Inoltre, ogni grande migrazione innesca una reazione a catena di spostamenti secondari provocati dal primo – un po’ come la sequenza di invasioni dei popoli delle steppe, spesso a loro volta conseguenza di altre invasioni, che mise in ginocchio l’impero romano o, per usare un paragone piú contemporaneo, un maniacale gioco di autoscontri in cui ogni macchina aggiunge la propria onda d’urto agli impatti precedenti34.
L’ubiquità e le ragioni della fuga.
Anche molti abitanti della Birmania e di Pegu, che non potevano piú sopportare la pesante oppressione e i continui tributi in uomini e denaro che erano costretti a versare, hanno lasciato le terre natali insieme alle loro famiglie […] Quindi di recente non si è assottigliato solo l’esercito ma la stessa popolazione del regno è molto diminuita. […] Quando sono arrivato a Pegu per la prima volta, in ogni ansa del grande fiume Awa [Irrawaddy] c’era una fila lunga e ininterrotta di abitazioni, ma al mio ritorno lungo l’intero corso del fiume si vedevano solo pochissimi villaggi.
Padre Sangermano, 1800 circa.
La pressione lunga quasi duemila anni – discontinua ma inesorabile – dello stato e dei coloni han su Zomia è stata sicuramente il grande processo storico maggiormente responsabile della fuga delle popolazioni nei territori montuosi, ma non è stato il solo. Anche lo sviluppo di altri centri statali, tra cui Pyu, Pegu, Nanzhao, Chiang Mai, e vari stati birmani e thai ha messo in movimento e portato fuori dall’influenza dello stato molte persone. Processi statali «comuni», come l’imposizione fiscale, il lavoro coatto, guerre e rivolte, dissenso religioso e le conseguenze ecologiche della costruzione dello stato sono stati la causa della regolare espulsione di sudditi vessati e, fatto piú notevole dal punto di vista storico, di precipitose fughe su larga scala.
La libertà di movimento dei contadini del Sud-est asiatico era notevole – sia nelle pianure che nelle regioni montuose. I primi visitatori europei, gli ufficiali coloniali e gli storici della regione hanno tutti osservato l’eccezionale propensione degli abitanti dei villaggi a migrare ogniqualvolta fossero insoddisfatti delle loro condizioni o pensassero di avere maggiori opportunità altrove. The Gazetteer of Upper Burma and the Shan States, con la sua breve descrizione di migliaia di villaggi e cittadine, lo dimostra35: agli estensori viene riferito ripetutamente che il villaggio era stato fondato di recente o diverse generazioni prima da persone arrivate da fuori, in genere in fuga da guerre e oppressione36; in altri casi, insediamenti che prima erano floride cittadine erano stati completamente abbandonati o ridotti a piccoli nuclei. Tutte le prove suggeriscono che nel periodo precoloniale lo spostamento e la migrazione delle popolazioni fossero la regola e non l’eccezione. La mobilità fisica, generalizzata e di grande entità, dei coltivatori del Sud-est asiatico – compresi i coltivatori di riso irriguo – contraddice totalmente «il duraturo stereotipo del nucleo famigliare contadino radicato nel territorio». Come spiega Robert Elson, «la nota dominante della vita contadina in quest’epoca [coloniale], come di quella precedente, sembra essere stata la mobilità e non la permanenza»37.
Gran parte di questi processi migratori senza dubbio si è sviluppata in pianura – tra un regno e l’altro, tra il centro di un regno e la sua periferia, da aree povere di risorse ad aree piú ricche38 – ma, come abbiamo già visto, le migrazioni si dirigevano anche verso le regioni montuose, le altitudini piú elevate e quindi verso le zone che era piú probabile fossero oltre l’influenza dello stato. All’inizio del XIX secolo, nel corso dell’invasione dello stato di Assam da parte della Birmania, la popolazione di Möng Hkawn, una cittadina di valle del corso superiore del Chindwin, in reazione all’arruolamento forzato e all’imposizione fiscale, fuggí sulle montagne: «per sfuggire all’oppressione che dovevano subire costantemente, gli shan cercarono rifugio tra le gole e le valli remote lungo le rive del Chindwin, e i kachin tra i recessi delle montagne all’estremità orientale della valle»39. Per spiegare meglio questo schema, Scott scrive che le «tribú di montagna», dopo la sconfitta, furono relegate sulle alture e costrette a quella che considera, erroneamente, una forma di agricoltura molto piú faticosa. «Questo duro lavoro è lasciato a miti aborigeni o altre tribú, che i birmani hanno da tempo cacciato dalle ricche pianure»40. Altrove, riflettendo sulla diversità etnica delle zone montuose, Scott azzarda una visione sinottica dell’intera Zomia come una vasta regione di rifugio o shatter zone. La sua formulazione, che sembra riflettere quella di Wiens osservata in precedenza, merita di essere riportata per esteso:
l’Indocina [Sud-est asiatico] sembra essere stato il rifugio delle tribú che fuggivano dall’India e dalla Cina. L’effetto combinato dell’espansione dell’impero cinese, che per secoli non si era spinto oltre il Fiume Azzurro, e delle incursioni delle tribú della Scizia negli imperi di Chandragupta e Ashoka ha spinto gli aborigeni a dirigersi sia a nord-est che a nord-ovest verso l’Indocina, dove si incontrarono e lottarono per la sopravvivenza. Solo una teoria del genere può spiegare la straordinaria varietà e la marcata differenza di razze che si trova nelle valli isolate e nelle alte catene montuose degli stati Shan e dei paesi circostanti41.
Credo che l’interpretazione di Zomia che fa Scott come una zona di rifugio sia sostanzialmente corretta, mentre è fuorviante la sua implicita assunzione che i popoli delle alture che incontrarono i colonizzatori fossero originariamente popoli «aborigeni» e che le loro storie successive fossero quelle di comunità coerenti dal punto di vista genealogico e linguistico. Con ogni probabilità, molti popoli delle alture erano popoli di valle che molto tempo prima erano fuggiti dallo spazio statale. Altri, però, erano popoli di valle «creatori-di-stati», come molti tai, sconfitti da stati piú forti che si erano dispersi o si erano radunati sulle alture. Altri ancora, come vedremo, erano popolazioni espulse dagli stati di valle: disertori, ribelli, eserciti sconfitti, contadini in rovina, abitanti dei villaggi che scappavano da epidemie e carestie, servi e schiavi fuggitivi, pretendenti al trono con i loro seguiti e dissidenti religiosi. Sono questi popoli rifiutati dagli stati di valle, insieme con il costante mescolarsi e ricostituirsi dei popoli delle alture nelle loro migrazioni, che hanno reso le identità di Zomia un tale stupefacente rompicapo42.
È difficile giudicare quanto la fuga sia stata decisiva dal punto di vista demografico per il popolamento delle regioni montuose nel corso dei secoli. Per fare una valutazione occorrerebbero piú dati di quelli che abbiamo sulla popolazione delle alture di mille o piú anni fa, ma le sporadiche prove disponibili suggeriscono che le montagne fossero popolate molto scarsamente: secondo Paul Wheatley, nel Sud-est asiatico insulare – forse come nella montuosa Luzon settentrionale di Keesing – fino a tempi molto recenti le montagne essenzialmente erano spopolate, il che le rendeva «di nessuna importanza umana prima del tardo XIX secolo»43.
È difficile fornire una spiegazione semplice dei motivi per cui i sudditi degli stati di valle abbiano voluto, o siano stati costretti, ad andarsene: quella che segue è la descrizione di qualcuna delle cause piú usuali – che però ignora un evento storico comune che, in un certo senso, portava le persone fuori dall’influenza dello stato senza che queste si dovessero muovere: la contrazione o il crollo del potere dello stato nel suo centro44.
Tasse e lavoro di corvée.
Nel Sud-est asiatico precoloniale, la regola chiave della politica di governo dello stato, riconosciuta tanto nella sua violazione quanto nella sua osservanza, era opprimere i sudditi del regno ma non fino al punto di provocare il loro esodo di massa. Nelle zone dove regni relativamente deboli erano in competizione per la forza lavoro, in genere la popolazione non era molto tartassata, anzi, in queste circostanze lo stato poteva incentivare i coloni a stabilirsi in aree poco abitate concedendo loro cereali, animali per arare e attrezzi.
Al contrario, un grande stato che dominava un importante centro di coltivazione di riso irriguo, in quanto monopolista, era piú portato a sfruttare al massimo il proprio vantaggio. Questo si verificava soprattutto nella zona centrale, quando il regno veniva attaccato o era dominato da un monarca che voleva attuare piani militari o edilizi grandiosi. La popolazione di Kyaukse, insediata nel classico centro agricolo di tutti i regni birmani precoloniali, era disastrosamente povera a causa dell’eccessiva tassazione45. Il rischio di sovrasfruttamento era aggravato da diverse caratteristiche dell’amministrazione precoloniale birmana: l’uso di «esattori» che avevano il diritto di riscuotere le imposte ed erano determinati a trarne profitto, il fatto che quasi metà della popolazione fosse costituita da prigionieri e dai loro discendenti, e la difficoltà di fare l’importantissima stima anno per anno della resa del raccolto e, quindi, della massima quantità di tasse che i contadini avrebbero potuto pagare. Ma il lavoro di corvée e le tasse sui nuclei famigliari e i terreni non erano abbastanza. Almeno in teoria, c’erano tasse e imposte su ogni attività immaginabile: bestiame, santuari di culto nat, matrimoni, legname, nasse, pece per il calafataggio, salnitro, cera d’api, palme da cocco e betel, elefanti; a queste, ovviamente, si sommavano innumerevoli pedaggi su mercati e strade. A tal proposito è utile ricordare che la definizione corrente di suddito di un regno non si riferiva tanto all’etnia, quanto alla condizione di essere in grado di pagare le tasse e lavorare a corvée46.
Il suddito portato al punto di rottura aveva diverse scelte. Forse la piú comune era sottrarsi al servizio della corona, mentre la piú onerosa era quella di diventare il «suddito» di un notabile o di un’autorità religiosa, sempre in cerca di forza lavoro. In alternativa, c’era l’opzione di spostarsi in un altro regno di pianura: negli ultimi trecento anni molte migliaia di mon, birmani e karen si sono spostati nell’orbita thai proprio in questo modo. Un’altra opzione era sottrarsi del tutto all’influenza dello stato e spostarsi nei retroterra e/o sulle alture. In genere tutte queste opzioni erano preferite ai rischi che comportava l’aperta ribellione, che restava una possibilità per lo piú limitata alle élite in lotta per il trono. Fino al 1921 la reazione dei mien e dei hmong alla forte pressione esercitata dallo stato thai perché facessero lavori di corvée fu quella di sparire nella foresta, dopo di che non furono piú oggetto di attenzione da parte delle autorità – e probabilmente era proprio quello che volevano47. Oscar Salemink riferisce di esempi ancora piú recenti di popoli delle alture che si sono spostati in gruppi verso zone piú remote, spesso ad altitudini maggiori, per sfuggire alle imposizioni degli ufficiali e dei funzionari vietnamiti48.
Come già osservato, la perdita di popolazione funzionava come una sorta di dispositivo omeostatico minando la forza del regno. Spesso era il primo segno tangibile che erano stati superati certi limiti di durata. Un indizio concomitante, che compare spesso nelle cronache, era l’apparizione di una popolazione «fluttuante» di persone che per disperazione mendicavano o si davano al banditismo e alle rapine. L’unico modo sicuro di sfuggire agli oneri di essere un suddito in tempi difficili era andarsene, il che spesso significava abbandonare l’agricoltura del riso irriguo per praticare il debbio o la raccolta. È impossibile dire con certezza quanto fosse comune, ma non è stato sicuramente un fenomeno irrilevante a giudicare dal numero di storie orali in cui i popoli delle alture raccontano di essere stati coltivatori di risaie in pianura49.
Guerra e ribellione.
Siamo come formiche, quando siamo in difficoltà ci allontaniamo in cerca di un posto migliore. Ci siamo lasciati tutto alle spalle per stare al sicuro.
Abitante di un villaggio mon mentre fugge in Thailandia, 1995.
Per 500 anni il paese è stato afflitto […] da costanti ribellioni e guerre tra birmani, shan e pegu. Chi non è stato ucciso, è stato portato via dalla propria casa da invasori senza pietà o è stato arruolato per combattere per il re. […] In certi casi i titolari [coltivatori] sono stati uccisi, in altri se ne sono andati in distretti cosí remoti che per loro è stato impossibile mantenere il diritto di possesso della proprietà degli avi, per quanto grande fosse il loro attaccamento.
J. G. Scott [Shway Yoe], The Burman.
L’espressione «gli stati fanno le guerre e le guerre fanno gli stati», coniata da Charles Tilly a proposito della prima Europa moderna vale altrettanto per il Sud-est asiatico50. Per i nostri propositi, il corollario al detto di Tilly potrebbe essere: «Gli stati fanno le guerre e le guerre fanno le migrazioni – di massa». Le guerre del Sud-est asiatico dello stesso periodo furono almeno altrettanto distruttive: le campagne militari mobilitavano piú popolazione adulta rispetto a quelle europee ed era altrettanto probabile che diffondessero epidemie (in particolare, tifo e colera), carestie e la devastazione e lo spopolamento del regno sconfitto. L’impatto demografico delle due vittoriose invasioni del Siam da parte della Birmania (1549-69 e negli anni Sessanta del 1700) fu enorme: la popolazione che viveva intorno alla capitale sconfitta svaní: una piccola parte fu catturata e portata al centro dello stato birmano, mentre il resto si disperse in zone piú sicure; la popolazione della regione centrale del Siam risalí ai livelli precedenti l’occupazione solo nel 192051. E i danni che provocava una guerra vittoriosa alle zone coinvolte nelle campagne militari non erano meno devastanti di quelle inflitti al nemico: le truppe del re birmano Bayinnaung saccheggiarono la capitale siamese, ma la loro mobilitazione provocò l’esaurimento delle riserve di cibo e di popolazione della regione del delta, intorno a Pegu. Dopo la morte del re, nel 1581, le guerre che seguirono tra Arakan, Ayutthaya e la corte birmana di Taungngu trasformarono il territorio intorno a Pegu in un «deserto spopolato»52.
Per i civili non combattenti, specialmente per quelli che si trovavano sulla rotta di marcia degli eserciti, la guerra era, se possibile, piú devastante che per i soldati. Se un esercito europeo del tardo XVII secolo di sessantamila uomini aveva bisogno di quarantamila cavalli, piú di cento carri di provviste e quasi cinquecento tonnellate di cibo al giorno, si può immaginare la vastità dei saccheggi e della devastazione che un esercito del Sud-est asiatico lasciava sul suo cammino53. Per questa ragione le rotte su cui procedeva un’invasione non erano quasi mai i tragitti piú diretti, ma quelli piú convenienti nel tempo e nello spazio a massimizzare la forza lavoro, i cereali, i carri, gli animali da tiro e il cibo – per non parlare dei saccheggi individuali – che richiedeva un grande esercito. Per capire la vastità della devastazione può essere utile un semplice calcolo. Se ipotizziamo, come fa John A. Lynn, che un esercito saccheggi il territorio in una fascia di otto chilometri per ogni lato della sua linea di marcia e che avanzi 16 chilometri al giorno, per ogni giorno di campagna militare la superficie della zona saccheggiata equivale a 260 chilometri quadrati; quindi una marcia di dieci giorni di quell’esercito potrebbe colpire un territorio di ventiseimila chilometri quadrati54. In regni affamati di forza lavoro, la minaccia peggiore delle guerre incessanti non era essere uccisi: in questa forma di «capitalismo di rapina», un combattente fortunato in realtà poteva aspirare a catturare propri prigionieri da vendere come schiavi; il vero pericolo era la totale devastazione che colpiva chi si trovava sulla rotta di marcia degli eserciti – il pericolo di essere catturati oppure di dover fuggire e abbandonare tutto ai soldati. Importava poco se l’esercito in questione fosse il «proprio» o quello di un regno vicino: quello di cui aveva bisogno il quartiermastro del proprio esercito o di quello nemico era lo stesso e lo otteneva saccheggiando i civili e le loro proprietà. Ne sono un esempio le guerre tra Birmania e Manipur, che continuarono sporadicamente dal XVI al XVIII secolo: le ripetute devastazioni spinsero i chin-mizo, un popolo di pianura, a lasciare la valle di Kabe-Kabaw per rifugiarsi sui rilievi, dove piú tardi finirono per essere considerati un «popolo delle alture» che probabilmente «era lí da sempre».
Le mobilitazioni ordinate alla fine del XVIII secolo dal re birmano Bò-dawhpaya (che regnò dal 1782 al 1819) per soddisfare i suoi stravaganti sogni di conquista e di costruzione di edifici cerimoniali furono rovinose per l’intero regno. Il fallimento dell’invasione del Siam nel 1785-86, in cui perí la metà di un esercito che forse ammontava a trecentomila uomini, la massiccia requisizione di forza lavoro per costruire quella che doveva essere la piú grande pagoda del mondo, le mobilitazioni per respingere i contrattacchi thai e per ampliare il sistema di irrigazione a Meiktila e, infine, un’altra mobilitazione generale per un’ultima, disastrosa, invasione della Thailandia da Tavoy misero in ginocchio la popolazione del regno. Un osservatore inglese disse che la popolazione della Birmania del Sud fuggiva «in altri paesi» per paura dell’arruolamento forzato e dei saccheggi degli eserciti. Il banditismo e la ribellione si diffusero ovunque, ma di solito la reazione era fuggire in zone lontane dal centro dello stato e dalle razzie dell’esercito del re. Le voci dell’approssimarsi dell’esercito spingevano i sudditi a fuggire il piú lontano possibile in preda al terrore, perché le truppe del proprio regno «erano in tutto e per tutto come la marcia di un esercito nemico»55. E per ogni guerra importante probabilmente c’erano dozzine di campagne militari minori tra piccoli regni o guerre civili tra pretendenti al trono, come quella del 1866 a Hsum Hsai, un piccolo principato nel modesto regno shan di Hsipaw, che quasi spopolò il distretto. La lunga guerra civile nel tardo XIX secolo per il controllo di un altro stato shan, Hsenwi, fu cosí devastante che alla fine «la piú grande delle moderne capitali shan non arrivava a equivalere al bazar di periferia di una delle antiche città murate56.
Il primo obiettivo di un civile era evitare l’arruolamento coatto. In tempi di mobilitazione, per ogni distretto venivano stabilite quote di coscrizione. Le frequenti successioni di quote draconiane (ad esempio, prima un uomo ogni duecento famiglie, poi uno ogni cinquanta, poi ancora uno ogni dieci e infine la mobilitazione generale) sono un inequivocabile indizio dell’evasione dagli obblighi militari. Le quote venivano raggiunte raramente e veniva usato il tatuaggio per marchiare gli arruolati, in modo da poterli identificare in seguito. Nel tardo periodo Konbaung, e forse anche prima, chi ne aveva i mezzi, poteva evitare l’arruolamento con la corruzione, ma il modo piú sicuro era fuggire dal nucleo dello stato risicolo e stare lontano dalla rotta di marcia dell’esercito. Vivere nei territori attraversati dalle invasioni (e dalle ritirate) delle guerre tra Birmania e Siam del tardo XVIII secolo fu la sfortuna dei karen sgaw e soprattutto dei karen pwo: Ronald Renard crede che fu proprio in questo periodo che si dispersero nelle regioni montuose lungo il fiume Saluen e presero a vivere lungo i crinali in abitazioni lunghe e strette piú difendibili. Anche quelli che molto piú tardi si misero sotto la protezione dei thai rifiutarono di stabilirsi in insediamenti permanenti: «preferivano la vita nomade di coltivatori itineranti perché, affermavano, non appartenere a un territorio specifico li rendeva meno vulnerabili»57.
Ma arruolare un esercito non bastava: per mantenerlo nel corso di una campagna militare che poteva essere ardua erano necessari sforzi giganteschi. Un viaggiatore europeo del tardo XVI secolo dopo aver osservato i saccheggi e gli incendi provocati dalla guerra tra Birmania e Siam, aggiunse, «ma, alla fine, non ritornano mai a casa senza aver lasciato sul campo metà della propria gente»58. Sappiamo che queste guerre non erano particolarmente sanguinarie, quindi è molto probabile che il grosso delle perdite fosse dovuto alla diserzione. Il sospetto è confermato dal resoconto su Cronache del Palazzo di Cristallo di un assedio birmano fallito: dopo cinque mesi di assedio, gli attaccanti esaurirono le scorte e furono colpiti da un’epidemia; l’esercito, che aveva iniziato forte di 250 000 uomini, secondo la cronaca, si disintegrò completamente e, dopo una rovinosa ritirata, «il re raggiunse la capitale accompagnato solo da una piccola scorta»59. Si immagina che, dopo il fallimento dell’assedio e lo scoppio dell’epidemia, gran parte dei soldati disertò e cercò di tornare a casa o di iniziare una nuova vita in un posto piú sicuro. J. G. Scott riferisce che, nel corso di una spedizione militare birmana del tardo XIX secolo contro gli shan, il ministro incaricato delle truppe «non faceva azioni di guerra: secondo le voci che circolavano, non aveva tempo per combattere perché era troppo occupato a evitare che le truppe si disperdessero»60. Sappiamo che i tassi di diserzione, come in quasi tutti gli eserciti premoderni, erano alti specialmente in caso di insuccesso militare61. È impossibile dire quanti disertori – o profughi civili – finirono sulle alture o in altri posti remoti, ma il fatto che molti soldati fossero stati arruolati con la forza o fossero schiavi, o loro discendenti, e che, proprio a causa della guerra, molti non avevano niente da cui ritornare, suggerisce che molti disertori iniziarono nuove vite altrove62.
Ci sono prove frammentarie che i pericoli e le migrazioni dovuti alla guerra spinsero nei territori periferici e ad altitudini piú elevate, e quindi a nuove routine di sussistenza, popoli che prima coltivavano risaie. I ganan, ad esempio, oggi sono una minoranza, forte di circa ottomila persone, che vive sul tratto superiore del fiume Mu (regione di Sagaing, Birmania) tra cime alte mille metri, solcate da profondi burroni63. Ma in passato i ganan erano, o erano diventati, un popolo di pianura, parte a pieno titolo dello stato risicolo Pyu, fino a che i centri del regno furono saccheggiati e distrutti dalle forze mon, birmane e di Nanzhao tra il IX e il XIV secolo. I ganan fuggirono sul tratto superiore del bacino del Mu perché era «lontano dai campi di battaglia»; lí si dedicarono, come fanno tuttora, alla raccolta e all’agricoltura itinerante; non hanno una lingua scritta e praticano una variante eterodossa del buddismo; i loro resoconti sono coerenti, come vedremo, con quelli di molti popoli delle alture contemporanei che rivendicano un passato da popoli di pianura.
Esistono prove sparse piú contemporanee della fuga sulle alture per evitare la cattura o le razzie della guerra. J. G. Scott ipotizzava che gli attuali gruppi sulle montagne intorno a Kengtung/Chaing-tung, in Birmania a est del Saluen, una volta fossero insediati in pianura nella zona di Kengtung e fossero stati spinti sulle montagne, dove ora fanno gli agricoltori itineranti, dalle invasioni thai64. Charles Keyes cita un resoconto missionario del XIX secolo che parla di un gruppo karen isolato, prima insediato in territori piú pianeggianti, che era scappato dai siamesi in una gola quasi inaccessibile tra le montagne tra Saraburi e Khorat65. I chin del Nord si rifugiarono su montagne remote per fuggire dalla guerra tra shan e birmani nel XVIII e nel XIX secolo, a volte dando rifugio a loro volta a principi ribelli birmani in fuga dalle truppe del re66.
È importante notare che, in una situazione di guerra, la devastazione del nucleo statale di coltivazione del riso ha l’effetto di annientare lo spazio statale sia dal punto di vista politico che ecologico. Pur ammettendo che sia un’esagerazione, questa descrizione di Chiang Mai dopo l’invasione birmana è istruttiva: «Le città divennero giungle, i campi di riso divennero praterie, le terre per gli elefanti divennero foreste per le tigri, un luogo dove era impossibile costruire un paese»67. Si potrebbe credere che gli abitanti della pianura, non piú gravati dai pesi che subivano come sudditi dello stato, potessero rimanere al loro posto. Ma il problema era che la sconfitta di un regno faceva sí che gli stati vicini e i mercanti di schiavi gareggiassero per rastrellare la popolazione che rimaneva. Spostarsi dalle pianure a luoghi molto meno accessibili agli eserciti e agli schiavisti offriva una possibilità ragionevole di autonomia e indipendenza. Leo Alting von Geusau crede che questa fosse l’opzione che ebbero gli akha e molti altri gruppi oggi considerati popoli delle alture «da tempo immemorabile»:
Nel corso di molti secoli, quindi, le zone piú inaccessibili delle regioni montuose dello Yunnan e dei vicini Vietnam, Laos e Birmania divennero le zone di rifugio di gruppi tribali marginalizzati dai piccoli stati vassalli che occupavano le aree piú in basso. In questo processo di marginalizzazione, gruppi tribali come gli hani e gli akha selezionarono e strutturarono i loro habitat – secondo l’altitudine e la vegetazione circostante – in modo che non fossero facilmente accessibili a soldati, banditi ed esattori fiscali. Tali processi sono stati chiamati «incapsulamento»68.
Razzie e schiavitú.
La razzia è la nostra agricoltura.
Proverbio berbero.
Come abbiamo visto, normalmente la concentrazione di popolazione e produzione cerealicola era la condizione necessaria alla formazione dello stato. Queste zone offrivano un potenziale surplus per i sovrani costruttori di stato e proprio per questo rappresentavano anche un irresistibile bersaglio per i razziatori. La minaccia di incursioni da parte dei trafficanti di schiavi e/o dei banditi era un pericolo reale e presente per tutti i centri di corte, tranne che per i piú grandi. Nel primo periodo coloniale la paura delle razzie schiaviste malesi aveva spopolato molte zone costiere della Birmania e del Siam e, per questo motivo, i karen evitavano le strade e le spiagge esposte. La prolungata vulnerabilità rischiava di generare sistemi di subordinazione e asservimento. Una situazione del genere caratterizzava l’alta valle del fiume Chindwin (valle di Kabaw) dove i chin delle alture avevano eletto se stessi padroni degli shan di valle e ne deportavano molti come schiavi69. Per la stessa ragione, nel 1960 un’importante cittadina di cinquecento nuclei famigliari e trentasette monasteri fu ridotta a sole ventotto case.
Se dominavano la valle adiacente, di solito ai popoli delle alture conveniva difendere gli insediamenti di valle, in modo da poter commerciare con loro e riscuotere tributi. In condizioni di stabilità imponevano la propria protezione con il ricatto, come in un racket. A volte, gruppi delle alture come i kachin pensavano fosse nel loro interesse stabilire insediamenti «nelle pianure o lungo i fiumi ai piedi delle montagne». Un po’ come i berberi consideravano il tributo che riscuotevano dalle comunità stanziali il «nostro raccolto», i kachin nominavano i capi birmani e shan dell’area di Bhamo lungo l’alto Irrawaddy. «Sembra che in tutto il distretto di Bhamo non ci fosse un solo villaggio che non fosse sotto la protezione dei kachin, che erano i veri padroni del paese»70. Nella sua versione piú tranquilla e routinaria, questa organizzazione potrebbe assomigliare a un proficuo stato premoderno, vale a dire, un racket di protezione monopolistico che mantiene la pace, incentiva la produzione e il commercio e in cambio riscuote una rendita che resta nei limiti sopportabili dai sudditi.
Eppure, i popoli delle alture di queste zone razziavano di continuo gli insediamenti di valle, al punto da «uccidere la gallina dalle uova d’oro» lasciando dietro di loro una pianura devastata e disabitata71. Perché? Credo che la risposta si trovi nella struttura politica delle alture, caratterizzata da molti piccoli regimi rivali in cui ognuno potrebbe aver «associato» gli insediamenti di valle che proteggeva. In termini molto semplici e schematici, la struttura potrebbe sembrare piú o meno come in Figura 2.
Siccome il gruppo kachin A vive a tre o quattro giorni di distanza da un villaggio sotto la sua protezione, il gruppo kachin B può razziare il villaggio protetto da A e scappare; quando viene a sapere dell’incursione, il gruppo kachin A per rappresaglia saccheggia un altro insediamento di valle protetto dal gruppo B. Ovviamente se i gruppi non arrivano a un qualche accordo, questo meccanismo può generare una faida72.
Tale schema ha molte conseguenze sul ragionamento complessivo che sto facendo. La prima è che quella che, soprattutto agli occhi dei popoli di valle (!), sembra una pratica generalizzata di incursioni da parte delle «tribú» delle alture, in effetti, è un’espressione piuttosto ben articolata della politica delle alture. La seconda è che, quando questo schema è diffuso, causa lo spopolamento di vaste zone e il ritiro dalla valle dei soggetti vulnerabili, in questo caso, in luoghi piú lontani dalle alture e piú vicini al fiume, dove la fuga è piú facile. La terza e forse piú importante è che l’obiettivo principale di queste razzie era catturare schiavi, molti dei quali venivano tenuti dai kachin o venduti ad altri popoli delle alture o ai trafficanti. Se la razzia aveva successo, comportava un trasferimento demografico netto di popolazione sulle alture, quindi rappresentava un ulteriore processo tramite il quale i popoli di valle diventavano popoli delle alture e le alture diventavano culturalmente piú cosmopolite.
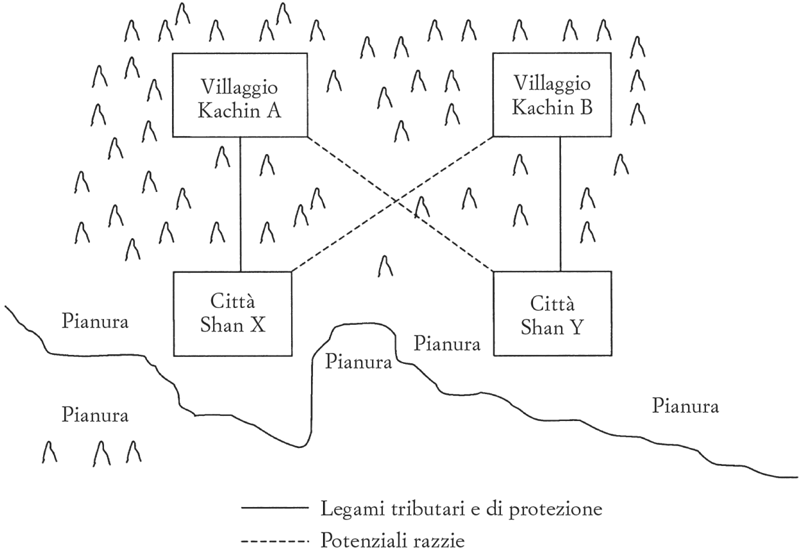
2. Schema delle razzie montagna-valle e delle relazioni tributarie.
Certi popoli delle alture divennero famosi schiavisti, come i karenni (karen rossi), particolarmente temuti negli stati Shan. In certe zone le incursioni schiaviste dopo la stagione del raccolto erano sistematiche73. «Quindi, in gran parte dei villaggi karenni si trovano persone di etnia shan-yang delle tribú karen, di etnia yondali, padaung e let-hta delle catene montuose del nord-ovest, tutte condannate a uno stato di schiavitú senza speranza. […] Sono venduti agli yon (shan di Chiang Mai) che li rivendono ai siamesi»74. L’elenco dei prigionieri dei karenni è significativo perché contiene sia nomi di popoli delle alture sia di popolazioni di valle. I popoli schiavisti come i karenni, specializzati nella merce di scambio piú preziosa, le persone, non si accontentavano di rapire gli abitanti di valle per incorporarli nella società delle alture o rivenderli nei mercati di valle: rapivano anche gli abitanti piú vulnerabili delle alture per schiavizzarli o rivenderli. In un certo senso, erano un nastro trasportatore reversibile di forza lavoro, che ora riforniva il materiale grezzo per la costruzione dello stato nella valle, ora depredava insediamenti di valle vulnerabili per soddisfare le proprie necessità di forza lavoro. Il modello aiuta a capire perché i valligiani temessero i razziatori e perché i popoli piú deboli delle alture si ritirassero in luoghi inaccessibili, spesso sui crinali, dietro palizzate fortificate e camuffate, per ridurre al minimo la loro esposizione75.
Ribelli e scismatici delle alture.
Le ribellioni e le guerre civili che imperversavano in pianura esponevano gli abitanti dei villaggi agli stessi orrori causati dalle invasioni e dalle guerre di conquista. Provocavano schemi di fuga simili in cui le persone cercavano disperatamente di spostarsi in località che immaginavano piú sicure. Ma va osservato che tutti questi modi di fuggire avevano una loro logica e che questa logica era determinata dalla classe sociale o, piú precisamente, dal grado in cui lo status, le proprietà e la vita di qualcuno erano garantiti dal potere statale. La logica è evidente anche nei diversi modelli di fuga dei primi anni della guerra del Vietnam nel Sud del paese, dal 1954 al 1965. Proprietari terrieri, élite e ufficiali che temevano per la propria sicurezza si allontanarono dalle campagne per gravitare sempre di piú verso i capoluoghi di provincia e alla fine, quando il conflitto si aggravò, verso Saigon. I loro movimenti sembrano suggerire che piú vicini erano al cuore dello stato, piú erano al sicuro. Molti comuni contadini, invece, passarono da una vita stanziale in grandi villaggi a insediamenti remoti e nomadi fuori dalla portata dello stato. È come se il fragile patto di una società basata sullo stato si fosse sciolto: le élite vanno al centro, dove il potere coercitivo dello stato si sente di piú, e le non-élite vulnerabili vanno in periferia, dove il potere coercitivo dello stato si avverte in misura minore.
Ovviamente, a meno che non siano molto potenti, i ribelli hanno ragioni ancora piú forti per andare sulle alture. Hardy spiega che le prime fasi della guerra in Indocina (1946-54) causarono «il movimento di un grande numero di persone viet dal delta del Fiume Rosso verso le regioni piú remote degli altopiani settentrionali. La rivoluzione trovò rifugio nelle foreste fino alla valle di Dien Bien Phu, vicino al confine con il Laos»76. Questo modello attraversa tutta la storia del Vietnam e dei paesi della regione. Si può far risalire, almeno, alla grande rivolta Tày Son (1771-1802) che iniziò quando tre fratelli del villaggio omonimo scapparono sulle montagne vicine per mettersi in salvo e reclutare seguaci; continuò nel movimento Can Vuong del primo periodo coloniale vietnamita, nelle rivolte Nghe-Tinh del 1930 e infine nella roccaforte dei Vietminh nelle alture tra la minoranza tho77. La fuga dallo stato da parte di ribelli e non combattenti sotto minaccia spesso genera migrazioni verso nuovi sistemi ecologici e l’adozione di nuove routine di sussistenza. Queste routine non sono solo piú adatte alla nuova località: in genere sono piú diversificate e mobili, rendendo quindi chi le pratica meno leggibile per lo stato.
Il fallimento delle ribellioni, come della guerra in generale, spingeva gli sconfitti ai margini; piú grande era la ribellione, maggiore era la popolazione che doveva spostarsi. La seconda metà del XIX secolo in Cina fu un tempo di enormi sconvolgimenti che misero in marcia centinaia di migliaia di persone, molte delle quali in cerca di rifugio lontano dal potere degli han. Il maggiore di questi sconvolgimenti fu un esito della rivolta dei Taiping avvenuta dal 1851 al 1864, certamente la piú grande ribellione contadina della storia mondiale. Seguono le grandi sollevazioni in Guizhou e nello Yunnan, a volte chiamate la rivolta Panthay, che durarono dal 1856 al 1873 e coinvolsero gli han «rinnegati» e il popolo delle alture miao/hmong, cosí come i musulmani mui-cinesi. Anche se la cosiddetta Ribellione miao non raggiunse le dimensioni della rivolta dei Taiping – che costò la vita a circa venti milioni di persone – durò quasi vent’anni prima di venire schiacciata. I ribelli sconfitti, le loro famiglie e intere comunità in fuga dalla rivolta dei Taiping fuggirono a Zomia mentre i rifugiati dalla Ribellione miao si diressero piú in profondità nel massiccio. Le migrazioni causate dalla fuga dal potere han non solo provocarono ovunque saccheggi, banditismo e distruzione, ma ebbero anche l’effetto di complicare ulteriormente la diversità del paesaggio etnico delle alture. In una sorta di reazione a catena, gruppi in fuga spesso scacciarono altri gruppi che erano arrivati prima di loro. Thongchai Winichakul sostiene che molti cinesi entrati nel Siam settentrionale alla fine del XIX secolo fossero i superstiti delle forze taiping78. I sopravvissuti sconfitti della Ribellione miao si spinsero a sud e molti gruppi akha e lahu, non coinvolti nella ribellione, andarono a sud con loro o li precedettero per mettersi al sicuro79. Nel XX secolo, una ribellione vittoriosa – la rivoluzione comunista in Cina – produsse un nuovo flusso migratorio: le truppe sconfitte del Kuomintang, insediate nella regione oggi conosciuta come il Triangolo d’oro (al confine tra Laos, Birmania, Cina e Thailandia), e i loro alleati delle alture assunsero il controllo di gran parte del commercio dell’oppio, approfittando dell’attrito del territorio delle loro localizzazioni remote sulle montagne e del vantaggio politico di essere situati lungo il confine di quattro giurisdizioni nazionali quasi contigue80. Ma i soldati sconfitti del Kuomintang non sono stati gli ultimi ad aver cercato rifugio a Zomia. Nel 1958, sotto la pressione dei quadri di partito e dei soldati cinesi, un buon terzo della popolazione wa attraversò il confine dalla Repubblica popolare verso la Birmania per cercare riparo81, e durante la Rivoluzione culturale seguí un altro picco migratorio.
La ritirata delle forze del Kuomintang nel Triangolo d’oro ci ricorda che le alture, e Zomia in particolare, sono state per molto tempo luoghi dove gli ufficiali di una dinastia sconfitta, i principi pretendenti e le fazioni sopraffatte nelle politiche di corte hanno potuto rifugiarsi e riorganizzarsi militarmente: all’inizio della dinastia Manchu, principi ming in fuga e i loro entourage si ritirarono nei territori piú sicuri del Guizhou e oltre, mentre in Birmania, nel periodo precoloniale e coloniale, le alture shan e chin ospitarono i principi ribelli e fuggitivi che reclamavano il trono della Birmania (mín laún).
Dissenso politico ed eresia o apostasia religiosa sono cosí legati che, soprattutto prima del XIX secolo, è difficile distinguerli. Occorre comunque sottolineare che, nei confronti delle pianure, le zone montuose sono associate tanto all’eterodossia religiosa, quanto alla ribellione e al dissenso politico82. Ma questo non deve sorprendere: date l’influenza del clero (sangha) nei paesi theravāda come la Birmania e il Siam e una cosmologia che potenzialmente fa del sovrano un re-dio indú-buddista, per la corona era vitale controllare gli abati del regno quanto lo era controllare i suoi principi – e almeno altrettanto difficile. La corona era in grado di imporre i suoi precetti religiosi alla stessa distanza a cui riusciva a imporre la sua politica e le sue tasse – e questa distanza variava in funzione della topografia e del tempo, insieme al potere e alla coesione della corte. La «frontiera» religiosa oltre la quale non era facile imporre l’ortodossia, quindi, non era tanto un luogo o un confine ben definiti, quanto una relazione di potere – il margine variabile oltre il quale il potere dello stato si indeboliva sensibilmente.
Le valli coltivate a riso irriguo e le pianure del tipico stato di valle non sono piatte solo topograficamente: si possono considerare appiattite anche dal punto di vista culturale, religioso e linguistico. La prima cosa che colpisce un osservatore è la relativa uniformità della cultura di valle paragonata alla rigogliosa diversità dei modi di vestire, di parlare, dei rituali, delle coltivazioni e delle pratiche religiose che si trova nelle alture. Questa uniformità è certamente un effetto dello stato. Con la sua pretesa di universalità, il buddismo theravāda, rispetto alle divinità locali (nat, phi) precedenti alla sua diffusione, era la religione di uno stato centralizzato. Nonostante il sincretismo e l’assimilazione delle pratiche animiste, ovunque possibile i monarchi theravāda bandirono i monaci e i monasteri eterodossi, misero fuori legge molti riti indú-animisti (molti dei quali dominati da femmine e travestiti) e diffusero quelli che ritenevano i testi «puri» e non contaminati83. L’appiattimento delle pratiche religiose, quindi, era un progetto dello stato risicolo per assicurare che l’unica altra istituzione elitaria diffusa in tutto il regno, a parte la corona, fosse saldamente sotto il suo controllo. Una certa uniformità era dovuta anche al fatto che le abbazie piú importanti, dopo tutto, erano gestite da un’élite che si appropriava del surplus e che, come la stessa corona, prosperava sulla ricca produzione e sulla concentrazione di forza lavoro disponibili al centro dello stato.
Il potere centralizzato contribuisce a spiegare un certo livello di ortodossia religiosa al centro, ma non giustifica del tutto l’enorme diversità religiosa delle alture. Anche l’eterodossia delle alture era una sorta di effetto dello stato. Oltre a non essere facilmente raggiungibili dal potere statale, le popolazioni delle alture erano piú sparpagliate, diversificate e spesso piú isolate. Il clero buddista, quando era presente, era sparso, decentralizzato e povero, e siccome non aveva il patrocinio o la supervisione reale, dipendeva dal favore della popolazione del posto: se, come accadeva spesso, la popolazione era eterodossa, lo era anche il suo clero84. Perciò era abbastanza probabile che sulle alture nascessero sette scismatiche; se e quando succedeva, erano difficili da reprimere per via della loro collocazione marginale. Ma ci sono altri due fattori decisivi. Il primo è che la combinazione delle sacre scritture buddiste e delle storie jātaka sulle vite anteriori del Buddha (per non parlare della cosmologia del monte Meru attorno a cui era organizzata l’architettura palatina) rappresentava una forte legittimazione al ritiro: eremiti, monaci erranti e ordini religiosi delle foreste, tutti condividevano il carisma e la conoscenza spirituale conferiti soltanto da una posizione esterna alla società85. Il secondo fattore decisivo è che le sette eterodosse, vietate nelle valli, tipicamente cercavano un luogo sicuro sulle alture. La geografia e la demografia delle regioni montuose non solo facilitavano l’eterodossia religiosa, ma servivano anche come zona di rifugio per le sette perseguitate nelle valli.
Un caso emblematico è l’altopiano di Shan della Birmania, una zona di piccoli stati di valle creati da un popolo buddista di coltivatori di riso. Michael Mendelson, nel suo importante studio sul sangha in Birmania, scrive della setta riformista Zawti (luce, radiosità) che sembra essere stata «cacciata dalla vera e propria Birmania» alla fine del XIX secolo ed essersi insediata nell’altopiano di Shan86. La setta adottò alcuni costumi caratteristici shan buddisti, e l’iconografia e i testi shan, ma seguiva anche alcune pratiche eretiche dei Paramat (una setta che per un breve periodo incontrò i favori del re Bodawpaya all’inizio del XIX secolo). Mendelson conclude il suo breve resoconto della setta con un’intuizione coerente con la tesi della «zona di rifugio»: «Gli studiosi dovrebbero seguire una traccia importante: la possibilità che per molti secoli gli shan abbiano offerto rifugio alle sette cacciate dalla vera e propria Birmania a causa delle loro “credenze eretiche”»87. Gli shan divennero buddisti solo nel tardo XVI secolo e può darsi che nella loro conversione abbia avuto un ruolo l’esodo delle sette bandite dal centro birmano. In quest’ottica, Edmund Leach osserva che tutti gli shan sono buddisti – quasi una condizione costitutiva dell’identità shan – ma si affretta ad aggiungere: «La maggioranza, in realtà, non è particolarmente devota e il buddismo shan comprende parecchie sette decisamente eretiche»88. Molto prima, nel suo Gazetteer, Scott parla di monaci negli stati Shan che facevano i commercianti, portavano armi, vivevano in fortezze, fumavano e indossavano berretti; poi cita un certo Dr Cushing, secondo il quale il grado di eterodossia aumenta con l’aumentare della distanza dal potere centrale birmano89. Un giornalista che viaggiava clandestinamente negli stati Shan negli anni Ottanta parla di monaci buddisti vicino al confine cinese che dormivano con le donne, fumavano oppio e vivevano in monasteri fortificati90. Secondo queste prove frammentarie sembra probabile che il buddismo shan possa rappresentare una sorta di archeologia storica vivente delle sette buddiste dissidenti, soppresse ed espulse dai territori centrali della Birmania negli ultimi secoli.
Quindi, Zomia divenne un luogo di rifugio per ribelli ed eserciti sconfitti della pianura, ma anche per sette religiose messe al bando. Se si rileggono gli ultimi secoli alla luce di questo processo, si può capire come Zomia abbia finito per somigliare a una sorta di società ombra, un’immagine speculare dei grandi stati risicoli – per quanto usasse molta della stessa materia prima cosmologica. Era una zona che attirava le idee e le persone vittime della creazione dello stato, i danni collaterali dei modelli dinastici. Il pluralismo espulso dalle valli si può trovare in abbondanza sulle alture – schegge che ci dicono quello che i regni di pianura hanno estromesso dalla valle e quindi ciò che, in circostanze diverse, avrebbero potuto diventare.
La frequenza con cui i territori periferici – montagne, deserti, dense foreste – sono strettamente associati al dissenso religioso è troppo comune per essere trascurata. La frontiera cosacca della Russia zarista era notevole non solo per la sua struttura sociale egalitaria, ma anche per essere una roccaforte dei Vecchi credenti, le cui dottrine giocarono un ruolo importante nelle grandi rivolte contadine di Razin e Pugačëv. La Svizzera fu a lungo contrassegnata da egalitarismo ed eterodossia religiosa, mentre le Alpi in generale erano viste dal Vaticano come una culla dell’eresia: i valdesi vi trovarono rifugio e, a metà del XVII secolo, sotto la minaccia della conversione forzata da parte del Duca di Savoia, si spostarono nelle valli piú alte. Anche la Riforma si diffuse nella regione alpina ma ne seguí la frammentazione geografica, con Ginevra che diventò calvinista e Basilea osservante dello zuinglianesimo91.
L’eterodossia delle alture si potrebbe considerare solo un riflesso abbastanza scontato della marginalità politica e geografica, una zona di resistenza in cui le minoranze perseguitate all’occorrenza si potevano rifugiare. Ma questa visione non renderebbe affatto giustizia della natura dialogica di questa specificità, che è il risultato di una scelta culturale ed espressione di diversità e resistenza. Ad esempio, è stato osservato che i berberi delle montagne hanno spesso riformulato il loro dissenso religioso come atto di implicita opposizione nei confronti dei loro vicini dominatori: «Quando i Romani che controllavano la provincia di Ifriqiya [Africa] divennero cristiani, si convertirono anche i berberi degli altopiani (che non erano mai stati del tutto sottomessi) – ma abbracciando le eresie donatista e ariana, in modo da distinguersi dalla Chiesa di Roma. Quando la regione divenne islamica, lo divennero anche i berberi, ma presto espressero il loro dissenso nei confronti delle ingiustizie del dominio dei musulmani arabi diventando eretici kharigisti». Robert LeRoy Canfield ha tracciato con precisione un analogo schema di dissenso religioso islamico calcolato accuratamente nei monti dell’Hindu Kush in Afghanistan92. Dove i principali centri agrari di valle sono dominati dai sunniti, i popoli delle alture vicine in gran parte aderiscono allo sciismo imamita, mentre quelli delle montagne piú sperdute e inaccessibili seguono il credo ismailita. Queste affiliazioni seguono contorni ecologici e spesso attraversano frontiere linguistiche ed etniche; sono due forme di dissenso che connotano fortemente popolazioni che non si sono sottomesse a uno stato che definisce se stesso in termini di ortodossia sunnita. L’identità religiosa, allora, diventa una deliberata strategia che permette di tracciare i confini della differenza politica e sociale. Vedremo lo stesso processo nel Sud-est asiatico continentale quando esamineremo i credi millenaristi delle alture nel capitolo VIII.
Affollamento, salute e l’ecologia dello spazio statale.
I primi [i contadini invece dei cacciatori-raccoglitori] hanno sempre le peggiori malattie, le armi e le corazze migliori, le tecniche piú sofisticate, e i governi piú efficienti nell’organizzare le guerre di espansione.
JARED DIAMOND, Armi, acciaio e malattie.
Sappiamo che la coltivazione stanziale dei cereali e l’allevamento di bestiame domestico (maiali, polli, anatre, oche, mucche, cavalli, pecore e cosí via) hanno provocato lo sviluppo senza precedenti delle malattie infettive. La maggior parte delle epidemie fatali di cui soffriamo – vaiolo, influenza, tubercolosi, peste, morbillo e colera – sono patologie zoonotiche che si sono evolute dagli animali domestici. L’affollamento è un fattore cruciale, perché implica la concentrazione non solo delle persone ma anche degli animali domestici e dei parassiti «obbligati» che inevitabilmente li accompagnano: ratti, topi, zecche, zanzare, pulci, acari e cosí via. Dal momento che le malattie in questione si diffondono per prossimità (tosse, contatto fisico, fonti idriche condivise) o attraverso i parassiti, la densità di ospiti rappresenta di per sé un ambiente ideale per il rapido diffondersi delle infezioni epidemiche. I tassi di mortalità delle città europee all’inizio dell’era moderna superano la crescita naturale della popolazione fino a circa metà del XIX secolo, quando le misure di igiene pubblica e la disponibilità di acqua pulita li fecero diminuire sensibilmente – e non c’è motivo di credere che le città del Sud-est asiatico fossero piú salubri. La grande maggioranza di queste malattie si potrebbe giustamente chiamare «malattie della civilizzazione»: fanno la loro comparsa nei documenti storici insieme ai centri di coltivazione dei cereali e alla concentrazione di flora, fauna e insetti che questi comportano93.
Le cronache degli stati risicoli e la testimonianza di antichi visitatori europei attestano la frequenza di epidemie devastanti nelle maggiori città del Sud-est asiatico premoderno94. David Henley, nel suo studio esauriente e accurato sul Sulawesi centrale e settentrionale, dimostra che le malattie epidemiche, soprattutto il vaiolo, rappresentavano un ostacolo importante alla crescita della popolazione. La popolazione costiera, forse per gli effetti dell’affollamento e della prossimità alle rotte commerciali, sembrava meno in salute delle «popolazioni delle zone montuose», «che davano l’impressione di essere piú forti e sane95.
Sembra che tutti fossero consapevoli che, in caso di epidemia, la via piú sicura era lasciare immediatamente la città e disperdersi nelle campagne o sulle alture. In genere l’effettivo vettore della malattia non era conosciuto, ma si sapeva che la dispersione e l’isolamento ritardavano il diffondersi dell’epidemia. I popoli delle alture pensavano che le pianure fossero insalubri: per i popoli che vivevano sopra i mille metri ciò poteva essere in relazione alla presenza della malaria alle altitudini inferiori o riflettere la paura delle epidemie urbane e le malattie trasmesse tramite il commercio marittimo. A Luzon, gli Igorot che vivevano a bassa quota sapevano che, quando scoppiava un’epidemia, se volevano salvarsi dovevano tornare sulle montagne, disperdersi e chiudere i passi96. È impossibile dire quanto la fuga nelle montagne fosse importante dal punto di vista demografico o in quale proporzione chi era fuggito ritornava una volta passato il pericolo. Tuttavia se all’equazione si aggiunge la fuga provocata da siccità e carestia, si capisce che l’impatto demografico di questi movimenti deve essere stato significativo.
Tutta l’agricoltura è una faccenda rischiosa ma, facendo un bilancio, l’agricoltura del centro risicolo sotto molti aspetti era piú a rischio – con un’eccezione importante – dell’agricoltura dei territori montuosi e, a maggior ragione, della raccolta. L’unico vantaggio importante della coltivazione del riso irriguo, quando l’approvvigionamento idrico deriva da corsi d’acqua perenni, è che resiste alla siccità almeno per un certo periodo97. Dall’altra parte, la grande diversità della coltivazione itinerante e della raccolta nei territori montuosi fornisce cosí tanti fonti nutritive che la perdita di uno o due raccolti, anche se provoca disagio, è spesso meno catastrofica. Ma la cosa forse piú importante è che le conseguenze epidemiologiche dell’affollamento di una sola varietà colturale ha quasi gli stessi svantaggi dell’affollamento degli esemplari di Homo sapiens. La base genetica relativamente ristretta della produzione dei cereali fornisce un habitat epidemiologico ideale per insetti, funghi, ruggini e altri parassiti, per cosí dire, specializzati nelle colture risicole. L’accumularsi di questi parassiti in una pianura irrigata prevalentemente coltivata a riso può rapidamente diventare catastrofico.
Quando non piove o le coltivazioni sono attaccate da parassiti visibili, la causa della perdita del raccolto è ragionevolmente ovvia, anche se coltivazioni colpite dalla siccità possono poi soccombere a un altro agente patogeno, come un paziente dalla salute già compromessa è vulnerabile a un’infezione opportunistica. Nel tardo XVI secolo, Hanthawaddy, nella Birmania del Sud, fu devastata da un’invasione di ratti che divorarono buona parte delle riserve di cereali98. Quando il cibo finí, la gente scappò, ma è chiaro che l’invasione di ratti fu causata, o almeno facilitata, dalla presenza di grandi riserve di cereali. Le cause della perdita del raccolto e della grave carestia che colpí la Birmania superiore tra il 1805 e il 1813, invece, sono sconosciute: sembra che abbia avuto un ruolo la siccità, come lo ebbe, secondo Thant Myint-U, in riferimento alle teorie di Malthus, l’eccessiva pressione della popolazione su un territorio agricolo limitato99. Ma, quale ne fosse stata la causa precisa, la carestia accelerò l’esodo della popolazione; in particolare, provocò «un enorme movimento verso la coltivazione itinerante», e le risaie abbandonate furono cosí tante che gli esattori fiscali konbaung dovettero inventarsi una nuova categoria catastale per renderne conto. Non è chiaro se questi sudditi in fuga si siano spostati sulle alture, ma una cosa è certa: abbandonarono il centro risicolo in massa100.
Il suggerimento di un’eccessiva pressione della popolazione sul centro risicolo fa sorgere l’interessante possibilità che il centro fosse auto-limitante ecologicamente oltre che fiscalmente, che è proprio quello che sostiene Charles Keeton101. Secondo lui, la massiccia deforestazione della zona secca sotto il re Mindon ebbe come conseguenza l’aumento del deflusso delle acque e l’insabbiamento dei canali e dei pozzi di irrigazione. Molti canali furono abbandonati. Una leggera fluttuazione verso il basso delle piogge – in un’area già caratterizzata da precipitazioni molto basse (da cinquanta a sessantacinque centimetri l’anno) – poteva scatenare una siccità e l’esodo della popolazione. Secondo questa interpretazione, la zona secca era diventata un sistema ecologico fragile e degradato, incline a provocare la perdita del raccolto. Tra chi fuggiva dalla carestia, qualcuno si diresse sulle alture, mentre la maggioranza, alla fine del XIX secolo, andò verso la frontiera aperta e fiorente del delta dell’Irrawaddy; in ogni caso, anche loro lasciarono il centro risicolo.
In controtendenza.
Nelle fonti ufficiali, le rosee autorappresentazioni dinastiche degli stati risicoli precoloniali nel Sud-est asiatico e delle dinastie Ming e Qing restituiscono l’immagine di una serena congregazione di popoli: saggi amministratori guidano rozze popolazioni verso un erudito centro di corte confuciano o buddista, in cui la coltivazione stanziale di riso irriguo e l’essere sudditi del regno rappresentano i segni della conquista della civiltà. Come tutte le autorappresentazioni ideologiche, l’ideale hegeliano che raffigurano sembra una crudele parodia dell’esperienza vissuta, specialmente alla frontiera, come lo era l’uso della parola «pacificazione» nella guerra del Vietnam.
Tralasciando per un momento la questione piú ampia del significato di «civilizzazione», possiamo dire che l’autorappresentazione è radicalmente sbagliata sotto almeno due aspetti. Primo, il processo che ha concentrato la popolazione, in genere, non era affatto un sereno e volontario viaggio verso la civiltà. Gran parte degli abitanti del centro era costituita da prigionieri – catturati in massa come bottino di guerra e portata nel cuore del regno o, per cosí dire, acquistata al dettaglio dagli schiavisti che vendevano allo stato la merce di cui aveva piú bisogno. Nel 1650 la proporzione di ahmudan ereditari (reggimenti di servizio per lo piú costituiti da schiavi e dai loro discendenti) in un raggio di duecento chilometri dalla capitale del regno di Ava arrivava al 40 per cento. Dal 1760 al 1780 fu organizzata una massiccia deportazione di prigionieri da Manipur, dai monti Shan e dalla bassa Birmania per rimpinguare i ranghi ahmudan ormai sguarniti. Un esempio ancora piú impressionante di un regno popolato da prigionieri era il Siam: secondo un osservatore, alla fine XVII secolo un terzo della popolazione del Siam centrale era composto da «forestieri che discendono soprattutto da prigionieri di guerra lao e mon». Per ovviare alla perdita di popolazione causata delle invasioni birmane, all’inizio del XIX secolo il Siam lanciò una grande campagna militare di cattura, con il risultato che «nel bacino centrale, il totale dei malesi, laotiani, mon, khmer e birmani equivaleva al numero di persone che si identificavano come siamesi»102. Con questo non voglio negare che un numero importante di persone provenienti dai territori periferici fossero attratte dai vantaggi e dalle opportunità che offriva il centro di corte nei periodi favorevoli, ma affermare che, in queste circostanze demografiche, questo tipo di creazione dello stato non sarebbe stata nemmeno concepibile senza cattura di prigionieri e schiavitú.
La seconda e piú grave omissione in questa autorappresentazione è la prova schiacciante della fuga dal cuore dello stato. Ovviamente prenderne atto sarebbe palesemente in contraddizione con il discorso sulla civiltà: perché mai qualcuno vorrebbe lasciare il centro risicolo per «andare dai barbari»? Si può perdonare l’errore agli osservatori affetti da miopia storica, visto che gli ultimi sessant’anni sono stati caratterizzati da un’imponente crescita della popolazione dei centri urbani e da un crescente controllo sui territori montuosi da parte dello stato moderno. Ma per tutto il corso del millennio precedente è molto chiaro che fuggire dallo stato era usuale almeno quanto lo era entrarvi. Il processo non era affatto regolare e subiva profonde oscillazioni tra lo svuotamento quasi completo del centro risicolo e la sua piena occupazione demografica.
I motivi della fuga dal centro dello stato sono molti, ma se ne può fare un elenco approssimativo. Contrariamente al discorso sulla civilizzazione che assume implicitamente che, in assenza di stati predatori, tutti preferiscano coltivare riso nelle pianure, esistevano ragioni concrete per preferire il debbio sulle alture o la raccolta alla coltivazione del riso irriguo. Finché c’era grande abbondanza di territori aperti, come accadeva fino a tempi relativamente recenti, in generale il debbio era piú efficiente della coltivazione del riso irriguo in termini di rendimento del lavoro. Inoltre, offriva una maggiore varietà di elementi nutritivi in ambienti generalmente piú sani. E infine, se combinata con la caccia e la raccolta di prodotti di grande valore per le pianure e il commercio internazionale, poteva fornire alti profitti a fronte di uno sforzo relativamente contenuto. Era possibile unire l’autonomia sociale ai vantaggi dello scambio commerciale. Il piú delle volte, andare sulle alture, o restarci, era una scelta di libertà che non costava privazioni materiali.
Dopo il crollo demografico a seguito di una carestia, un’epidemia o una guerra – se si era abbastanza fortunati da sopravvivere –, l’agricoltura itinerante poteva diventare la norma anche nella pianura risicola. Quindi lo spazio di resistenza allo stato non era un luogo sulla mappa, ma una posizione nei confronti del potere: poteva essere creato da efficaci atti di ribellione, da cambiamenti nelle tecniche agricole o da inaspettate cause di forza maggiore. A seconda della portata dell’influenza dello stato risicolo e della resistenza dei suoi potenziali sudditi, lo stesso luogo poteva passare da una pesante oppressione a una relativa indipendenza, e viceversa.
Riguardo alla fuga vera e propria, occorre distinguere tra i processi lenti e logoranti, che costringevano le persone a emigrare anno dopo anno, e gli eventi piú importanti che provocavano un esodo di massa. Nel primo caso, il peso crescente della tassazione e del lavoro di corvée imposti da un regno ambizioso poteva provocare un’uscita costante di sudditi in rovina che si allontanavano dal potere dello stato. Potevano partire per la frontiera anche dissidenti religiosi, gli sconfitti di lotte tra fazioni, persone emarginate dal villaggio, criminali e avventurieri. Come vedremo, nelle società delle alture gli emigrati di questo tipo venivano assimilati velocemente.
È difficile stimare se, nel lungo periodo, alla perdita di popolazione al centro dello stato contribuisse di piú l’accumularsi delle partenze costanti dei sudditi o le crisi che provocavano esodi di massa. La prima, proprio perché poco spettacolare, è piú facile da rintracciare nei registri fiscali che nelle cronache. Al contrario, guerra, carestia, incendi ed epidemie sono piú degni di nota e quindi compaiono nelle cronache e negli archivi. Questi quattro fattori, che insieme alla tirannia, costituiscono i cinque famosi flagelli dei detti popolari birmani103, sono i principali responsabili dei grandi spostamenti di popolazione da uno stato all’altro, della migrazione dal centro risicolo verso i margini del potere dello stato e, negli stessi territori montuosi, del riposizionamento della popolazione.
Non c’è modo di prevedere la catastrofe rappresentata dalla guerra, dalla carestia o dalle epidemie e non c’è modo di sapere in anticipo la loro durata o la loro gravità. Per loro natura questi eventi provocano terrore e fughe tumultuose. Eppure, questi disastri facevano cosí parte della vita del Sud-est asiatico precoloniale che si può immaginare che molte popolazioni avessero delle «procedure di sopravvivenza» in caso di disastro, un po’ come i contadini potevano contare sulla conoscenza degli alimenti di cui nutrirsi per tirare avanti in tempi di carestia. Dispersione, vie di fuga e routine alternative di sussistenza facevano senz’altro parte del repertorio con cui i contadini del centro combattevano le crisi104.
L’esodo di massa, spesso unito a ribellione e banditismo, ha caratterizzato la storia precoloniale della maggior parte degli stati del Sud-est asiatico. Qui si può distinguere tra le catastrofi che hanno spinto la popolazione del centro a cercare un posto sicuro – in un altro stato, ai margini del potere, sulle alture – dalla resistenza e dalla fuga di popolazioni che erano state incorporate a forza nello stato per la prima volta da un’ambiziosa dinastia. Nel Vietnam del Nord dal XIV al XVI secolo sono evidenti entrambe le situazioni. Dal 1340 al 1400, siccità, ribellioni e invasioni portarono al crollo della popolazione del delta del Fiume Rosso addetta alla coltivazione del riso, che passò da 1,6 milioni a 800 000 persone, con molti dei rifugiati che apparentemente fuggirono sulle alture. All’inizio del XVI secolo, il territorio centrale, ormai di nuovo in forze, tentò di estendere il suo potere sui «distretti di montagna a ovest, nord e nord-est della capitale». Una serie di ribellioni – condotte in parte da monaci buddisti e taoisti che si pensava avessero poteri miracolosi – opposero una fiera resistenza e misero migliaia di persone in fuga, molte delle quali probabilmente ripararono all’interno delle zone montuose. Una resistenza altrettanto feroce fu scatenata dalla corte siamese all’inizio del XIX secolo, quando provò a estendere il suo controllo sulla zona lao del Sud, tatuando i contribuenti fiscali (la politica del «ferro rosso»), alzando le richieste di lavoro di corvée «e incoraggiando e promuovendo la completa schiavizzazione delle popolazioni tribali e delle zone montuose»105. Quando le ribellioni venivano soffocate, si può ipotizzare che chi voleva sfuggire all’assimilazione si rifugiasse sulle alture, mentre chi era minacciato dalle spedizioni schiaviste si ritirasse piú in alto sulle montagne in modo da essere irraggiungibile. A partire dalle invasioni mongole del XIII secolo fino a gran parte del XV secolo, la Birmania superiore soffrí caos e carestie durante le quali, secondo Michael Aung-Thwin, «ampi segmenti della popolazione se ne andarono dalle aree tradizionalmente sicure per rifugiarsi in enclave piú al riparo»106. Non è chiaro dove andassero esattamente questi rifugiati, ma una parte significativa deve essersi sparpagliata nel piú vicino territorio periferico del potere dinastico che, in molti casi, erano le alture. Ancora nel XIX secolo, il delta della Birmania inferiore, una zona di rifugio anche in precedenza, divenne la destinazione standard di chi fuggiva dal centro del potere birmano.
Anche con le prove frammentarie di cui disponiamo, possiamo tentare qualche ipotesi sulle oscillazioni delle popolazioni amministrate al centro dello stato risicolo e di quelle fuori dalla sua influenza. Possiamo immaginare una sorta di scala che misura la distanza dal potere dinastico: nel punto piú vicino c’è la popolazione del centro, pesantemente amministrata e addetta alla coltivazione del riso, e in quello piú lontano gli abitanti delle roccaforti sulle creste montuose, ben oltre la portata dello stato; i sudditi dei territori periferici e i gruppi insediati nei retroterra montuosi occupano una posizione intermedia. Schematicamente, e ipoteticamente, ha abbastanza senso pensare che una popolazione, quando messa alle strette, come primo passo si sposti nella zona sicura piú vicina. Quindi, di fronte a una guerra o a una carestia, chi sta al centro si sposterebbe verso la periferia, mentre la popolazione già nei territori periferici all’inizio proverebbe a evitare gli sconvolgimenti del centro staccandosi fiscalmente e organizzando le proprie difese107. Se questa strategia fallisse, si dirigerebbe a sua volta verso il retroterra e le alture. Di fronte a un’estensione del potere dello stato, come amministrazione diretta o attraverso razzie schiaviste, la popolazione del retroterra e delle alture può ribellarsi o fuggire – o ribellarsi e poi fuggire, forse piú all’interno o piú in alto sulle alture108. Quindi, ogni segmento di popolazione, quando è in pericolo, presumibilmente si muove lungo la scala nella posizione successiva piú lontana dal potere dello stato. Sotto condizioni piú favorevoli al centro, il processo funzionerebbe al contrario: molti si sposterebbero piú vicino al centro per approfittare delle opportunità commerciali e di status sociale che vi troverebbero.
Oliver Wolters scrive di uno stato mandala «a fisarmonica» nel Sud-est asiatico: possiamo estendere la similitudine alla popolazione, che ora si avvicina, ora si allontana dalla portata dello stato a seconda del calcolo dei pericoli e dei vantaggi. In questa prospettiva, la popolazione potrebbe essere considerata politicamente anfibia. La sua capacità di muoversi ciclicamente nel corso del tempo tra l’essere relativamente nello stato o fuori dallo stato dipendeva da una vasta frontiera aperta e dalla familiarità con i necessari repertori di struttura sociale e di sussistenza. Ma era davvero una nuova nicchia? Se pensiamo che una buona parte della popolazione era costituita da prigionieri o dai loro discendenti – tra cui moltissimi portati via dalle alture –, allora, forse, per alcuni di loro la fuga dallo stato era una sorta di ritorno a casa.
L’attrito della distanza: stati e culture.
Niente è piú difficile che conquistare un popolo [gli Igorot] che non ha necessità e le cui fortificazioni sono le foreste, le montagne, l’impenetrabile natura selvaggia e i profondi precipizi.
Ufficiale spagnolo, Filippine, XVIII secolo
Gli ufficiali precoloniali e coloniali sapevano bene che gli ostacoli militari alla conquista delle remote zone montuose erano formidabili. La combinazione di una popolazione mobile e generalmente ostile e di una topografia impervia significava che anche le spedizioni punitive, per non parlare dell’occupazione militare, erano imprese molto rischiose. Come si legge nelle Cronache del Palazzo di Cristallo riguardo a una di queste campagne, «I Mahaupayaza e il re di Ava a cui era stato ordinato di andare all’inseguimento dei Sawbwa di Mogaung furono richiamati perché si capí che per gli inseguitori era impossibile procedere senza grande difficoltà in un paese montuoso dove i passi erano bloccati da ammassi di neve e da brume e nebbie che non si alzavano fino a mezzogiorno»109. Scott, che guidava la forte campagna militare per la «pacificazione» della Birmania settentrionale alla fine del XIX secolo, osservava la relazione tra la difficoltà del movimento delle truppe e il tempo necessario a sottomettere un distretto: «Dove ampi tratti di foresta selvaggia, miglia di terreno acquitrinoso infestato dalla malaria, o confusi grovigli di giungle e precipizi permettevano ai banditi una sicura ritirata, per riportare [questi distretti] all’ordine occorrevano un paio d’anni in piú»110. Non era diverso per i francesi in Vietnam: un documento del 1901 avvertiva degli ostacoli che comportava controllare il dissenso e i disordini nelle alture protette da «il riparo di impervie montagne e foreste quasi impenetrabili»111.
Questo è ovviamente il punto di vista dello stato di valle, ma per chi si ritirava sulle alture era un vantaggio naturale da sfruttare. Si potevano chiudere i passi, come facevano gli Igorot e, se necessario, ritirarsi ancora piú all’interno delle montagne. In generale il territorio montuoso favoriva la guerra difensiva e forniva innumerevoli luoghi dove un piccolo gruppo poteva resistere a una forza molto piú consistente. I recessi piú profondi di una zona montuosa, verso i quali il tragitto dal centro di pianura piú vicino è arduo e dove l’attrito della distanza è al massimo, sono i meno accessibili al diretto controllo dello stato. In questi luoghi le montagne sono davvero fortezze naturali. I britannici sapevano che i «selvaggi» wa, situati tra Thailandia, Cina e gli stati Shan orientali della Birmania, vivevano in una zona come questa. Secondo un ufficiale coloniale, le mappe di inizio secolo non riuscivano affatto a descrivere la reale difficoltà del territorio, in cui le dorsali principali «erano attraversate da ripide cime»112. Anche oggi i wa – che forse ammontano a due milioni – «vivono in quello che è senza dubbio uno degli ultimi grandi territori montuosi selvaggi del mondo moderno»113.
Il grado di attrito rappresentato dal territorio non può essere interpretato semplicemente come un dato topografico: il dato in larga misura è progettato e manipolato socialmente per aumentare o minimizzare l’attrito. Seguire i progressi del potere britannico nelle alture vuol dire soprattutto seguire i progressi delle tecnologie per annullare le distanze: ponti, strade sempre percorribili, disboscamento, mappe precise e il telegrafo. Le tecniche avanzate di defogliazione, gli elicotteri, gli aerei e la moderna fotografia satellitare hanno ulteriormente diminuito l’attrito del territorio. Quindi l’attrito non è semplicemente «lí» in modo meccanico: è manipolato costantemente per uno scopo o per l’altro. Chi vuole massimizzare l’attrito della distanza ha a disposizione una schiera di contro-strategie: distruggere ponti, fare imboscate o mettere trappole ai passi e alle gole, far cadere alberi lungo le strade, tagliare i cavi del telegrafo e del telefono, e cosí via. Gran parte della letteratura sulla guerriglia (la parte che non riguarda le tecniche per ottenere informazioni) parla dei modi di gestire il territorio a proprio vantaggio.
La logica militare che determina l’attrito della distanza funziona anche sulle dinamiche di evoluzione sociale e culturale. Capirne a grandi linee le conseguenze serve a mettere in luce alcune distinzioni tra società delle alture e stati risicoli. Molte delle principali influenze culturali del Sud-est asiatico sono state esogene – introdotte da mercanti marittimi: l’induismo braminico, il buddismo e, piú tardi, l’islam sono arrivati in questo modo. Dalla costa, dove sono approdate, queste influenze si diffusero lungo le principali arterie commerciali e i grandi assi migratori rappresentati da pianure e bacini fluviali, seguendo il movimento delle popolazioni di pianura. Si può immaginare una serie di fotogrammi in time-lapse in cui l’influenza di queste idee culturali si diffonde piú velocemente in aree dove la frizione del terreno è minore e maggiore il volume di traffico umano.
A questo riguardo bisogna sottolineare che i luoghi con un attrito molto alto – paludi, terre umide, gole, montagne scoscese, terre incolte, deserti –, anche se in linea d’aria sono abbastanza vicino al centro dello stato, è probabile che rimangano relativamente inaccessibili e quindi zone di differenza politica e culturale. Se aggiungiamo alla dimensione temporale di lungo periodo o al time-lapse una dimensione verticale o di altitudine, come nel caso della presenza di grandi catene montuose, è facile capire che si possa sviluppare un certo tipo di stratificazione sociale. Un determinato complesso culturale, ad esempio la devozione alla setta indú-scivaista, parte dalla costa e viaggia con il potere dello stato e gli scambi commerciali lungo i corsi d’acqua e le pianure coltivabili; chi per una ragione o per l’altra sceglie di non adattarsi a questo complesso, ad esempio, gli animisti, si sposta o viene spinto nei tratti superiori del bacino idrografico, piú nell’interno e fuori portata. Immaginiamo ora che un altro complesso culturale, ad esempio il buddismo o l’islam, prenda il posto del primo: forse con l’aiuto dello stato, questa nuova ondata spinge le popolazioni indú-scivaiste che non si vogliono assimilare piú in alto nel bacino idrografico e queste a loro volta spingono i primi animisti a rifugiarsi ad altitudini ancora piú elevate e/o piú nell’interno. Si capisce facilmente come, in circostanze del genere, il risultato possa essere qualcosa di simile all’altopiano di Tengger descritto prima: una sorta di sedimentazione verticale di ondate culturali arrivate da lontano – le piú antiche (e le piú profonde) ormai situate alle altitudini piú elevate e le piú recenti (le piú superficiali) nelle pianure. Ovviamente, nella realtà gli schemi di migrazione sono molto piú complessi; inoltre, nel XX secolo, i missionari cristiani del Sud-est asiatico continentale sono, per cosí dire, «saltati» direttamente sugli altopiani. Tuttavia, questo schema molto grossolano ci aiuta a capire perché quelli che vivono in luoghi ad alta quota e sperduti, poco accessibili dallo stato, possono anche essere culturalmente distinti e, in un certo senso, storicamente stratificati114.
Mini-Zomie, asciutte e umide.
Ci siamo concentrati sulla grande zona montuosa contigua che abbiamo scelto di chiamare Zomia, ma i principî dell’attrito della distanza, delle regioni di rifugio e delle topografie resistenti allo stato funziono a scala minore anche altrove. Un caso storicamente importante è la catena dei monti Pegu in Birmania, un tratto montuoso coperto di foreste, lungo quattrocento chilometri, largo tra i sessantacinque e duecento chilometri circa, che corre attraverso il cuore della Birmania tra i fiumi Irrawaddy e Sittang.
La catena dei monti Pegu, lo spazio resistente allo stato piú vicino alle ricche pianure, è stata a lungo la roccaforte di fuggiaschi, ribelli e banditi. La sua densa foresta, le sue valli nascoste e soprattutto la sua vicinanza ai floridi villaggi risicoli erano tali, scrive Sir Charles Crosthwaite, che «nessun bandito avrebbe potuto sperare in condizioni migliori»115. Ma la regione divenne una preda molto ambita, perché era sede delle ultime grandi riserve di teak, la merce chiave per generare profitto nella Birmania coloniale dell’inizio del XX secolo. Nonostante le risorse investite per il suo controllo, i monti Pegu sfuggirono dalle mani britanniche: la prima volta durante la seconda guerra anglo-birmana (1885-87), poi ancora nel corso della grande rivolta di Saya San (1930-32) e infine, definitivamente, allo scoppio della Seconda guerra mondiale. Dopo la guerra e per circa trent’anni, fino al 1975, il Nord dei monti Pegu è stato la base principale dei ribelli comunisti e il Sud quella dei ribelli karen, che quasi rovesciarono il governo di Rangoon. Questa roccaforte di ribelli era cosí sicura che il Partito comunista della Birmania (Pcb) la considerava il proprio Yan′ana e chiamò la Scuola centrale del marxismo-leninismo situata sulle sue montagne «La città d’oro di Pechino»116. Quando infine la catena montuosa fu ripulita dai ribelli, nel 1975, sia il Pcb che il Partito nazionale karen (Knup) persero la loro ultima base a un passo dalla pianura centrale e dal governo del paese. Anche se scarsamente popolati, i monti Pegu meritano un capitolo a sé in tutti i resoconti degli spazi resistenti allo stato della Birmania117.
Il monte Popa, all’estremità settentrionale dei monti Pegu, oggi sede di un importante santuario buddista e meta di pellegrinaggio, fino a tempi abbastanza recenti è stato un famoso spazio di resistenza allo stato. Situato a sud-ovest di Mandalay, tra Meiktila e Chauk, questa cima scoscesa alta millecinquecento metri è circondata da speroni rocciosi, macchie di giungla e burroni. Anche se non è abbastanza estesa per costituire un’importante zona di rifugio o una base per i rivoluzionari, è abbastanza vicina alle rotte commerciali e alle popolazioni di valle per offrire riparo alle bande di fuorilegge e ladri di bestiame. Una di queste bande resistette per dieci anni dopo l’annessione britannica118. Il monte Popa è solo una delle centinaia di quelle che i britannici chiamavano roccaforti, luoghi difficili da conquistare e da tenere in possesso. Potevano ospitare pretendenti al trono, sette eterodosse della foresta, ribelli e banditi. Ogni luogo aveva la propria storia di resistenza allo stato e chi, per qualunque motivo, voleva allontanarsi dallo stato sapeva che vi poteva trovare rifugio. Tutti questi luoghi avevano in comune un territorio impervio che favoriva la difesa e la ritirata, e una popolazione dispersa e mobile con una tradizione di assenza di stato.

Mappa 7. Altitudini nella catena dei monti Pegu – altitudine in metri.
Un resoconto completo dei luoghi di resistenza allo stato dovrebbe avere tante pagine dedicate ai luoghi umidi in pianura – paludi, terre umide, torbiere, pantani, brughiere, delta, coste colonizzate dalle mangrovie e complesse vie d’acqua e arcipelaghi – quante ne ha per le roccaforti sulle montagne. Siccome questi luoghi recalcitranti al governo in genere erano situati vicino a ricche aree risicole a basse altitudini, costituivano una minaccia anche maggiore all’ordine politico di pianura. All’inizio del XVII secolo, lo Jiaxing, a sud del delta del Fiume Azzurro, era uno di questi luoghi turbolenti. Il labirinto di vie d’acqua grandi e piccole poneva problemi di ordine politico pressocché insormontabili. Un prefetto incaricato del suo controllo scrisse: «I corsi d’acqua piú grandi sono separati da laghi, paludi, insenature e golene che formano una grande distesa di innumerevoli chilometri. Sono i rifugi dove i banditi di ogni luogo si ritrovano, da cui emergono e in cui scompaiono»119.
Proprio come le terre umide possono costituire un naturale perimetro difensivo per il centro dello stato, come era per Venezia e Amsterdam, allo stesso modo possono costituire il rifugio di ribelli, banditi e dei loro equivalenti sull’acqua, i pirati. Il grande classico cinese del XIII secolo [secondo Wikipedia è del XV secolo] I Briganti è il racconto picaresco delle gesta di ufficiali in disgrazia o traditi e del loro grande seguito di fuorilegge nelle paludi120. Una vasta palude con una storia leggendaria ancora piú lunga (tremila anni o piú) sono le terre umide della Mesopotamia tra il Tigri e l’Eufrate (oggi sul confine tra Iran e Iraq). Questa distesa di quindicimila chilometri quadrati, che cambia forma di stagione in stagione, fino a tempi recenti ospitava una grande popolazione che viveva su isole galleggianti, ben lontana dalla presenza dello stato. Wilfred Thesiger, un avventuriero il cui racconto Quando gli arabi vivevano sull’acqua fece conoscere per la prima volta questo mondo al pubblico anglosassone, osservava che le paludi, «con il loro sconcertante labirinto di canneti dove gli uomini si possono muovere solo in barca, deve essere stato il rifugio dei superstiti di un popolo sconfitto e un centro di illegalità e anarchia sin dai tempi piú remoti»121. La combinazione di un labirinto di vie d’acqua indistinguibili (agli occhi non allenati di un forestiero!) soggette a cambiamenti stagionali dava ai suoi mobili abitanti un vantaggio decisivo su tutti gli ufficiali che volevano introdursi nella zona. Il rimedio draconiano, in questo come in altri casi di zone di resistenza paludose, era di bonificarle e distruggere l’habitat una volta per tutte. Alla fine, questo grande progetto di estensione dello spazio statale fu portato a termine da Saddam Hussein dopo le massicce perdite subite nella stessa zona nel corso della guerra Iran-Iraq. La bonifica di grandi estensioni di paludi e terre umide, una soluzione finale non disponibile ai sovrani che avevano a che fare con zone di rifugio montuose, è sempre stata, qualunque fossero le sue altre ragioni, un esercizio di cancellazione di potenziali siti di resistenza e ribellione122.
Nel Nordamerica dominato dai coloni bianchi, le zone umide davano riparo a ribelli e fuggitivi come facevano le montagne e la frontiera. I seminole, guidati dal capo Osceola, insieme agli schiavi fuggitivi loro alleati, combatterono una guerriglia durata sette anni contro le truppe federali, decise ad applicare la politica di deportazione degli Indiani promossa da Andrew Jackson123. La Great Dismal Swamp al confine tra Virginia orientale e North Carolina diede rifugio a migliaia di schiavi fuggitivi per molte generazioni, «proprio nel mezzo delle comunità piú schiaviste del Sud»124. Agli schiavi si unirono bianchi rinnegati, gente del Sud che scappava dal reclutamento, disertori, fuorilegge, distillatori di contrabbando, cacciatori e cacciatori di pelliccie. Anche la «Great Dismal», come le paludi di Quando gli arabi vivevano sull’acqua è presente nella letteratura grazie alla poesia di Longfellow A Slave in the Dismal Swamp (Lo Schiavo nell’atra maremma) e al libro di Harriet Beecher Stowe Dred: A Tale of the Dismal Swamp (1856, Racconto della Grande e Tetra Palude). Come per la zona di rifugio degli arabi delle paludi, ci furono ripetuti appelli per bonificare la Great Dismal perché permetteva alla gente «di infimo genere» di trovare libertà e indipendenza125.
Anche gli ambienti costieri, specialmente nel Sud-est asiatico, hanno fornito copertura ai ribelli e a chi voleva sfuggire allo stato. Era quasi impossibile controllare e amministrare le regioni di delta dei fiumi principali del Sud-est asiatico continentale (Mekong, Chao Phraya e Irrawaddy), mutevoli e frastagliate da un numero infinito di estuari e canali di marea. Anche con molte forze a disposizione, le autorità non potevano competere con una popolazione sfuggente che conosceva alla perfezione il suo territorio acquitrinoso ed era in grado di sparire nel giro di un minuto. Preoccupati dalle situazioni ambientali che potevano favorire i rivoluzionari, sia i francesi sia il governo di Saigon sostenuto dagli Stati Uniti individuarono in particolare montagne e terre umide come posti da sorvegliare. «Gli Altopiani centrali e le pianure acquitrinose del delta occidentale del Mekong [il Transbassac] erano due importanti regioni strategiche segnalate come vulnerabili all’infiltrazione comunista»126. Anche i ribelli karen che combattevano contro il governo birmano approfittarono pienamente dell’«impenetrabile regione di grandi paludi di mangrovie, foreste, fiumi fangosi e insenature nascoste dove le forze del governo erano costrette a muoversi lentamente»127.
Con i suoi passaggi incredibilmente tortuosi, ardui per chiunque non abbia una lunga esperienza, l’habitat delle mangrovie forse rappresenta l’ambiente ideale in cui fuggire e offre copertura protettiva senza pari. «Canali tortuosi e insenature, ostruiti dal fango e da banchi di sabbia, spariscono dalla vista nascosti dietro a un muro di vegetazione; nel labirinto delle mangrovie gli stretti passaggi sono coperti dai rami o dalle lunghe fronde delle nipah [palme]. Qui la gente del posto, che sa muoversi sull’acqua e conosce bene questa intricata geografia, quando avverte un pericolo riesce a non farsi scoprire»128.
Un ambiente ideale in cui fuggire e nascondersi, proprio per le sue caratteristiche attirava i razziatori. Le mangrovie erano vicine alle rotte commerciali proprio come i monti Pegu erano vicini alle ricche pianure. I razziatori potevano venir fuori dal nulla, saccheggiare navi, razziare insediamenti costieri, catturare schiavi e dileguarsi. Come i vichinghi, gli zingari del mare avevano una duplice esistenza di commercianti e predoni e, come i vichinghi, usavano imbarcazioni veloci, a pescaggio ridotto, i perahu, con cui potevano scappare lungo piccoli corsi d’acqua, dove barche piú grandi non riuscivano ad addentrarsi, e con cui di notte facevano incursioni nei villaggi arrivando dalla parte a monte del bacino, spesso non protetta. Grazie all’uso dell’ambiente delle mangrovie a proprio vantaggio, per un periodo hanno rappresentato un’importante minaccia per il commercio marittimo britannico e olandese nel Sud-est asiatico. I loro discendenti diretti, motorizzati e pesantemente armati, tormentano ancora oggi le grandi petroliere che solcano lo stretto di Malacca129.
Come le montagne, le zone umide, le paludi e le mangrovie sono luoghi di fuga e potenziali basi da cui partire per fare razzie; ma soprattutto sono posti a bassa incidenza dello stato, dove possono trovare rifugio le popolazioni che per qualunque motivo vogliono sfuggire all’autorità dello stato.
Andare dai barbari.
Sappiamo che parte del confine cinese iniziò a seguire la stessa linea di evoluzione divergente [nomadismo pastorale] e che la Grande Muraglia fu costruita tanto per trattenere i Cinesi in Cina, quanto per tenere fuori dalla Cina i nuovi barbari.
OWEN LATTIMORE, «The Frontier in History».
I racconti antichi e le storie popolari di pianura che parlano delle minoranze e della loro origine, in genere le considerano popoli indigeni da cui discendono le popolazioni di valle. Oggi gli storici e gli etnografi delle minoranze che vivono a Zomia spesso le descrivono come migranti con una storia di sconfitte, persecuzioni e marginalizzazione e quindi come le vittime di un’ingiusta serie di atti ostili. Questa tesi si basa su due ipotesi implicite. La prima è che tutti i popoli delle alture preferirebbero fare i coltivatori in pianura, che molti di loro erano popoli di valle e che siano stati spinti sulle alture contro il loro volere e in virtú di una forza maggiore. La seconda ipotesi è che naturalmente vorrebbero evitare lo stigma della «barbarie» e dell’arretratezza a cui sono associati – vale a dire, che la conseguenza logica della loro fuga sia l’essere barbari. Dato che, per gli standard della pianura, le persone civilizzate sono sudditi di uno stato, coltivano riso irriguo e pagano le tasse, l’abbandono di questa condizione, l’uscita dall’orbita dello stato e l’adozione di nuove routine di sussistenza vuol dire, ipso facto, uscire dalla civiltà.
Ma se ci si ferma qui, si rischia di trascurare l’importante aspetto dell’intenzionalità di queste migrazioni – il loro agire in modo deliberato. Dove esiste una terra di frontiera aperta e commercio con gli insediamenti di pianura, gli abitanti delle alture possono godere di una vita relativamente prosperosa con meno fatica, ed evitare le tasse e il lavoro di corvée. Lattimore osserva che molti pastori delle frontiere settentrionali e occidentali della Cina erano coltivatori di varia provenienza «che decisero di abbandonare un’attività agricola poverissima per una vita piú sicura come pastori»: allo stesso modo, passare alla vita di coltivatori itineranti e raccoglitori nei territori montuosi spesso era una scelta in termini di interesse personale strettamente economico130. E se a questo interesse personale aggiungiamo il vantaggio di tenere per sé una parte piú consistente del proprio raccolto e di poter disporre dei prodotti del proprio lavoro, le ragioni per staccarsi dal potere dello stato appaiono convincenti anche solo dal punto di vista materiale.
Per chi stava a valle il passaggio alla vita sulle alture era sempre associato con una diminuzione di status, quindi era inconcepibile che potesse essere frutto di un atto volontario. Per i valligiani, le popolazioni delle alture erano aborigeni che non erano mai stati civilizzati o, con piú benevolenza, una popolazione cacciata con la forza dalla pianura. Consapevoli del disprezzo con cui venivano considerati, molti popoli tribali nelle loro tradizioni orali spiegano la loro collocazione e il loro status attuali con una combinazione di vittimizzazione, tradimento e negligenza. In ogni caso, è molto chiaro che tutti i gruppi delle alture abbiano incorporato un gran numero di «disertori» dalla civiltà e li abbiano inseriti nelle loro genealogie. Tra questi moltissimi erano cinesi han che trovarono conveniente lasciare la civiltà per andare sulle alture. Come abbiamo visto, narrazioni alternative di questo genere non trovavano posto nell’autorappresentazione della politica di governo han-confuciana. Perciò, la Grande Muraglia (o meglio, Grandi Muraglie) e le mura anti-miao di Hunan erano considerate ufficialmente barriere contro i barbari, mentre in effetti erano state costruite altrettanto sicuramente per trattenere nell’ambito del potere statale la popolazione stanziale di coltivatori e contribuenti fiscali. Come dimostra Magnus Fiskesjö, «molti immaginati barbari del passato e molti cosiddetti ribelli miao, [della metà del XIX secolo] in realtà erano cinesi delle etnie di maggioranza, in fuga dagli obblighi fiscali o da responsabilità penali»131. Commercio, ricerca di terre e matrimonio erano altre ragioni che potevano spingere gli han e altri migranti a entrare nella società delle alture. L’auto marginalizzazione o, nei termini di valle, l’«auto imbarbarimento», a volte poteva essere un fenomeno abbastanza comune, ma per il discorso sulla civilizzazione questa condotta era impensabile132.
Se è vero che diversi gruppi scelsero di non essere assimilati alla cultura e ai costumi dello stato di valle e che invece scelsero deliberatamente di collocarsi in una posizione fisicamente e culturalmente distante dalla civiltà, allora dobbiamo trovare la maniera di descrivere questo processo come qualcosa di piú di una perdita o di una caduta in disgrazia. Geoffrey Benjamin, nel cercare di cogliere il modo in cui i popoli delle alture della Malesia peninsulare si posizionavano – ecologicamente, economicamente e culturalmente – rispetto allo stato malese, ha coniato il termine «dissimilazione»133. La dissimilazione – da non confondersi con dissimulazione – è la creazione piú o meno intenzionale di una distanza culturale tra società. Può comportare l’adozione e il mantenimento di differenze linguistiche, di storie distintive, di differenze nei modi di vestire, riti di sepoltura e matrimonio, stile delle case, forme di coltivazione e altitudine. E dato che tutti questi marcatori culturali sono intesi a distinguere un gruppo dagli altri, sono necessariamente relazionali. La dissimilazione può anche essere la rivendicazione di un diritto su una particolare nicchia nell’economia complessiva alture/valle – ad esempio: «Noi siamo raccoglitori nella foresta; noi non tocchiamo l’aratro». Ovviamente, la dissimilazione perseguita ed elaborata nel corso del tempo conduce all’etnogenesi, un tema che esploreremo nel capitolo VII.
Nel contesto della storia della migrazione lontano dai centri statali, in questa sezione finale vogliamo sottolineare l’aspetto piú importante della dissimilazione per i popoli delle alture. L’atto fondamentale della dissimilazione è l’affermazione: «Siamo un popolo non statale. Siamo raccoglitori e coltivatori itineranti nelle alture perché ci siamo collocati a distanza dallo stato di valle».
Autonomia come identità: popoli che sfuggono lo stato.
Per molti popoli delle alture, la dissimilazione, rivendicare la differenza tra una società e l’altra significava mettere una distanza fisica tra se stessi e gli stati di pianura. In un certo senso, il processo era sovradeterminato, persino tautologico. Consideriamo, ad esempio, un lungo processo di migrazione: un popolo di pianura, inferiore militarmente o numericamente, si trova di fronte la prospettiva della sconfitta e sottomissione o, piú probabilmente, di entrambe le cose; una frazione di questo gruppo assediato resta dov’è, viene sottomessa e, col tempo, assimilata; un’altra frazione invece si ritira e si sposta all’interno o sulle alture per mantenere la propria autonomia anche se forse deve cambiare le proprie routine di sussistenza; ipotizziamo infine che il gruppo abbia un nome: chiamiamolo le Allodole. Le allodole che restano saranno assimilate nella cultura di pianura dominante e lasceranno su questa il loro segno distintivo; ma non saranno piú «allodole», diventeranno «cinesi», «birmani», «siamesi», «tai». Quelle che se ne vanno in numero consistente, anche se cambieranno comunque (forse anche di piú!), continueranno a essere conosciute come allodole e, inoltre, un aspetto molto importante della loro storia sarà la migrazione dallo stato di valle. Dal punto di vista della valle, le «allodole» saranno segnate dalla fuga e dall’evasione dallo stato. Se il processo si ripete diverse volte, l’aspetto della fuga dallo stato può arrivare a rappresentare la caratteristica essenziale di un popolo.
Schematicamente il processo è quello che diversi etnografi e storici considerano l’esperienza tipica dei miao/hmong, soprattutto nel corso degli ultimi tre secoli di ribellione e di fuga. Nicholas Tapp descrive il processo di biforcazione: da una parte, ci sono i miao «cotti» (shu) o «miao-cinesi», che hanno accettato la sovranità cinese, i nomi cinesi e l’agricoltura stanziale e che nel tempo sono stati assorbiti nella cultura han; dall’altra parte ci sono i miao «crudi» (sheng), o «miao-miao», che si sono spostati (o restati) in alto sulle alture a fare i coltivatori itineranti e i razziatori, lontani dallo stato cinese134. Un altro studioso della storia miao/hmong crede che «quando i hmong soffrivano di scarsità di terreni, mancanza di foresta, eccessivo o ingiusto prelievo fiscale ed erano vittime di abusi da parte degli ufficiali o dei proprietari terrieri, la maggioranza provava ad adattarsi alla nuova situazione, altri si ribellavano, pronti a combattere, mentre altri ancora sceglievano di spostarsi in un’altra zona amministrativa o in un altro paese. Queste migrazioni interessavano solo una parte della popolazione hmong, perché la vasta maggioranza sceglieva di restare e adattarsi»135. In questo schema, i hmong fuggitivi e senza stato, segnati indelebilmente dalla fuga e dal rifiuto di «entrare nella mappa», sono una popolazione residuale, mentre gran parte di coloro che storicamente erano conosciuti come hmong sarebbero stati assorbiti come sudditi dello stato han e quindi scomparsi come gruppo distinguibile. Se teniamo conto del fatto che potrebbero essersi ribellati e fuggiti con loro, e in seguito assimilati, anche altri gruppi, questo residuo rappresenta poco in termini di continuità genealogica, e a maggior ragione di continuità genetica. La continuità – il significato – di essere hmong potrebbe stare piú nella storia condivisa di ribellione e fuga che nella rivendicazione di presunti legami di sangue ancestrali.
Una storia di questo genere si può applicare a moltissimi popoli delle montagne di Zomia (ma non a tutti). Wa, akha, lahu, lisu, khamu, palaung, padaung, lamet e qualche karen sembrano condividere una storia in cui, spesso dopo una ribellione, qualcuno rimaneva indietro mentre altri fuggivano assimilando, lungo la strada, altri migranti. Shanshan Du crede che negli ultimi tre secoli i lahu siano stati coinvolti in circa venti rivolte, dopo le quali molti «rimasero in zone sotto il controllo imperiale mentre altri migrarono a sud in regioni piú marginali e montuose dopo grandi repressioni»136. La complessa storia dei karen, soprattutto dei karen pwo, ha molti elementi simili: alleati con i mon e, dopo la caduta di Pegu a metà del XVIII secolo, con i siamesi, i karen in molti casi sembrano essere stati assimilati dai regimi mon, siamese e birmano. Molti di coloro oggi conosciuti come karen sono quelli che scelsero di scappare o di restare sulle alture come popolo autonomo e senza stato, anche se vulnerabile137. Da un punto di vista storico, la gran parte di coloro che erano karen, lahu e hmong è stata assimilata nell’insieme composito della pianura come sudditi dello stato, mentre il loro residuo in fuga ha mantenuto la propria identità distintiva, elaborando cosí una storia di fuga e di vita fuori dallo stato138.
Il caso studiato piú a fondo di ciò che si potrebbe chiamare «fuga dallo stato come identità» è quello degli akha, descritto nel lavoro del compianto Leo Alting von Geusau. Forti di circa due milioni e mezzo di individui, compresi gli hani (ha nhi) del Vietnam del Nord, gli akha parlano una lingua tibetano-birmana e in passato erano considerati appartenere agli yi-lolo «di basso rango» («crudi», sheng) non cinesizzati. Oggi si trovano nello Yunnan meridionale (Sip Song Phan Na) e nelle zone adiacenti di Laos, Birmania e Thailandia. Negli ultimi due secoli sono stati spinti a sud da guerre e schiavitú e dalla ricerca di nuove terre per la coltivazione itinerante; avevano contatti con i regni di pianura han e tai, anche se gli han hanno lasciato una traccia piú profonda nelle loro credenze e pratiche culturali.
Per i nostri scopi la cosa piú importante è che gli akha mantengono elaborate (per quanto inaffidabili) genealogie e raccontano la propria storia tramite i bardi o phima. Una parte sembra si possa documentare ma, in ogni caso, la loro storia orale è indicativa di un popolo per cui la fuga e l’essere fuori dallo stato sono caratteristiche distintive. Credono di essere stati in origine un popolo delle alture che gradualmente si è spostato in pianura a coltivare riso, ma non come suddito di uno stato. In seguito, arrivarono gruppi di guerrieri tai nello Yunnan meridionale, gestirono il potere come uno stato, assimilarono alcuni akha e ne spinsero altri sulle alture, insieme con i palaung e altre etnie. Von Geusau sostiene che questo è coerente con l’istituzione della prima città-stato (muang) da parte del guerriero tai-lue Ba Zhen alla fine del XII secolo, che espulse molti dei precedenti abitanti. A ciò seguirono le invasioni mongole, la dinastia Yuan a metà del XIII secolo e l’espansione del potere statale nella regione. Da allora in avanti, gli akha si considerano un popolo che vuole stare fuori dallo stato, sceglie la propria localizzazione e il proprio sistema di vita in modo da «non farsi trovare facilmente da soldati, banditi ed esattori fiscali»139. Nonostante la fuga, non hanno subito un isolamento genetico: secondo Von Geusau, grazie all’uso di regole flessibili di adozione e a genealogie creative, hanno assorbito cinesi han e tai, cosí come altri popoli delle montagne quali i lahu, i palaung, i khamu e i wa.
La fuga e il rifiuto dello stato sono i due tratti principali della storia e della cosmologia degli akha. Una figura chiave delle loro leggende è l’aspirante re degli akha del XIII secolo, Dzjawbang, che istituí un censimento (la mossa iconica della creazione dello stato e delle tasse!) e fu massacrato dal suo stesso popolo. Suo figlio, Bang Dzjui, è un Icaro che morí perché il suo cavallo sciamanico con le ali riparate con la cera volò troppo vicino al sole. Entrambe le storie sono racconti che mettono in guardia dalla gerarchia e dalla formazione dello stato. I normali rituali sciamanici di cura intesi a riportare un’anima vagante al proprio corpo contengono la stessa morale di evasione dallo stato: «Il viaggio verso questo mondo [di spirito] con nove livelli è descritto come una discesa dalle montagne alle pianure, dove l’anima della persona è stata catturata nel “labirinto del drago” e condannata a fare lavoro di corvée o a lavorare come schiavo per tutta la vita. Per guarire l’anima di una persona, devono offrire un maiale o un altro grande animale, come un bufalo […] esattamente come nel commercio degli schiavi»140. Lo stesso principio vale per quello che si potrebbe chiamare ambito religioso: oltre al rispetto per gli specialisti, per chi ha lunghe genealogie e per i maniscalchi, gli akha sostengono di non credere in nessun dio e che, letteralmente, non chinano il capo di fronte a nessuno. È difficile immaginare un popolo la cui storia orale, le cui pratiche e la cui cosmologia rappresentino un rifiuto piú totale degli stati e delle gerarchie permanenti.
a. Punto di arrivo della Lunga Marcia e centro principale del Partito comunista cinese tra il 1935 e il 1948 [N.d.T.].