SHABBAT
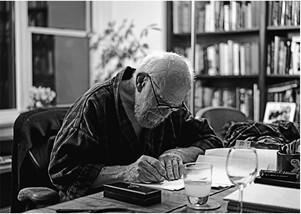
Mia madre – insieme ai suoi fratelli e alle sue sorelle, diciassette fra tutti – ricevette un’educazione ortodossa: le fotografie di suo padre lo ritraggono sempre mentre indossa uno yarmulke,4 e mi raccontarono che se di notte gli cadeva, lui si svegliava. Anche mio padre veniva da un ambiente ortodosso. Entrambi i miei genitori erano ben consapevoli del quarto comandamento («Ricordati del giorno di sabato per santificarlo»), e lo Shabbat (lo Shabbos, come lo chiamavamo noi, nel nostro yiddish lituano) era completamente diverso dagli altri giorni della settimana. Non ci era permesso svolgere alcun lavoro, guidare l’auto o usare il telefono; era proibito accendere una luce o una stufa. Essendo medici, i miei genitori facevano qualche eccezione, giacché non potevano staccare il telefono o evitare del tutto di usare l’auto: dovevano essere disponibili, se necessario, per visitare i pazienti, effettuare interventi chirurgici o far nascere i bambini.
Abitavamo in una comunità ebraica relativamente ortodossa a Cricklewood, nella parte nordoccidentale di Londra: il macellaio, il fornaio, il droghiere, il fruttivendolo e il pescivendolo chiudevano tutti bottega in tempo per lo Shabbat, e non riaprivano fino alla domenica mattina. Tutti loro, e tutti i nostri vicini – così immaginavamo –, stavano celebrando il sabato proprio come noi.
Il venerdì, intorno a mezzogiorno, mia madre deponeva l’identità e le vesti di chirurga e si dedicava alla preparazione del gefilte fish5 e di altre prelibatezze per lo Shabbos. Subito prima che arrivasse la sera, accendeva le candele rituali proteggendone la fiamma con le mani a coppa e mormorando una preghiera. Tutti noi indossavamo i nostri abiti del sabato freschi e puliti, e ci riunivamo per il pasto serale, il primo dello Shabbat. Mio padre sollevava il suo calice d’argento con il vino e intonava le benedizioni e il Kiddush;6 poi guidava tutti noi nel canto delle preghiere di ringraziamento.
Ogni sabato mattina, i miei tre fratelli e io seguivamo i nostri genitori nella sinagoga di Cricklewood su Walm Lane, un grande tempio costruito negli anni Trenta per accogliere parte dell’esodo di ebrei che ebbe luogo in quel periodo dall’East End a Cricklewood. Durante la mia infanzia, la sinagoga era sempre piena, e tutti noi avevamo i nostri posti assegnati, gli uomini in basso e le donne – mia madre, le varie zie e cugine – di sopra; a volte, quando ero piccolo, le salutavo con la mano durante il servizio. Benché non capissi la lingua ebraica del libro di preghiere, mi piaceva ascoltarne il suono e soprattutto sentire cantare le antiche preghiere medioevali sotto la guida del nostro hazan,7 uomo di straordinario talento musicale.
Dopo il servizio, ci ritrovavamo tutti e ci mescolavamo fuori dalla sinagoga, e poi di solito andavamo a piedi a casa di mia zia Florrie e dei suoi tre figli per recitare un Kiddush, accompagnato da vino rosso dolce e torta al miele, quel tanto che bastava a stimolare l’appetito. Dopo un pranzo freddo consumato a casa, a base di gefilte fish, salmone cotto in camicia e gelatina di barbabietola, il sabato pomeriggio – sempre che non fosse interrotto da chiamate d’emergenza per i miei genitori – era dedicato alle visite di famiglia. Zii, zie, cugini e cugine venivano a trovarci per il tè, oppure ci recavamo noi da loro; abitavamo tutti abbastanza vicino da poter andare a piedi.
La seconda guerra mondiale decimò la comunità ebraica di Cricklewood, e in tutta l’Inghilterra negli anni dopo il conflitto la comunità ebraica nel suo complesso perse migliaia di membri. Molti ebrei, compresi alcuni miei cugini, emigrarono in Israele; altri andarono in Australia, in Canada o negli Stati Uniti; Marcus, il mio fratello maggiore, si trasferì in Australia nel 1950. Molti di coloro che rimasero andarono incontro a un processo di assimilazione e adottarono forme di giudaismo diluite e attenuate. La nostra sinagoga, gremita ai tempi della mia infanzia, si svuotò ogni anno di più.
Nel 1946, in una sinagoga relativamente piena e in presenza di diverse decine di miei parenti, cantai la parte che mi competeva nel mio bar mitzvah,8 ma quella cerimonia segnò per me la fine dell’osservanza formale della religione ebraica. In seguito non rispettai i doveri rituali di un ebreo adulto – pregare ogni giorno, indossare i tefillin9 prima della preghiera ogni mattina – e a poco a poco divenni sempre più indifferente alle credenze e alle consuetudini dei miei genitori, anche se, prima dei miei diciotto anni, non vi fu un particolare punto di rottura. Fu solo allora infatti che mio padre, indagando sui miei sentimenti concernenti la sessualità, mi costrinse ad ammettere che mi piacevano i ragazzi.
«Non ho mai fatto niente,» dissi «è solo una sensazione – ma non dirlo a mamma, non lo sopporterebbe».
Invece mio padre glielo disse, e il mattino dopo lei scese con un’espressione di orrore dipinta in volto e mi gridò: «Sei abominevole. Vorrei che non fossi mai nato». (Senza dubbio stava pensando alle parole del Levitico: «Se uno ha relazioni carnali con un uomo come si hanno con una donna, ambedue hanno commesso cosa abominevole; saranno certamente messi a morte; il loro sangue ricadrà su di loro»).
La questione non fu mai più sollevata, ma le sue parole durissime mi fecero odiare la capacità della religione d’essere intollerante e crudele.
Dopo la laurea, nel 1960, mi allontanai bruscamente dall’Inghilterra, dalla mia famiglia e dal mio ambiente, e me ne andai nel Nuovo Mondo, dove non conoscevo nessuno. Quando mi trasferii a Los Angeles, trovai una sorta di comunità tra i sollevatori di pesi di Muscle Beach, e anche all’UCLA tra i miei compagni di internato in neurologia; io però, nella mia vita, bramavo legami più profondi – un «significato» – e fu proprio la loro assenza, credo, ad attirarmi negli anni Sessanta in una dipendenza quasi suicida dalle anfetamine.
Cominciai lentamente a riprendermi quando trovai un lavoro davvero importante in un ospedale per lungodegenti nel Bronx, a New York (il Mount Carmel di cui scrissi in Risvegli). Là rimasi affascinato dai miei pazienti, sviluppai per loro un interesse profondo e sentii che raccontare le loro storie – storie di situazioni pressoché sconosciute e quasi inimmaginabili per il grande pubblico, ma in effetti anche per molti medici – era una sorta di missione. Avevo scoperto la mia vocazione, e la seguii tenacemente, con determinazione, ricevendo ben pochi incoraggiamenti da parte dei miei colleghi. Quasi senza esserne consapevole, divenni un narratore di storie proprio in un momento in cui, in medicina, la narrazione s’era quasi estinta. Questo non mi dissuase, perché sentivo che le mie radici affondavano nella tradizione delle magnifiche descrizioni di casi clinici neurologici dell’Ottocento (fui spronato, in questo, dal grande neuropsicologo russo A.R. Lurija). Quella che avrei condotto per molti anni fu un’esistenza solitaria, quasi monacale, ma profondamente gratificante.
Negli anni Novanta feci la conoscenza di Robert John Aumann, mio cugino e coetaneo, uomo dall’aspetto notevole, dalla corporatura robusta e atletica, con una lunga barba bianca che lo faceva sembrare un vecchio saggio anche a soli sessant’anni. Dotato di un intelletto potente, ma anche di un grandissimo calore umano e di tenerezza, Robert John è capace di un impegno religioso profondo: «impegno», in effetti, è una delle sue parole preferite. Benché nel suo lavoro rappresenti la razionalità nel campo dell’economia e nelle interazioni umane, per lui non vi è conflitto tra fede e ragione.
Insistette affinché mettessi una mezuzah10 sulla mia porta, e me ne prese una in Israele. «Lo so che non sei credente,» mi disse «ma comunque dovresti averne una». Non protestai.
In un’interessante intervista del 2004 Robert John parlò del lavoro della sua vita nel campo della matematica e della teoria dei giochi, ma anche della sua famiglia – di come andasse a sciare e a fare escursioni in montagna con una trentina di figli e nipoti al seguito (si facevano accompagnare da un cuoco kosher, che si portava dietro le pentole) – e di quanto fosse importante, per lui, lo Shabbat.
«L’osservanza dello Shabbat è qualcosa di estrema bellezza» disse «ed è impossibile se non si è religiosi. Non è questione di migliorare la società – si tratta di migliorare la qualità della propria vita».
Nel dicembre del 2005 Robert John ricevette il premio Nobel per i suoi cinquant’anni di fondamentali ricerche in economia. Per la commissione del Nobel non fu esattamente un ospite facile: andò a Stoccolma con la sua famiglia, compresi molti di quei figli e di quei nipoti i quali dovevano tutti avere piatti, utensili e cibi kosher appositi, e abiti da cerimonia particolari in cui non vi fosse alcuna commistione, vietata dalla Bibbia, di fibre di lana e lino.
Quello stesso mese mi diagnosticarono un cancro a un occhio e il mese dopo, mentre ero in ospedale per le cure, Robert John venne a trovarmi. Mi raccontò moltissime storie divertenti sul premio Nobel e sulla cerimonia, ma tenne a sottolineare che, se fosse stato obbligato ad andare a Stoccolma di sabato, avrebbe rifiutato di ritirarlo. Il suo impegno nei confronti dello Shabbat, la sua completa serenità e il suo totale distacco dagli interessi mondani avrebbero avuto la meglio perfino su un Nobel.
Nel 1955, a ventidue anni, andai in Israele per diversi mesi in un kibbutz; benché l’esperienza mi fosse piaciuta, decisi che non ci sarei tornato. Anche se moltissimi miei cugini si erano trasferiti laggiù, la politica del Medio Oriente mi disturbava, e sospettavo che sarei stato fuori posto in una società profondamente religiosa. Nella primavera del 2014, però, venni a sapere che mia cugina Marjorie – pure lei medico, era stata una protégée di mia madre e aveva lavorato fino a novantotto anni – era in punto di morte; così le telefonai a Gerusalemme per dirle addio. Con una voce sorprendentemente forte e chiara, e un accento molto simile a quello di mia madre, mi disse: «Non ho nessuna intenzione di morire adesso; il 18 giugno festeggerò il mio centesimo compleanno. Ci sarai?».
«Ma certo!» le risposi. Quando riattaccai, mi resi conto che in pochi secondi avevo ribaltato una decisione a cui mi ero attenuto per quasi sessant’anni.
Fu una visita esclusivamente familiare. Festeggiai il centesimo compleanno di Marjorie insieme a lei e alla sua famiglia estesa. Vidi altri due cugini che mi erano stati cari ai tempi di Londra – e poi un numero incalcolabile di secondi cugini, di parenti più lontani e, naturalmente, Robert John. Mi sentii accolto dalla mia famiglia in un modo che non provavo più dai tempi dell’infanzia.
Avevo avuto qualche timore nel far visita alla mia famiglia ortodossa insieme al mio compagno Billy (le parole di mia madre mi riecheggiavano ancora nella mente); ma anche lui fu accolto con gran calore. Come gli atteggiamenti fossero cambiati in modo profondo perfino tra gli ortodossi apparve chiaro quando Robert John invitò Billy e me a unirci a lui e alla sua famiglia per il pasto di apertura dello Shabbat.
La pace dello Shabbat, di un mondo che si ferma, di un tempo fuori dal tempo, era palpabile, pervadeva ogni cosa, e mi ritrovai impregnato di un umore meditabondo, qualcosa di simile alla nostalgia, mentre mi chiedevo come sarebbe stato se... come sarebbe stato se A e B e C fossero andati in modo diverso? Che tipo di persona avrei potuto essere? Che genere di vita avrei potuto vivere?
Nel dicembre del 2014 completai la mia autobiografia, In movimento, e consegnai il manoscritto all’editore non immaginando proprio che qualche giorno dopo avrei saputo di avere un cancro metastatico, originatosi dal melanoma oculare di nove anni prima. Sono felice di essere riuscito a finire la mia autobiografia senza saperlo e di aver potuto, per la prima volta in vita mia, dichiarare la mia sessualità in modo sincero e privo di reticenze, affrontando il mondo apertamente senza conservare più – chiusi dentro di me – segreti gravati da sensi di colpa.
A febbraio capii di dover essere altrettanto aperto anche a proposito del mio cancro, e del confronto con la morte. Quando il saggio La mia vita fu pubblicato sul «New York Times», ero in ospedale; e a luglio scrissi un altro pezzo, La mia tavola periodica, in cui il cosmo fisico e gli elementi chimici che ho amato prendevano una vita propria.
Adesso – debole, con il fiato corto, con i muscoli un tempo sodi consumati dal cancro – scopro che i miei pensieri, invece di fissarsi sul soprannaturale o sullo spirituale, si appuntano sempre più spesso su che cosa si intenda quando si parla di vivere una vita buona e degna, di raggiungere la pace dentro di sé. Scopro che i miei pensieri vanno allo Shabbat, il giorno del riposo, il settimo giorno della settimana e forse anche della propria vita, quando uno sente d’aver fatto la sua parte e può, in coscienza, abbandonarsi al riposo.
4. Termine yiddish per indicare la kippah, il copricapo prescritto a tutti gli ebrei maschi nei luoghi sacri, ma indossato dai più religiosi costantemente.
5. Piatto tipico della cucina ashkenazita, dalla lunga preparazione, che consiste in un polpettone di pesci diversi con vari altri ingredienti.
6. Rituale di santificazione del sabato che consiste nel recitare una benedizione sul vino.
7. Hazan o chazan è il cantore che guida la preghiera.
8. Cerimonia che segna il raggiungimento dell’età a partire dalla quale un individuo è considerato responsabile delle proprie azioni; si celebra nel primo sabato successivo al compimento del tredicesimo anno.
9. I filatteri, piccoli astucci di cuoio contenenti quattro brani biblici scritti su pergamena che ogni ebreo maschio adulto porta legati al braccio o alla fronte durante la preghiera.
10. Astuccio, fabbricato con materiali diversi e spesso finemente decorato, contenente una pergamena con passi biblici, che viene fissato allo stipite destro della porta.