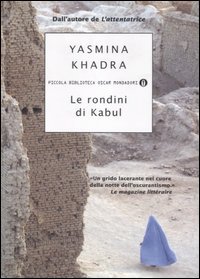
PROLOGO
Sullo sfondo di una città messa a ferro e fuoco da vent'anni di guerre Yasmina Khadra ambienta questa storia che mette i brividi, una vicenda che sembra uscire da una tragedia classica, con quattro protagonisti colti in un momento cruciale della loro esistenza: Atiq, il guardiano del carcere che non riesce più a sostenere il ritmo delle esecuzioni, sua moglie Mussarat, condannata da un male incurabile, Mohsen, un borghese decaduto, e sua moglie Zunaira, un tempo avvocato e sostenitrice della causa femminista. Ognuno di loro incarna un modo diverso di rispondere all'integralismo: la resistenza, la pazzia, la sottomissione, la fuga nell'illusione. Ma per tutti e quattro viene il momento di dare un senso alla propria vita, attraverso l'amore e il sacrificio...
Affidandosi a una scrittura ricca e intensamente poetica, Yasmina Khadra scaraventa il lettore nel cuore di una follia in cui si perdono i confini tra vita, amore, morte e sopravvivenza. Un bagno al vetriolo da cui si esce sconvolti, un romanzo straordinario, che è anche un grandioso inno alla donna, da una delle più importanti voci del mondo arabo.
PROGETTO GRAFICO: WANDA LAVIZZARI
Yasmina Khadra, pseudonimo di Mohamed
Moulessehoul, (Algeria, 1956), reclutato alla scuola dei cadetti a
nove anni, è stato ufficiale superiore dell'esercito algerino. Dopo
aver suscitato la disapprovazione dei suoi superiori con i primi
libri pubblicati, l'autore ha deciso di usare come pseudonimo il
nome della moglie, con il quale ha pubblicato in Francia alcuni
romanzi di successo. Nel 1999 ha lasciato l'esercito svelando così
la sua vera identità.
Attualmente vive in Francia. In Italia sono usciti Morituri (1988), Doppio bianco (1989), Cosa sognano i lupi (2001 ), La parte del morto (2005), Cugina K (2006) e L'attentatrice (2006).
Copyright © Editions Julliard, Paris 2002
Titolo originale dell'opera: Les hirondelles de Kaboul
© 2001 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano
I edizione Scrittori italiani e stranieri settembre 2003 I edizione Piccola Biblioteca Oscar aprile 2007
ISBN 978-88-04-56797-4
Questo volume è stato stampato presso Mondadori
Printing S.p.A. Stabilimento NSM - Cles (TN) Stampato in Italia.
Printed in Italy
A casa del diavolo, una tromba d'aria dispiega la
sua veste svolazzante nella macabra danza di una strega in trance;
il suo isterismo non riesce neppure a spolverare le due palme
calcificate che si alzano al cielo come le braccia di un
suppliziato. Un caldo canicolare ha riassorbito i presunti refoli
d'aria che la notte, nella sua disastrosa ritirata, aveva
dimenticato di portare con sé. Dalla fine della mattinata, nessun
rapace ha trovato ragioni sufficienti per sorvolare le sue prede.
Scomparsi i pastori, che solitamente spingevano le scheletriche
greggi fino ai piedi delle colline. Non un'anima nel raggio di
chilometri, tranne qualche sentinella acquattata in una rudimentale
torre di guardia. Un silenzio di morte accompagna quella
desolazione sconfinata.
Le terre afghane sono solo campi di battaglia, deserti di sabbia e cimiteri. Le preghiere si frangono nella furia dei mitra, ogni sera i lupi ululano alla morte e il vento, quando si alza, affida il lamento dei mendicanti al gracchiare dei corvi.
Tutto sembra arroventato, fossilizzato, folgorato da un sortilegio innominabile. Il raschiatoio dell'erosione gratta, scrosta, sgrossa, livella il suolo necrotizzato, innalzando impunemente le steli della sua forza tranquilla. Poi, senza alcun preavviso, ai piedi di montagne rabbiosamente tosate dal soffio delle fornaci, sorge Kabul... o meglio quel che ne resta: una città in avanzato stato di decomposizione.
Nulla sarà più come prima, sembrano dire le strade crepate, le colline tignose, l'orizzonte incandescente e il ticchettio delle culatte. La rovina dei bastioni si è insinuata fin dentro le anime. La polvere ha prostrato i frutteti, accecato gli sguardi e sigillato le menti. A tratti, il ronzio delle mosche e il fetore delle carogne aggiungono alla desolazione qualcosa d'irreversibile. Si direbbe che il mondo stia imputridendo, che la sua cancrena abbia scelto di svilupparsi a partire da qui, dalla terra dei Pashtun, mentre la desertificazione prosegue le sue implacabili reptazioni attraverso la coscienza degli uomini, e il loro modo di pensare.
Nessuno crede al miracolo delle piogge, all'incanto della primavera, ancor meno all'alba di un domani più clemente. Gli uomini sono impazziti; hanno voltato le spalle alla luce per rivolgersi alle tenebre. I santi protettori sono stati destituiti. I profeti sono morti e i loro fantasmi crocifissi sulla fronte dei bambini...
E tuttavia qui, tra mute pietraie e tombe silenziose, fra terreni riarsi e cuori inariditi, è nata anche la nostra storia, come sboccia la ninfea sulle putride acque di una palude.
CAPITOLO 1
Atiq Shaukat distribuisce scudisciate tutt'intorno
per aprirsi un varco nella folla cenciosa che turbina, come un
nugolo di foglie morte, fra le bancarelle del mercato. È in
ritardo, ma non è possibile andare più veloce. Sembra di stare in
un alveare; le scudisciate che elargisce non destano la minima
reazione. È giorno di suq, e la gente è come in trance. Ad Atìq
gira la testa. Giungono mendicanti da tutti gli angoli della città,
a ondate sempre più imponenti, contendendo a carrettieri e
perdigiorno improbabili spazi liberi. L'afrore dei facchini e le
esalazioni delle merci avariate impregnano l'aria di un odore
pestilenziale, mentre un caldo implacabile opprime tutto il
piazzale. Alcune donne spettrali, censurate nei loro sudici burqa,
si aggrappano ai passanti, con la mano in un gesto di supplica,
raccogliendo al volo chi una moneta, chi un'imprecazione. Spesso,
quando si ostinano, una frusta spazientita le ricaccia indietro, il
tempo di un veloce ripiegamento, ed ecco che tornano all'assalto
salmodiando insopportabili suppliche. Altre, ingombre di marmocchi
dalle narici effervescenti di mosche, s'aggrumano disperate intorno
ai fruttivendoli, facendo la posta, fra una litania e l'altra, a un
pomodoro o a una cipolla marci scovati da un cliente attento in
fondo al suo cesto.
«Non restate qui,» grida loro un venditore agitando furiosamente
una lunga pertica sopra le teste «attirate la iella e ogni genere
d'insetto sul mio banco.»
Atiq Shaukat consulta l'orologio. Le mascelle gli si contraggono
per la collera, il boia dev'essere arrivato da più di dieci minuti,
e lui si trova ancora per strada. Esasperato, si rimette a
scudisciare per disperdere quella marea umana, s'accanisce
inutilmente contro un gruppo di vecchi insensibili alle sue
frustate quanto ai singhiozzi di una bambina che si è persa nella
calca, poi, approfittando di una breccia aperta da un camion,
riesce a sgattaiolare fino a un vicolo meno affollato e si
affretta, zoppicando leggermente, verso un edificio rimasto
stranamente in piedi in mezzo a una distesa di rovine. Si tratta di
un vecchio dispensario abbandonato, e da tempo saccheggiato dagli
spiriti, che i talebani utilizzano occasionalmente come prigione
quando nel quartiere è prevista un'esecuzione pubblica.
«Ma dov'eri finito?» tuona un grasso barbuto palpando il suo
kalashnikov. «Ti ho mandato a cercare un'ora fa.»
«Ti chiedo scusa, Qassim Abdul Jabbar» dice Atiq senza fermarsi.
«Non ero a casa.»
Poi, con voce irritata, aggiunge:
«Ero all'ospedale. Ho dovuto portare via d'urgenza mia moglie.»
Qassim Abdul Jabbar brontola, per nulla convinto, e col dito sul
quadrante dell'orologio gli fa capire che per colpa sua stanno
tutti perdendo la pazienza. Atiq incassa il collo nelle spalle e si
dirige verso l'edificio, dove lo aspettano alcuni uomini armati,
accovacciati da una parte e dall'altra del portone. Uno di loro si
alza spolverandosi il sedere, si dirige verso un camioncino col
pianale scoperto parcheggiato a una ventina di metri, salta dentro
la cabina, fa ruggire il motore e si dispone, in retromarcia,
davanti all'ingresso della prigione.
Atiq Shaukat strappa un mazzo di chiavi da sotto il lungo gilè e
s'infila nella prigione, tallonato da due miliziane imbacuccate nei
loro burqa. In un angolo della cella, proprio lì dove un lucernario
riversa una pozza di luce, una donna velata conclude le sue
preghiere. Le due miliziane invitano il carceriere ad allontanarsi.
Una volta sole, aspettano che la prigioniera si sia rialzata per
avvicinarsi e, senza tanti complimenti, le ordinano di star dritta,
poi iniziano a legarle strettamente le braccia e le cosce, e alla
fine, dopo aver verificato che le corde siano ben tese, le
avvolgono un sacco di tela intorno al corpo spingendola davanti a
loro nel corridoio. Atiq, che aspettava nel vano del portone, fa
cenno a Qassim Abdul Jabbar che le miliziane stanno arrivando.
Quest'ultimo chiede agli uomini nel cortile di farsi da parte.
Incuriositi, alcuni passanti si radunano di fronte all'edificio, in
silenzio. Le due miliziane escono in strada, afferrano la
prigioniera da sotto le ascelle, la buttano sul sedile posteriore
del camioncino e si piazzano accanto a lei, una per lato.
Abdul Jabbar rialza la sponda del camioncino e la fissa con i
catenacci. Data un'ultima occhiata alle due miliziane e alla
prigioniera per accertarsi che tutto sia a posto, s'arrampica a
fianco del conducente e ordina di mettersi in marcia battendo sul
fondo il calcio del kalashnikov. Subito il camioncino si mette in
moto, scortato da un grosso 4x4 sormontato da un lampeggiatore e
carico di miliziani stracciati.
Mohsen Ramat esita a lungo prima di decidersi a raggiungere la
folla in piazza. È stata annunciata l'esecuzione pubblica di una
prostituta. Verrà lapidata. Qualche ora prima, alcuni operai hanno
scaricato delle carriole piene di sassi nel luogo dell'esecuzione e
hanno scavato una fossa profonda una cinquantina di centimetri.
Mohsen ha assistito a parecchi linciaggi del genere. Solo ieri, due
uomini, uno dei quali appena adolescente, sono stati impiccati in
cima a un'autogrù per esserne sganciati solo al calare della notte.
Mohsen detesta le esecuzioni pubbliche. Lo costringono a prendere
coscienza della propria fragilità, rendono più grevi le prospettive
della sua finitezza; di punto in bianco, scopre quanto siano futili
le cose e le persone, e più nulla lo riconcilia con le certezze di
un tempo, quando levava lo sguardo all'orizzonte solo per
rivendicarlo. La prima volta che aveva assistito all'esecuzione di
qualcuno - un assassino sgozzato da un parente della vittima - era
stato male. Per notti e notti, i suoi sogni sfolgorarono di visioni
terrificanti. Spesso, si risvegliava urlando peggio di un ossesso.
Poi, mentre il passare dei giorni consolida i patiboli e infoltisce
il gregge espiatorio al punto che la gente di Kabul è presa
d'angoscia solo all'idea che un'esecuzione capitale venga rinviata,
Mohsen ha smesso di sognare. La sua coscienza si è spenta. Si
addormenta appena chiude gli occhi e resuscita solo al mattino, la
testa vuota come una zucca. La morte, per lui come per gli altri, è
una banalità. D'altronde, tutto è banalità. A parte le esecuzioni
capitali, che rincuorano i superstiti ogni volta che i mullah si
trascinano davanti alle loro porte, non c'è niente. Kabul è
diventata l'anticamera dell'aldilà. Un'anticamera oscura, dove i
punti di riferimento sono adulterati; un calvario pudibondo;
un'insopportabile latenza osservata nella più stretta intimità.
Mohsen non sa dove andare né che farsene del proprio ozio. Fin dal
mattino non smette di vagare nei sobborghi devastati, con la mente
che vacilla, il volto inespressivo. Prima, ossia molti anni luce
fa, gli piaceva passeggiare, la sera, lungo i viali di Kabul.
All'epoca, le vetrine dei negozi non avevano granché da offrire, ma
nessuno veniva a sferzarti il viso a frustate. La gente badava alle
proprie occupazioni con l'entusiasmo sufficiente a concepire, nel
loro delirio, progetti mirabolanti. I chioschi erano pieni da
scoppiare e il loro baccano si riversava sui marciapiedi come una
colata d'allegria. Buttati su sedie di vimini, i vecchi fumavano il
narghilè, gli occhi strizzati per un raggio di sole, il ventaglio
negligentemente posato sul ventre. E le donne, nonostante il velo
graticciato, piroettavano nel loro profumo come vampate di calore.
I carovanieri di un tempo giuravano di non aver visto in nessun
altro posto, nel corso delle loro peregrinazioni, uri così
affascinanti. Vestali impenetrabili, le loro risate erano un canto,
la loro grazia un'apparizione. Per questa ragione indossare il
burqa è diventata una necessità; serve più a proteggerle da sguardi
malevoli che a risparmiare agli uomini immani sortilegi... Com'è
lontano, quel tempo. È forse frutto di pura fabulazione? Ormai, i
viali di Kabul non divertono più. Le facciate scarnificate, rimaste
ancora in piedi per non si sa quale miracolo, attestano che le
bettole, le osterie, le case e gli edifici sono stati ridotti in
fumo. La carreggiata, prima asfaltata, è ora un sentiero battuto
che i sandali e gli zoccoli raspano ogni giorno senza posa. I
negozianti hanno appeso il sorriso al chiodo. I fumatori di chilum
si sono volatilizzati. Gli uomini si sono trincerati dietro le
ombre cinesi e le donne, mummificate in sudari del colore della
paura o della febbre, sono assolutamente anonime.
Mohsen aveva dieci anni, prima dell'invasione sovietica; un'età in
cui non si capisce perché, di punto in bianco, i giardini vengano
disertati e i giorni siano pericolosi quanto le notti; un'età in
cui s'ignora, soprattutto, che una sventura fa presto ad arrivare.
Suo padre era un facoltoso commerciante. Abitavano una grande casa
in pieno centro e ricevevano regolarmente parenti o amici. Mohsen
non ricorda esattamente quel tempo, ma è sicuro che era davvero
felice, che nessuno contestava i suoi scoppi di risa o condannava i
suoi capricci di bambino viziato. Poi, è arrivata quell'ondata
russa, con la sua armada da fine del mondo e il suo
gigantismo conquistatore. Il cielo afghano, in cui si tessevano i
più begli idilli della terra, fu coperto da rapaci blindati: la sua
azzurra limpidezza fu zebrata da strie di polvere e le rondini,
sgomente, si dispersero nel balletto dei missili. La guerra era lì.
Aveva trovato una patria...
Un colpo di clacson lo scaraventa di lato. Istintivamente porta la
sciarpa al volto per ripararsi dalla polvere. Il camioncino di
Abdul Jabbar lo sfiora, per poco non travolge un mulattiere e
piomba sulla piazza, seguito dal potente 4x4. Alla vista del
corteo, un truce schiamazzo scuote la folla, in cui adulti irsuti
contendono i primi posti a fauneschi ragazzini. I miliziani devono
distribuire scudisciate a più non posso per sedare gli animi.
Il veicolo si ferma davanti alla fossa appena scavata. Fanno
scendere la peccatrice mentre piovono invettive da ogni parte. Il
turbinare della folla scompiglia nuovamente i ranghi, catapultando
verso il fondo i più distratti.
Insensibile alle brutalità che cercano di ricacciarlo indietro,
Mohsen approfitta dei varchi che l'agitazione apre nella calca per
guadagnare i primi posti. Alzandosi sulla punta dei piedi, scorge
un energumeno colossale "piantare" la donna impura nella fossa e
ricoprirla di terra fino alle cosce, in modo da tenerla dritta e
impedirle di muoversi.
Un mullah si getta sulle spalle le falde del proprio burnus,
squadra con disprezzo, per l'ultima volta, il cumulo di veli sotto
il quale una persona si prepara a morire e tuona: «Alcuni hanno
scelto di sguazzare nel fango come i porci. Eppure, erano a
conoscenza del Messaggio, conoscevano i pericoli delle tentazioni,
ma la loro fede non è stata abbastanza forte da resistere. Esseri
miserabili, ciechi e frivoli, hanno preferito un istante di
dissolutezza, effimero quanto irrisorio, al giardino eterno. Hanno
tolto le loro dita dall'acqua lustrale delle abluzioni per ficcarle
nella risciacquatura, si sono tappati le orecchie all'appello del
muezzin per ascoltare le oscenità di Satana, hanno accettato di
subire la collera di Dio piuttosto che tenersene al riparo. Cosa
dire loro, se non la nostra pena e la nostra indignazione?... (Il
suo braccio si tende come una spada verso la mummia.) Questa donna
non ignorava quel che faceva. L'ebbrezza della fornicazione l'ha
distolta dalla via del Signore. Oggi, è il Signore che le volta le
spalle. Non ha diritto né alla sua misericordia né alla pietà dei
credenti. Morirà nel disonore come nel disonore è vissuta».
Si interrompe per raschiarsi la gola, dispiega un foglio di carta
in un silenzio assordante.
«Allahu' akbar!» grida qualcuno dalle ultime file.
Il mullah alza maestosamente una mano per placare l'urlatore. Dopo
aver recitato un versetto del Corano, legge qualcosa che somiglia a
una sentenza, rimette il foglio di carta in una tasca interna del
gilet e, dopo una breve meditazione, invita la folla ad armarsi di
pietre. È il segnale. In una ressa indescrivibile, la gente si
getta sui mucchi di pietre appositamente sistemati nella piazza
qualche ora prima. Subito, un diluvio di proiettili s'abbatte sulla
vittima che, imbavagliata, vibra sotto la furia dei colpi senza un
grido. Mohsen raccoglie tre pietre e le lancia contro il bersaglio.
Le prime due si perdono nella frenesia generale, ma al terzo
tentativo raggiunge la vittima in testa e vede, con insondabile
giubilo, una macchia rossa aprirsi nel punto in cui l'ha colpita.
Un minuto dopo, insanguinata e sfinita, la vittima si accascia e
non si muove più. La sua rigidità galvanizza ancor di più i
lapidatori che, con gli occhi stralunati e la bava alla bocca,
raddoppiano la propria ferocia come se volessero resuscitarla per
prolungare il suo supplizio. Nella loro isteria collettiva,
persuasi d'esorcizzare i propri demoni attraverso quelli
della succube (Nella demonologia, i demoni succubi sono demoni
femminili che nottetempo vengono a congiungersi carnalmente con gli
uominI) alcuni non si rendono conto che quel corpo crivellato non
risponde più alle offese, che la donna immolata giace senza vita,
semisepolta, come un sacco di orrore gettato agli avvoltoi.
CAPITOLO 2
Il ragazzo annuisce, stringe controvoglia il frutto sotto
l'ascella e si dirige verso un'incredibile babele di
catapecchie.
«Attenzione!» urlano. «Scansatevi, scansatevi...»
Atiq rialza le falde del lungo gilet e si picchia sul sedere per
toglierne la polvere.
«Ti davo per spacciato» gli confida un uomo seduto a un tavolo
della terrazza di un chiosco.
Atiq riconosce Mirza Shah, che gli offre una sedia.
«Posso offrirti un té, aguzzino?»
«Accetto volentieri» dice Atiq lasciandosi cadere sulla
sedia.
«Hai chiuso bottega prima del previsto.»
«È difficile essere carcerieri di se stessi.»
Mirza inarca un sopracciglio. «Non verrai a dirmi che le tue celle
non hanno inquilini.»
«È la verità. L'ultima è stata lapidata stamattina.»
«La puttana? Non ho partecipato alla cerimonia, ma mi hanno
raccontato...»
Atiq si addossa al muro, congiunge le dita sul ventre e contempla
le macerie di quello che, una generazione prima, era stato uno dei
viali più animati di Kabul.
«Sei triste, Atiq.»
«Sì?»
Mirza sgrana il rosario intorno al dito squadrando l'amico che,
infastidito, finge di guardarsi le unghie.
«Cos'è che non va, aguzzino?»
«Me lo chiedo anch'io.»
«Per questo poco fa parlavi da solo?»
«Forse.»
«Non trovi nessuno con cui parlare?»
«È proprio necessario?»
«Bada a come parli» l'interrompe Atiq, a disagio. «C'è il
rischio che ti prendano sul serio.»
«È solo per punzecchiarti.»
«Non si scherza a Kabul, lo sai bene.»
Mirza gli picchietta dolcemente sul dorso della mano per
tranquillizzarlo.
«Da bambini eravamo molto amici. L'hai dimenticato?»
«Le teste matte non hanno memoria.»
«Le teste matte non hanno memoria.»
«Non avevamo segreti.»
«Oggi, questo non è più possibile.»
La mano di Mirza si contrae.
«Chi oserebbe ribellarsi a essa, Mirza? Io no di
certo.
L'accetto pienamente, con infinita devozione, ma sono solo e
spaventato. Non c'è nessuno che mi aiuti.»
«È molto semplice: ripudiala.»
«E perché no?»
«Mi ha salvato la vita, ricordalo.»
All'improvviso, si acciglia: «Non sarai così pazzo da
amarla?».
«Viviamo insieme da una ventina d'anni. Non è una cosa da
poco.»
Mirza è scandalizzato, ma si trattiene e cerca di non strapazzare
l'amico d'infanzia.
«Non si tratta di amore.»
Mirza tace bruscamente. Un giovane si è fermato sulla soglia del
chiosco, lo sguardo perso e le labbra esangui. È alto, il viso
imberbe e bello, ornato da una ghirlanda sottile di peli ribelli. I
capelli lunghi e lisci gli cadono sulle spalle, che ha strette e
minute come quelle di una ragazza.
«Cosa vuoi?» lo apostrofa Mirza.
Il giovane si porta un dito alla tempia per tornare in sé, gesto
che infastidisce ulteriormente Mirza.
Mohsen Ramat si accorge che i due uomini hanno messo mano allo
scudiscio e stanno per sferzargli il viso. Si profonde in scuse
indietreggiando e si allontana verso l'accampamento di tende.
«Ti rendi conto?» s'indigna Mirza. «La gente non ha nessun
riguardo.»
CAPITOLO 3
Mohsen Ramat spinge titubante la porta di casa. È dalla mattina che non tocca cibo, e il suo vagabondare l'ha sfiancato. Nei chioschi, al mercato, in piazza, ovunque si è avventurato, è stato subito ripreso dall'incommensurabile stanchezza che si trascina dietro come una palla al piede. L'unico amico e confidente che aveva è morto di dissenteria l'anno scorso. Non è riuscito a farsene altri. La gente fa fatica a convivere con la propria ombra. La paura è diventata il più efficace mezzo di sorveglianza. Suscettibili come non mai, una confidenza viene subito male interpretata, e i talebani non sanno perdonare le lingue imprudenti. Visto che si può condividere solo la mala sorte, ognuno preferisce masticare per conto suo le proprie delusioni per non doversi sobbarcare a quelle altrui. Dal momento che a Kabul la gioia viene annoverata fra i peccati capitali, è perfettamente inutile cercare conforto presso una terza persona. Quale conforto si può ancora ottenere in un mondo in preda al caos, brutale e assurdo, dissanguato da un rosario di guerre di rara ferocia; un mondo disertato dai suoi santi protettori, in balia di corvi e carnefici, che le preghiere più fervide sembrano incapaci di riportare alla ragione?
Tranne un'ampia stuoia intrecciata come un
tappeto, due vecchi sgabelli imbottiti ormai bucati e un
cavalletto tarlato sul quale riposa il libro delle Letture, nella
stanza non è rimasto più nulla. Mohsen ha venduto tutti i mobili,
uno dopo l'altro, per far fronte alle ristrettezze. Adesso, non
riesce neppure a sostituire i vetri rotti. Le finestre, dalle
imposte cadenti, sono cieche. Ogni volta che un miliziano passava
per strada gli ordinava di ripararle al più presto: un passante
poteva rimanere offeso dal volto di una donna senza velo. Mohsen ha
ricoperto le finestre con le tende: da allora, il sole ha smesso di
visitare la sua casa.
Si toglie le scarpe sulla scaletta d'ingresso e crolla a terra.
«Ti porto da mangiare?» s'informa una voce di donna dietro una
tenda in fondo alla stanza.
«Non ho fame.»
«Un po' d'acqua?»
«Se è fresca, non dico di no.»
Un tintinnare di stoviglie nella stanza accanto, poi la tenda si
apre su una donna bella come il sole. Posa una piccola caraffa
davanti a Mohsen e si siede sullo sgabello di fronte. Mohsen
sorride. Sorride sempre quando sua moglie si fa vedere. È sublime,
di una freschezza imperitura. Nonostante le quotidiane avversità e
il lutto per una città in balia delle ossessioni e della follia
degli uomini, Zunaira non ha una ruga. È vero, le sue guance non
hanno più il riverbero di un tempo, non si sentono più risuonare le
sue risate, ma i suoi occhi immensi, splendenti come smeraldi,
hanno conservato intatta tutta la loro magia.
Mohsen si porta la caraffa alle labbra.
La moglie aspetta che abbia finito di bere per togliergliela di
mano.
«Sembri sfinito.»
«Oggi ho camminato parecchio. Ho i piedi in fiamme.»
La donna sfiora le dita dei piedi del marito prima di mettersi a
massaggiarle delicatamente. Mohsen si rovescia all'inietro,
appoggiandosi sui gomiti e si abbandona ai palpeggiamenti della
moglie.
-Ti aspettavo per pranzo.»
«Me ne sono dimenticato.»
«Ti sei dimenticato?»
«Non so cosa mi ha preso, oggi. Non ho mai provato prima una
sensazione del genere, nemmeno quando abbiamo perduto la nostra
casa. Ero come inebetito e vagavo alla cieca, incapace di
riconoscere le strade che percorrevo avanti e indietro senza
riuscire ad attraversarle. Strano davvero. Ero come immerso nella
nebbia, non riuscivo a ricordare quale fosse la mia direzione né
dove volessi andare.»
«Sarai rimasto troppo a lungo sotto il sole.»
«Non si tratta d'insolazione.»
Improvvisamente, tende la mano verso quella della moglie,
costringendola a sospendere il massaggio. Zunaira alza gli occhi
scintillanti, sorpresa dalla forza disperata della stretta intorno
al polso.
Mohsen esita un moménto, poi chiede con voce atona: «Sono
cambiato?».
«Perché mi fai questa domanda?»
«Ti domando se sono cambiato.»
Zunaira corruga le magnifiche sopracciglia per riflettere.
«Non capisco di cosa vuoi parlare.»
«Ma di me. Sono forse rimasto lo stesso uomo, quello che tu
preferivi agli altri? Ho conservato le stesse abitudini, le stesse
maniere? Pensi che io reagisca normalmente, che ti tratti con lo
stesso affetto?»
«Certo, molte cose sono cambiate intorno a noi. La nostra casa è
stata bombardata. I nostri cari e i nostri vicini non sono più qui,
alcuni di loro hanno lasciato questo mondo. Il tuo commercio è
finito in malora. Mi hanno tolto il mio lavoro. Non mangiamo a
sufficienza, e non facciamo più progetti per il futuro. Ma
siamo insieme, Mohsen. Questo deve contare per noi. Siamo insieme
per sostenerci. Abbiamo solo noi stessi per tenere viva la
speranza. Un giorno, Dio si ricorderà di noi. Si accorgerà che le
nefandezze che subiamo ogni giorno non sono riuscite a fiaccare la
nostra fede, che non abbiamo vacillato e meritiamo la sua
misericordia.»
Mohsen lascia il polso della moglie per accarezzarle lo zigomo. Il
gesto è affettuoso e lei vi si abbandona.
«Tu sei l'unico sole che mi resta, Zunaira. Senza di te, la mia
notte sarebbe più nera delle tenebre, più fredda della morte. Ma,
per l'amor di Dio, se vedi che cambio nei tuoi confronti, che
divento ingiusto o cattivo, dimmelo. Ho la sensazione che le cose
mi sfuggano, che stia perdendo il controllo. Se sto diventando
matto, aiutami a rendermene conto. Accetterei di deludere il mondo
intero, ma mi proibisco di farti torto, fosse pure senza
volerlo.»
Zunaira avverte tutta l'angoscia del marito. Per dimostrargli che
non ha nulla da rimproverarsi, fa scivolare la guancia nel palmo
titubante della sua mano.
«Amore mio, viviamo momenti difficili. A furia di piangere, non
sappiamo più cosa sia la tranquillità. Improvvisamente, la calma ci
spaventa e dubitiamo di tutto quel che non ci minaccia.»
Lentamente, Mohsen ritira le dita da sotto la guancia della moglie.
La vista gli si offusca; deve fissare il soffitto e lottare dentro
di sé per arginare l'emozione. Il pomo d'Adamo sembra impazzito nel
collo emaciato. La sofferenza è tale che dei brividi partono dagli
zigomi, dilagano fino al mento e tornano a squassargli le
labbra.
«Stamattina, ho fatto qualcosa d'impensabile» dice. Zunaira si
irrigidisce; ciò che legge nei suoi occhi smarriti la sconvolge.
Cerca di prendergli le mani, ma lui le ritira all'altezza del
petto, come per difendersi da un'aggressione.
«Non riesco a crederci» farfuglia. «Com'è potuto accadere? Come ho
potuto?»
Zunaira rialza la testa, sempre più perplessa.
Mohsen si mette ad ansimare. Il suo petto si alza e si abbassa a un
ritmo inquietante. Racconta, terrorizzato dalle sue stesse parole:
«Una prostituta è stata lapidata in piazza. Non so come io mi sia
unito alla folla di degenerati che chiedeva sangue. Ero come
travolto in un gorgo. Anch'io volevo essere in prima fila, guardare
da vicino la bestia immonda morire. E quando il diluvio di pietre
ha iniziato a sommergere la vittima, anch'io mi sono sorpreso a
raccogliere sassi e a mitragliarla. Ero come impazzito, Zunaira.
Come ho osato? Per tutta la vita mi sono ritenuto un obiettore di
coscienza. Né le minacce degli uni né le promesse degli altri mi
hanno convinto a prendere le armi e a dare la morte. Accettavo di
avere nemici, ma non sopportavo l'idea di essere nemico di
qualcuno. E stamattina, Zunaira, solo perché la folla urlava, ho
urlato con lei, solo perché esigeva sangue, anch'io l'ho reclamato.
Da quel momento, non smetto di guardare le mie mani che non
riconosco più. Ho vagato nelle strade per seminare la mia ombra e
prendere le distanze dal mio gesto, ma a ogni angolo di via, allo
svoltare di qualsiasi cumulo di macerie, mi sono ritrovato faccia a
faccia con quell'attimo di follia. Ho paura di me, Zunaira, non mi
fido più dell'uomo che sono diventato».
Zunaira è paralizzata dal racconto del marito. Mohsen non è il tipo
da mettersi a nudo. Raramente parla di quel che lo affligge, e non
lascia quasi mai trasparire le sue emozioni. Così, quando ha
scoperto quella grande sofferenza in fondo ai suoi occhi, ha capito
che lui non avrebbe potuto tenerla per sé. Si aspettava una
sventura del genere, ma non di quella gravità.
Il viso le si fa livido e, per la prima volta, i suoi occhi,
sgranandosi, perdono tutto il loro splendore.
«Hai lapidato una donna?»
«Credo di averla anche colpita alla testa.»
«Non puoi aver fatto una cosa simile, Mohsen. Non sei il tipo,
andiamo. Sei un uomo istruito.»
«Non so cosa mi ha preso. È accaduto tutto così in fretta. Come se
la folla mi avesse stregato. Non ricordo come ho raccolto le
pietre. Ricordo solo che non ho potuto disfarmene, una rabbia
irresistibile si è impadronita del mio braccio... Quel che mi
spaventa e mi tormenta è il fatto che non ho neppure cercato di
resistere.»
Zunaira si alza. Come se si riavesse da uno svenimento. A fatica.
Incredula, ma senza collera. Le sue labbra, un attimo prima tumide,
si sono disseccate. Cerca un appoggio, ma incontra solo una
putrella che sbuca dal muro, vi sì aggrappa. A lungo aspetta di
ritrovare le forze, invano. Mohsen cerca di prenderle la mano; lei
lo schiva e barcolla verso la cucina nell'irreale fruscio della sua
veste. Nel momento in cui scompare dietro la tenda, Mohsen
comprende che non avrebbe dovuto confidare alla moglie ciò che lui
per primo rifiuta di ammettere.
CAPITOLO 4
Il sole si prepara a tramontare. I suoi raggi non
rimbalzano più con la stessa furia sul fianco delle colline.
Eppure, per quanto attendano con impazienza la sera, i vecchi
inebetiti sotto i porticati sanno che la notte sarà torrida come il
giorno.
Rinchiusa nella stufa delle sue montagne pietrose, Kabul soffoca.
Sembra che in cielo si sia dischiuso uno spiraglio d'inferno. Le
rare folate di vento, lungi dal rinfrescare o rinnovare l'aria
inaridita, si divertono a sospendere la polvere nel vuoto per
corrodere gli occhi e prosciugare le gole.
Atiq Shaukat nota che la sua ombra si è smisuratamente allungata a
terra; tra poco il muezzin chiamerà i fedeli alla preghiera del
tramonto. Fa scivolare la frusta sotto la cintura e si dirige, con
passo annoiato, verso la moschea del quartiere, un ampio stanzone
imbiancato alla meglio, con il soffitto fatiscente e il minareto
mutilato da un bombardamento.
Una muta di talebani gravita attorno al santuario per intercettare
i passanti e obbligarli manu militari a raggiungere i fedeli.
L'interno del santuario ronza in quella fornace. I primi arrivati
hanno preso d'assalto i tappeti logori sparsi a terra in prossimità
del minbar, sul quale un mullah legge dottamente da un libro
religioso. I meno previdenti sono costretti a disputarsi
qualche lembo di stuoia. Tutti gli altri, troppo contenti di
ripararsi dal sole e dalle frustate dei miliziani, si accontentano
di un ruvido pavimento, che lascia sul sedere impronte ben
marcate.
Atiq scosta col ginocchio un gruppo di vecchi, ringhia al più
anziano di appiattirsi maggiormente contro il muro e si siede
contro una colonna. Il suo sguardo accigliato torna a minacciare il
vecchio in fondo, che si sforza in tutti i modi di farsi il più
piccolo possibile.
Atiq Shaukat detesta gli anziani, soprattutto quelli del quartiere,
in maggioranza putridi intoccabili che crepano nell'accattonaggio e
nell'insignificanza, salmodiando tutto il giorno funeste litanie e
sfiorando, con mani spettrali, le falde degli abiti dei passanti.
Simili a rapaci che aspettano al varco la selvaggina data in pasto
ai cani, si raccolgono la sera dove qualche anima caritatevole
viene a deporre ciotole di riso destinate alle vedove e agli
orfani, e non esitano a dare spettacolo pur di spigolarne qualche
boccone. Atiq li detesta soprattutto per questo. Ogni volta che li
trova nella sua stessa fila, prega con disgusto. Non gli piacciono
i loro gemiti quando si prosternano né la loro morbosa sonnolenza
durante le prediche. Per lui, sono solo cadaveri dimenticati dal
becchino, fetidi e inquietanti, con gli occhi cisposi, la bocca
rovinata e il fetore degli animali moribondi addosso...
"Astaghfirou Llahì" dice a se stesso. "Ecco che il tuo cuore si
gonfia di fiele anche nella casa del Signore, mio povero Atiq.
Riprenditi, dai. Lascia fuori il tuo astio e fa in modo che il
Maligno non corrompa i tuoi pensieri."
Si prende le tempie fra le mani, cerca di fare il vuoto nella
propria mente, poi ficca il mento nell'incavo della gola, gli occhi
ostinatamente fissi al suolo temendo che la vista degli anziani
alteri il suo raccoglimento.
Il muezzin va nella sua alcova per chiamare alla preghiera. I
fedeli si alzano anarchicamente tutti insieme e iniziano a disporsi
per file. Un piccoletto dalle orecchie a punta e l'aspetto di un
folletto tira Atiq per la falda del gilet, invitandolo ad
allinearsi agli altri. Irritato da quel gesto, il carceriere gli
afferra il polso e, con discrezione, lo torce contro il proprio
fianco. Dapprima sorpreso, il piccoletto cerca di liberare la mano
dalla morsa che la contorce, poi, non riuscendovi, si piega e
minaccia di stramazzare a terra tanto il dolore è forte. Atiq
continua a stringere ancora per qualche secondo; quando è sicuro
che la sua preda sta per mettersi a strillare, molla la presa. Il
piccoletto recupera il polso in fiamme, lo fa scivolare sotto
l'ascella e, non capacitandosi che un credente possa comportarsi a
quel modo in una moschea, si fa posto nella fila davanti per non
voltarsi più indietro.
"Astaghfirou Llah!" si ripete Atiq. "Cosa mi succede? Non sopporto
la penombra né la luce del giorno, non sopporto di stare seduto né
in piedi, non sopporto i vecchi né i bambini, non lo sguardo delle
persone né le loro mani su di me. È molto se sopporto me stesso.
Che io stia impazzendo?"
Dopo la preghiera, decide di aspettare nella moschea la successiva
chiamata del muezzin. Comunque, non se la sente di tornare a casa e
trovare il letto sfatto, le stoviglie dimenticate nei catini
maleodoranti e sua moglie rannicchiata in un angolo, la testa cinta
da un sudicio velo e il viso violaceo... I fedeli si disperdono;
alcuni raggiungono le loro case, altri si radunano nel cortile per
conversare. I vecchi e i mendicanti si ammucchiano all'ingresso del
santuario, la mano già tesa. Atiq si avvicina a un gruppo di
mutilati di guerra che stanno scambiandosi fatti d'arme. Il più
alto, una specie di Golia impigliato nella sua barba, traccia con
un dito tumefatto delle linee curve nella polvere. Gli altri,
seduti alla turca intorno a lui, l'osservano in silenzio. Tutti
sono mutilati, chi di un braccio, chi di una gamba. Uno di loro,
leggermente in disparte, ha perso tutt'e due le gambe. Sta
ficcato in un'artigianale carriola sistemata in modo che gli serva
da sedia a rotelle. Il Golia, invece, è cieco da un occhio e ha
metà del viso sfigurata. Finisce di disegnare, poi, puntellandosi a
terra, inizia a raccontare.
«La configurazione del terreno era più o meno questa» dice con una
voce esile che contrasta indecorosamente con l'erculea corpulenza.
«Qui c'era una montagna, lì un costone e due colline quaggiù. Da
qualche parte scorreva un fiume che da nord aggirava la montagna. I
sovietici tenevano le creste e ci sovrastavano su tutta la linea.
Da due giorni, ci contenevano tenacemente. Non potevamo ritirarci
per via della montagna. Era brulla e gli elicotteri ci avrebbero
sicuramente fatto a pezzi. Da qualche parte, il costone finiva in
un precipizio. Il fiume, largo e profondo, ci sbarrava la strada da
quest'altra parte. Ci rimaneva solo questo passaggio obbligato, un
guado, e i russi facevano apposta a lasciarcelo libero. In verità,
era una trappola. Una volta finiti là dentro, avremmo fatto la fine
del topo. Però non potevamo tenere la nostra posizione ancora a
lungo. Ci mancavano le munizioni e non avevamo di che mangiare.
Inoltre, il nemico aveva chiesto rinforzi. E con i rinforzi, la sua
artiglieria c'incalzava giorno e notte. Non potevamo chiudere
occhio. Eravamo in condizioni pietose. Non potevamo neppure
seppellire i nostri morti che iniziavano a puzzare
terribilmente...»
«I nostri morti non hanno mai puzzato» interviene il mutilato,
offeso. «Ricordo che una granata ci era piombata addosso
cogliendoci di sorpresa e uccidendo sul colpo quattordici
mujaheddin. È stato così che ho perso le gambe. Anche noi eravamo
circondati. Per otto giorni siamo rimasti nella nostra tana. E i
nostri morti non si sono nemmeno decomposti. Erano distesi lì dove
li aveva scaraventati l'esplosione. E non puzzavano, neanche. Il
loro volto era sereno. Nonostante le ferite e le pozze di sangue in
cui erano immersi, sembravano solo addormentati.»
«Doveva essere inverno» ipotizza il Golia.
«Non era inverno. Eravamo in piena estate, e per il caldo si poteva
friggere un uovo su di un sasso.»
«Forse, i tuoi mujaheddin erano dei santi» dice il Golia
stizzito.
«Tutti i mujaheddin sono benedetti dal Signore» gli ricorda il
mutilato, che gli altri approvano con ampi cenni del capo. «Non
puzzano e le loro carni non si decompongono.»
«Allora, veniva da dove, il puzzo che appestava la nostra
posizione?»
«Dalle carogne dei muli.»
«Non avevamo muli.»
«Allora, non poteva che essere il puzzo degli sciuravì (russi
secondo gli afghani). Quei maiali puzzerebbero anche dopo
aver fatto il bagno. Ricordo che quando ne catturavamo uno, tutte
le mosche del paese venivano a fargli visita...»
«Mi lasci finire il mio racconto, Tamreez?» dice il Golia,
esasperato.
«Ci tenevo a precisare che i nostri morti non puzzano. D'altra
parte, durante la notte odorano di un profumo di muschio che li
lascia solo al sorgere del giorno.»
Il Golia cancella con mano rabbiosa i disegni tracciati nella
polvere e si alza. Lanciata una torva occhiata al mutilato,
scavalca il muretto e se ne va verso un accampamento di tende. Gli
altri tacciono finché non è scomparso, poi, febbrili, si avvicinano
all'uomo in carriola.
«Comunque, la sua storia la conosciamo a memoria. Quanto la fa
lunga per arrivare al suo incidente» dice un monco, dall'aria
famelica.
«È stato un valoroso combattente» gli fa notare il suo vicino.
«È vero, ma l'occhio l'ha perso in un incidente, non in battaglia.
E poi, francamente, mi chiedo da quale parte stesse, se i suoi
morti puzzavano. Tamreez ha ragione. Siamo veterani di guerra.
Abbiamo perduto centinaia di amici. Sono morti tra le nostre
braccia o sotto i nostri occhi: nessuno puzzava...»
Tamreez si dimena nel suo macinino, si sistema il cuscino sotto le
ginocchia avvolte da bende di caucciù e guarda in direzione
dell'accampamento di tende come se temesse il ritorno del
Golia.
«Ho perduto le gambe, metà dei denti, tutti i capelli, ma la
memoria è rimasta intatta. Mi ricordo ogni particolare, come se
fosse ieri. Eravamo in piena estate, e quell'anno la canicola
spingeva i corvi al suicidio. Li vedevamo salire alti nel cielo,
prima di lasciarsi precipitare come incudini, le ali incollate ai
fianchi e il becco in avanti. Lo giuro sul Libro Santo, è la verità
vera. Sentivamo crepitare i pidocchi nei nostri panni stesi sulle
rocce roventi. È stata la peggiore estate che abbia mai visto.
Avevamo allentato la vigilanza, certi che nessun culo bianco si
sarebbe avventurato fuori dell'accampamento sotto un simile sole di
piombo. Ma i rinnegati russi ci avevano scovato grazie all'aiuto di
un satellite o qualcosa del genere. Se un elicottero o un aereo
avesse sorvolato il nostro covo, un minuto dopo avremmo evacuato la
nostra postazione. Invece, niente all'orizzonte. Calma piatta in
tutte le direzioni. Stavamo mangiando nella nostra tana, quando la
granata ci è piovuta addosso. Azzeccandoci in pieno. Al posto
giusto, nel momento giusto. Bum! Ho visto un geyser di terra e
fuoco che mi ghermiva, e poi basta. Quando mi sono risvegliato,
giacevo squarciato sotto un masso, le mani insanguinate, i vestiti
laceri e neri di fumo. Non ho capito immediatamente. Poi, ho visto
una gamba accanto a me. Neppure per un attimo ho pensato che fosse
la mia. Non sentivo nulla, non soffrivo. Ero solo un po'
rintronato. (Di colpo sgrana gli occhi, il viso rivolto verso la
cima del minareto. Le labbra gli fremono mentre gli zigomi sono
squassati da spasmi irrefrenabili. Giunge le mani come per
raccogliere l'acqua da una fontana e racconta con un tremolio nella
gola...) È stato così che l'ho visto. Come adesso vedo voi. Lo
giuro sul Libro Santo, è la verità... Volteggiava nel cielo blu. Le
ali talmente bianche che i loro riflessi illuminavano l'interno
della caverna. Volteggiava, volteggiava. Nel silenzio assoluto, non
udivo i lamenti dei feriti né le esplosioni tutt'intorno. Sentivo
solo il serico fruscio delle sue ali che, maestose, rimestavano
l'aria... Era una visione incantevole...»
«È sceso verso di te?» s'informa il monco, eccitato.
«Sì» dice Tamreez. «È sceso fino a me. Piangeva e il suo viso
purpureo brillava come un astro.»
«Era l'angelo della morte» garantisce il suo vicino. «Poteva essere
solo lui. Appare sempre così, ai prodi. Ti ha detto qualcosa?»
«Non ricordo. Ha dispiegato le ali intorno al mio corpo ma io l'ho
respinto.»
«Disgraziato,» gli gridano «dovevi lasciarlo fare. L'angelo ti
avrebbe portato dritto in paradiso e adesso non staresti a marcire
nella tua carriola.»
Atiq pensa di avere ascoltato fin troppo e decide di andare a
sgranchirsi la mente altrove. A furia di essere ripetuti fino alla
noia e modificati secondo le circostanze, i racconti dei reduci di
guerra sono in procinto di diventare vere e proprie fabulazioni.
Atiq pensa sinceramente che i mullah dovrebbero porvi termine. Si
accorge soprattutto che non può attardarsi per strada
indefinitamente. Da qualche tempo, cerca di fuggire la sua realtà;
quella che non può modificare né raccontare, nemmeno a
quell'insensibile e ottuso di Mirza Shah, sempre pronto a
rinfacciare alla gente il poco di coscienza che gli resta. D'altra
parte, se la prende con se stesso per essersi confidato con lui.
Per un bicchiere di té che non ha neanche bevuto. Se la prende con
se stesso perché continua a sottrarsi alle proprie responsabilità,
perché è stato così sciocco da credere che il modo migliore di
risolvere un problema sia voltarsi dall'altra parte. Sua moglie è
malata; è colpa sua? Ha dimenticato quanto si è prodigata per lui
quando il suo plotone, sbaragliato dalle truppe comuniste, lo aveva
abbandonato in un villaggio sperduto; come l'ha nascosto e curato
per settimane; com'è riuscita a trasportarlo a dorso di mulo,
attraversando per giorni e notti un territorio ostile tra bufere di
neve, fino a Peshawar? Adesso che lei ha bisogno di lui, la fugge
senza ritegno, correndo dietro a tutto ciò che può distrarlo.
Ma tutto ha una fine, anche il giorno. Scende la notte; la gente
rientra nelle proprie case, i senzatetto raggiungono la loro tana,
mentre gli sbirri, non di rado, sparano senza intimare l'alt contro
ogni ombra sospetta. È bene che anche lui torni a casa a ritrovare
la moglie nelle condizioni in cui l'ha lasciata, ossia malata e
disperata. Prende per una strada ingombra di macerie, si ferma
all'altezza di un rudere, appoggia il braccio contro l'unico muro
ancora in piedi e rimane così, il mento sulla spalla,
sufficientemente stabile sulle gambe. Ovunque, nell'oscurità in cui
rare lucerne dondolano svogliate, sente frignare dei lattanti. I
loro vagiti gli fendono il cranio come stilettate. Una donna
insorge contro la prole turbolenta, ma subito la voce assordante di
un uomo le intima di tacere. Atiq alza la testa, poi la schiena,
contempla le miriadi di costellazioni disseminate in cielo.
Qualcosa di simile a un singhiozzo gli strozza la gola. Deve
stringere le dita fino a sanguinare per non crollare. È stanco,
stanco di girare a vuoto e di correre dietro a volute di fumo;
stanco di giornate insipide come questa che lo calpestano dal
mattino a notte fonda. Non riesce a capire perché sia
sopravvissuto, per due decenni di fila, alle imboscate, alle
incursioni aeree, agli ordigni esplosivi che maciullavano decine di
corpi intorno a lui senza risparmiare donne e bambini, greggi e
casolari, per continuare a vegetare, alla fine, in un mondo tanto
oscuro e ingrato, in una città completamente sfasata, pavesata di
patiboli e percorsa da relitti umani: una città che lo maltratta e
lo guasta inesorabilmente, giorno dopo giorno, notte dopo notte,
sia in compagnia di una morta con la condizionale in fondo a una
fetida cella sia mentre veglia la moglie agonizzante, più
miserabile di un pendaglio da forca...
«Dio è misericordioso!» sospira. «Se questa è la prova alla quale
mi sottoponi, Signore, dammi la forza per superarla.»
Battendo le mani, biascica un versetto e torna sui propri passi per
rientrare a casa.
La prima cosa a colpire Atiq quando spinge la porta di casa è la
lanterna accesa. Di solito, a quest'ora, Mussarat è a letto e le
stanze sono immerse nel buio. Nota il giaciglio vuoto, le coperte
accuratamente distese sul pagliericcio, i cuscini dritti contro il
muro come piace a lui e tende l'orecchio; nessun lamento, nessun
rumore. Torna indietro, osserva i catini rivolti contro il
pavimento, le stoviglie scintillanti nel loro angolo. Tutto ciò
l'incuriosisce, perché da mesi ormai è raro che Mussarat si occupi
della casa. Rosa dalla malattia, trascorre la maggior parte del
tempo a gemere, raggomitolata intorno ai dolori che le attanagliano
le viscere. Atiq tossicchia per segnalare la propria presenza. Una
tenda si scosta e alla fine compare Mussarat, il viso sciupato, ma
in piedi sulle proprie gambe. Non può fare a meno di
appoggiarsi con la mano al vano della porta, e tuttavia
la si sente combattere con tutta l'energia che le rimane per
reggersi sulle proprie gambe come se ne andasse della sua dignità.
Atiq si prende il mento fra due dita, un sopracciglio inarcato,
senza cercare di dissimulare la propria sorpresa.
«Pensavo che fosse tornata mia sorella dal Belucistan» dice.
Mussarat sussulta.
«Non sono ancora inabile» gli fa notare.
«Non intendevo dire questo. Stamattina, ti ho lasciata così male in
arnese. Quando ho visto ogni cosa al suo posto, in ordine, e il
pavimento spazzato, ho subito pensato che fosse tornata mia
sorella. Ci è rimasta solo lei. Le tue vicine sono al corrente
delle tue condizioni di salute, eppure nessuna di loro è mai venuta
a vedere in che modo potesse rendersi utile.»
«Non ho bisogno di loro.»
«Quanto sei permalosa, Mussarat. Perché devi rigirare ogni parola
per vedere cosa c'è sotto?»
Mussarat si rende conto che non sta appianando le cose con suo
marito. Toglie la lanterna dalla tavola e l'appende a una putrella
per fare più luce; poi, va a cercare un vassoio ricco di
cibarie.
«Ho tagliato il melone che mi hai mandato e l'ho messo al fresco
sul davanzale» dice in tono conciliante. «Sicuramente avrai fame.
Ti ho preparato il riso come piace a te.»
Atiq si disfa delle ciabatte, appènde il tocco e lo scudiscio alla
maniglia di una finestra e si siede accanto al vassoio di ferro
ammaccato. Non sapendo cosa dire e non osando guardare la moglie
per paura di riattizzarne la suscettibilità, afferra una caraffa e
se la porta alle labbra. L'acqua rigurgita dalla sua bocca e gli
schizza la barba; si asciuga con il dorso della mano e finge di
interessarsi a una focaccia d'orzo.
«L'ho cotta con le mie mani» gli dice Mussarat in agguato. «Per
te.»
«Perché ti dai tanto disturbo?» si lascia infine scappare Atiq.
«Voglio adempiere ai miei obblighi di moglie fino all'ultimo.»
«Io non pretendo niente da te.»
«Non hai bisogno di farlo.»
Quasi si accascia sulla stuoia di fronte a lui, bracca il suo
sguardo e aggiunge: «Mi rifiuto di abdicare, Atiq».
«Donna, non è questo il problema.»
«Sai quanto detesti essere umiliata.»
Atiq posa su di lei uno sguardo penetrante. «Ho fatto qualcosa che
ti ha offesa, Mussarat?»
§«L'umiliazione non è necessariamente nell'atteggiamento degli
altri, qualche volta risiede nel fatto di non accettarsi.»
«Ma cosa vai a cercare, donna? Tu sei malata, tutto qua. Hai
bisogno di riposarti, di recuperare le forze. Non sono cieco.
Viviamo insieme da anni; non hai mai barato. Né con me, né con
nessun altro. Non hai bisogno di aggravare le tue condizioni solo
per dimostrarmi chissà cosa.»
«Viviamo insieme da anni, Atiq, ma questa è la prima volta che ho
la sensazione di mancare ai miei doveri di moglie: mio marito non
mi parla più.»
«Non ti parlo, è vero, ma non ce l'ho con te. Sono solo stremato da
questa guerra che non ha fine, e dalla miseria che guasta ogni cosa
intorno a noi. Sono soltanto un carceriere occasionale, che non
capisce perché abbia accettato di sorvegliare dei poveracci invece
di occuparsi della propria disgrazia.»
«Se hai fede in Dio, devi considerare la disgrazia che sono
diventata per te come una prova di pietà.»
«Non sei la mia disgrazia, Mussarat. Sei tu che lo pensi. Ho fede
in Dio e accetto tutti i dispiaceri che mi manda per mettere alla
prova la mia pazienza.»
«Oltrepassi ogni limite, e poi chiedi scusa. Mi manca solo
questa, figurati.»
Lei si alza, fa per tornare dietro la tenda.
«Ecco la ragione che mi spinge a non rivolgerti la parola,
Mussarat: Sei sempre sulla difensiva, come una lupa braccata.
E quando cerco di farti ragionare, te la prendi e te ne
vai.»
«È vero,» riconosce lei «ma io ho solo te. Quando ce l'hai con me,
è come se il mondo intero mi voltasse le spalle. Darei tutto quel
che ho per te. È perché cerco di meritarti, costi quel che costi,
che sono così maldestra. Oggi, mi ero ripromessa di non
contrariarti o di non deluderti. E tuttavia, è proprio quello che
continuo a fare.»
«In tal caso, perché persisti nell'errore?»
«Ho paura...»
«Di cosa?» "
«Dei giorni che verranno. Mi terrorizzano. Se solo tu potessi
facilitarmi le cose.»
«E come?»
«Dicendomi cosa ti ha detto il dottore riguardo alla mia
malattia.»
«Ancora!» urla Atiq fuori di sé.
Con un calcio rovescia la tavola, si alza di scatto e, raccolti al
volo ciabatte, scudiscio e turbante, esce in strada.
Rimasta sola, Mussarat si prende la testa tra le mani. Lentamente,
le spalle minute si mettono a sussultare.
A qualche caseggiato da lì, neppure Mohsen Ramat riesce a dormire.
Allungato sul pagliericcio, le mani sotto la nuca, fissa la candela
che trasuda sopra una terrina, proiettando ombre incerte contro le
pareti. Sopra la testa, il soffitto fatiscente gli fa notare che
una grossa asse si è incurvata fino a spezzarsi. La settimana
scorsa, nella stanza accanto, un brandello di muro si è
staccato, rischiando di seppellire Zunaira...
Zunaira che si è trincerata in cucina e tarda a raggiungerlo.
Hanno cenato in silenzio, lui prostrato, lei assente. Non hanno
toccato cibo, mordicchiando distrattamente il boccone di pane che
hanno impiegato un'ora a inghiottire. Mohsen era a disagio. Il suo
racconto a proposito dell'esecuzione della prostituta ha portato lo
scompiglio in casa sua. Confessandosi a Zunaira, pensava di
sgravarsi la coscienza, di riprendere il controllo di sé. Mai
avrebbe sospettato di scandalizzare la moglie fino a quel punto.
Più d'una volta, ha cercato di tendere la mano verso di lei, di
farle capire quanto fosse straziato; il braccio rifiutava di
obbedirgli; rimaneva incollato al suo fianco, come anchilosato.
D'altra parte, Zunaira non l'incoraggiava. Teneva gli occhi a
terra, la testa china, mentre le dita sfioravano appena il bordo
del tavolino. Impiegava più tempo a portare un boccone di pane alle
labbra che a morderlo. Lontana, i gesti meccanici, rifiutava di
risalire in superficie e risvegliarsi. Siccome né l'uno né l'altra
mangiavano veramente, ha preso il vassoio e si è ritirata dietro la
tenda. Mohsen l'ha aspettata a lungo, poi è andato a stendersi sul
pagliericcio. Lì, ancora, l'ha aspettata. Zunaira non è venuta.
L'aspetta da due ore, forse più, e Zunaira non lo raggiunge ancora.
In cucina, nessun rumore attesta la sua presenza. Lavare due piatti
e vuotare un cestino di pane non richiederebbe più di un battere di
ciglia. Mohsen si rimette a sedere, pazienta ancora qualche
secondo, prima di decidersi ad andare a vedere di che si tratta.
Scostata la tenda, scopre Zunaira distesa sopra una stuoia, le
ginocchia contro il ventre, voltata verso il muro. È sicuro che non
stia dormendo, ma non osa disturbarla. Arretra senza far rumore,
infila un abito e un paio di sandali, spegne la candela ed
esce in strada. Un caldo umido opprime il quartiere. Qua e là,
degli uomini chiacchierano davanti a qualche portone o ai piedi di
qualche muro. Mohsen non ritiene necessario allontanarsi da casa.
Si siede sulla soglia, si mette a braccia conserte e cerca una
stella nel cielo. In quel preciso momento un uomo sbuca davanti a
lui come una belva e divora la viuzza con passo stizzito. Il
riflesso di un raggio di luna ne illumina il volto incartapecorito;
Mohsen riconosce il carceriere che poco prima, sulla soglia del
chiosco, stava per sferzargli il viso con lo scudiscio.
CAPITOLO 5
Atiq Shaukat torna alla moschea per seguire la
preghiera di El Icha, da cui sarà l'ultimo a rialzarsi. Passerà
lunghi minuti, le mani aperte in una fatiha, a recitare versetti e
a chiedere ai santi e agli antenati di assisterlo nella sua
"disgrazia". Costretto dalle vecchie ferite al ginocchio a
interrompere le prosternazioni, si sprofonda in un angolo ingombro
di libri religiosi e cerca di leggere. Non riesce a concentrarsi. I
testi si confondono sotto i suoi occhi e minacciano di fargli
scoppiare la testa. Ben presto, il caldo torrido del santuario lo
costringe a raggiungere i gruppi di fedeli sparpagliati nel
cortile. I vecchi e i mendicanti sono scomparsi, ma gli invalidi di
guerra sono ancora lì, a esibire le loro infermità come trofei. Il
mutilato troneggia nella sua carriola, seguendo con attenzione i
racconti dei suoi compagni, pronto ad assentire o a protestare. Il
Golia è tornato; seduto accanto a un monco, ascolta ossequiosamente
un vecchio raccontare come fosse riuscito a immobilizzare un'intera
compagnia di carri sovietici con un pugno di mujaheddin armati di
un solo fucile mitragliatore.
Atiq non sopporta per molto l'enormità di quelle gesta. Lascia la
moschea e vaga per le periferie devastate, ricorrendo di tanto in
tanto allo scudiscio per respingere i mendicanti più
ostinati. Senta accorgersene, si ritrova di fronte alla prigione,
entra. Il silenzio delle celle lo placa. Decide di passarvi la
notte. Cerca a tastoni la lanterna, l'accende e si allunga sulla
branda, le mani sotto la nuca e gli occhi rivolti al soffitto. Ogni
volta che i suoi pensieri lo riportano dinanzi a Mussarat, sferra
un calcio nel vuoto, come per sbarazzarsene. Un'ondata dopo
l'altra, la collera torna a fargli pulsare il sangue alle tempie e
a comprimergli il petto. Se la prende con se stesso per non aver
osato togliersi il dente una volta per tutte e dire il fatto suo a
una moglie che dovrebbe ritenersi privilegiata in confronto a
quelle femmine private della loro natura che infestano le strade di
Kabul. Mussarat abusa della sua pazienza. La sua malattia non
rappresenta più un'attenuante; bisogna che inizi ad
accettarlo...
Un'ombra mostruosa oscura il muro. Atiq sussulta e afferra lo
scudiscio.
«Sono io, Zanish» lo rassicura una voce tremolante.
«Non ti hanno insegnato a bussare prima di entrare?» brontola Atiq,
furibondo.
«Ho le mani impegnate. Non volevo spaventarti.»
Atiq dirige la lanterna sul visitatore. È un uomo sulla sessantina,
alto come l'albero di una vela, le spalle curve, un collo grottesco
e una berretta informe sopra i capelli in disordine. Il viso
emaciato si allunga verso il mento, che una barbetta canuta
prolunga, mentre gli occhi a palla sembrano schizzargli fuori dalla
fronte come per effetto di un dolore atroce.
Rimane in piedi nel vano della porta, il sorriso incerto,
aspettando un cenno da parte del carceriere per venire avanti o
tornare indietro.
«Ho visto la luce» spiega. «Mi sono detto: "Il buon Atiq non sta
bene, devo andare a tenergli compagnia". Ma non sono venuto a mani
vuote. Ho portato un po' di carne affumicata e qualche bacca».
Atiq riflette un attimo, poi alza le spalle e accenna a una pelle
di pecora per terra. Fin troppo contento per essere stato accolto,
Zanish si sistema nel posto indicato, disfa un piccolo involto e
sciorina la propria generosità ai piedi del carceriere.
«Mi sono detto: "A casa hanno fatto arrabbiare Atiq. Non sarebbe
venuto a quest'ora in una prigione senza detenuti, se non avesse
avuto bisogno di schiarirsi le idee". Neppure io mi trovo bene a
casa mia. Quel centenario di mio padre non vuole mettere giudizio.
Ha perso la vista e l'uso delle gambe, ma ha conservato intatto il
suo malumore. Passa il tempo a prendersela con tutti. Prima, per
farlo stare zitto, gli davamo da mangiare. Ma adesso non c'è molto
da mettere sotto i denti, e siccome lui ha perso i suoi, nulla
trattiene più la sua lingua. A volte, inizia col chiedere silenzio,
ma poi è lui a non finirla più. Due giorni fa, non ha voluto
svegliarsi. Le mie figlie l'hanno scosso e asperso d'acqua: non si
è mosso. Gli ho preso il polso, non batteva. Ho appoggiato
l'orecchio sul suo petto, non respirava. Mi sono detto: "Be', è
morto, vado ad avvertire la famiglia e a preparargli un bel
funerale". Sono uscito per dare la notizia al vicinato, poi sono
andato a comunicare il decesso del decano della tribù ai cugini, ai
nipoti, ai parenti e agli amici. Ho passato la mattinata a ricevere
condoglianze e attestazioni di affetto. A mezzogiorno, torno a
casa. E chi trovo nel cortile a prendersela con il mondo intero?
Mio padre, in carne e ossa, vivo come le sue invettive, la bocca
spalancata sulle gengive biancastre. Credo che abbia perso la
testa. Non ci si può mettere a tavola né a letto, con lui. Non
appena vede passare qualcuno, gli salta addosso e trova qualche
rimprovero da muovergli. Ogni tanto, anch'io perdo la testa e mi
metto a urlargli contro. Interviene allora il vicinato e tutti
ritengono. che faccia torto al Signore perdendo la pazienza con mio
padre. Così, per non contrariare Dio, passo la maggior parte del
mio tempo fuori casa. Anche i pasti, li prendo per strada.»
Atiq scuote la testa. Tristemente. Anche Zanish non è più lo
stesso. L'ha conosciuto quand'era muftì a Kabul, dieci anni prima.
Non era tra i più rinomati, ma i suoi sermoni del venerdì
radunavano centinaia di fedeli. Viveva in una grande casa, con un
giardino e un portone in ferro battuto, qualche volta gli capitava
di essere invitato alle cerimonie ufficiali insieme ai notabili. I
suoi figli sono stati uccisi durante la guerra contro i russi, e
questo ne aveva aumentato la considerazione presso le autorità
locali. Sembrava non avere niente di cui lamentarsi e, a dire di
tutti, non aveva nemici. Viveva in modo relativamente decoroso,
tutto casa e moschea. Leggeva molto; la sua erudizione imponeva il
rispetto sebbene lo si andasse a cercare di rado. Poi,
inaspettatamente, fu visto un mattino percorrere gesticolando i
viali con gli occhi stralunati e la saliva alla bocca. Dapprima,
gli venne diagnosticata una possessione, contro la quale gli
esorcisti lottarono invano; poi, venne internato per alcuni mesi in
un ospedale psichiatrico. Non recuperò più integralmente le sue
facoltà. Ogni tanto, gli torna un barlume di lucidità, allora si
isola per nascondere la vergogna di quel che è diventato. Spesso
sta lì, sulla soglia di casa, seduto sotto un parasole scolorito a
guardare passare i giorni e la gente con la medesima
indifferenza.
«Sai cosa farò, Atiq?»
«Come posso saperlo? Non mi dici mai nulla.»
Zanish tende l'orecchio, poi, sicuro che nessuno può udirlo, si
china verso il carceriere e gli confida in un sussurro: «Me ne
vado...».
«Te ne vai dove?»
Zanish guarda verso la porta, trattiene il respiro e rimane in
ascolto. Per niente rassicurato, si alza, esce in strada per
verificare se ci sia qualcuno, poi torna dentro, le pupille
sfavillanti di una gioia demente.
«Che ne so. Me ne vado, punto e basta. Ho preparato fagotto,
bastone e denaro. Non appena il mio piede destro sarà guarito,
restituirò la tessera di razionamento, i documenti in mio possesso
e, senza dire grazie né addìo, me ne andrò. Prenderò una direzione
a caso e la seguirò fino all'oceano. E quando sarò in riva al mare,
mi butterò in acqua. Non tornerò più a Kabul. È una città dannata.
Non c'è salvezza. Troppa gente muore, le strade sono piene di
vedove e orfani.»
«E anche di talebani.»
Zanish si volta repentinamente verso la porta, spaventato
dall'osservazione del carceriere, poi il suo braccio famelico si
agita in un gesto pieno di disgusto e il collo gli si allunga di un
pollice quando impreca: «Prima o poi, quelli là avranno ciò che si
meritano».
Atiq annuisce. Raccoglie una fetta di carne affumicata e la scruta
perplesso. Zanish ne ingurgita due bocconi per dimostrargli che non
c'è nulla da temere. Atiq annusa ancora la fetta di carne prima di
rimetterla giù; sceglie un frutto e l'addenta con appetito.
«Quando sarà guarito il tuo piede?»
«Tra un paio di settimane al massimo. Dopo, senza dire niente a
nessuno, prendo su baracca e burattini e, pfui!, mai visto né
conosciuto. Camminerò fino a svenire, dritto davanti a me, senza
parlare a nessuno, senza neppure incontrare nessuno sulla mia
strada. Camminare, camminare, camminare finché la pianta dei miei
piedi non sia tutt'uno con la suola delle mie ciabatte.»
Atiq si lecca i baffi, coglie un secondo frutto, lo pulisce contro
il gilet e l'ingoia in un boccone.
«Dici sempre che te ne andrai, e sei sempre qua.»
«Mi fa male il piede.»
«Prima, era l'anca che ti faceva male, e prima dell'anca, era la
schiena, e prima della schiena, erano gli occhi. Sono mesi
che dici che te ne vai, e sei ancora qua. Come ieri, come domani.
Tu non andrai da nessuna parte, Zanish.»
«Sì, me ne andrò. Cancellerò le orme dei miei passi. Nessuno saprà
dove sono andato e neppure io saprò ritrovare la strada se mi
venisse voglia di tornare a casa.»
«Ma no» dice Atiq con l'evidente intenzione di risultare
sgradevole, come se contraddire quel povero diavolo lo vendicasse
di tutte le sue delusioni, «tu non te ne andrai. Resterai piantato
in mezzo al quartiere come un albero. Non perché siano le radici a
trattenerti, ma perché la gente della tua risma non sa avventurarsi
oltre la punta del proprio naso. Fantasticano di paesi lontani,
strade senza fine, spedizioni mirabolanti perché non potranno
realizzarle.»
«Come fai a saperlo?»
«Lo so.»
«Tu non puoi sapere cosa ci riserva il domani, Atiq. Solo Dio è
onnisciente.»
«Non c'è bisogno di consultare una sfera di cristallo per prevedere
quel che faranno domani i mendicanti. Domani, al sorgere del sole,
li ritroveremo allo stesso posto con la mano tesa e la voce che
pare un nitrito, esattamente come ieri e i giorni precedenti.»
«Io non sono un mendicante.»
«A Kabul siamo tutti mendicanti. E tu, Zanish, domani te ne starai
sulla soglia di casa tua, all'ombra del tuo fottuto parasole
bucato, ad aspettare che le tue figlie ti portino il tuo miserabile
pasto, che consumerai per terra.»
Zanish è rattristato. Non capisce perché il carceriere si ostini a
non ritenerlo in grado di prendere una iniziativa, di cui tutto
sommato tanta gente si mostra capace, e non sa come convincerlo.
Rimane in silenzio, poi tira verso di sé il suo modesto fagotto,
ritenendo che il carceriere non sia più degno della sua
generosità.
Atiq sogghigna e coglie apposta una terza bacca che mette da
parte.
«Prima, quando parlavo, venivo creduto» dice Zanish.
«Prima, la tua testa funzionava» ribatte il carceriere
intrattabile.
«Pensi che sia diventato matto?»
«Non sono il solo, purtroppo!»
Zanish scuote la testa, costernato. Con mano incerta, raccoglie il
fagotto e si alza.
«Vado a casa» dice.
«Ottima idea.»
Si trascina fino alla porta, la morte nell'anima. Prima di sparire,
confessa con voce atona: «È vero. Ogni notte dico che me ne vado, e
ogni giorno sono ancora qui. Mi chiedo cosa mi ci trattenga».
Uscito Zanish, Atiq si allunga di nuovo sulla branda e intreccia le
dita sotto la nuca. Visto che il soffitto della prigione non lo
distrae minimamente, si rimette a sedere e si prende le guance tra
le mani. Un fiume di rabbia gli monta alla testa. I pugni e le
mascelle contratti, si alza per tornare a casa, giurando a se
stesso di non avere più riguardi per la moglie se si ostina nel suo
atteggiamento da vittima espiatoria.
CAPITOLO 6
Mohsen Ramat tira il fiato. A quanto pare, la
notte ha sopito il malumore di Zunaira. Stamattina si è alzata di
buon'ora, rasserenata, gli occhi più seducenti che mai. Mohsen ha
pensato che forse aveva dimenticato il malinteso del giorno prima,
ma che poi se ne sarebbe ricordata e gli avrebbe tenuto ancora il
broncio. Zunaira non ha dimenticato; ha solo capito che suo marito
era disperato e aveva bisogno di lei. Volergliene per un gesto
irriflesso, antidiluviano, abominevole e insensato; un gesto
assurdo, ma indicativo di come vanno le cose in Afghanistan, un
gesto atroce che Mohsen rimpiange e subisce come un caso di
coscienza significherebbe renderlo ancora più fragile. A Kabul le
cose vanno di male in peggio, trascinando nella loro deriva gli
uomini e i costumi. È il caos nel caos, il naufragio nel naufragio,
e guai agli imprudenti. Chi è isolato è irrimediabilmente perduto.
L'altro giorno, un folle gridava a squarciagola per il quartiere
che Dio aveva fallito. Quel povero diavolo evidentemente ignorava
dove fosse e cosa ne fosse stato della sua lucidità. Inflessibili,
i talebani non hanno considerato la sua follia un'attenuante e
l'hanno fustigato a morte sulla pubblica piazza, gli occhi bendati
e la bocca imbavagliata.
Zunaira non è un talebano, e suo marito non è pazzo; se ha avuto un
attimo di smarrimento, nel mezzo di un'isteria collettiva, è
perché gli orrori quotidiani si rivelano più tremendi di ogni
presentimento e la degradazione umana più profonda degli abissi.
Mohsen sta allineandosi agli altri, imitando la loro disperazione,
si sta immedesimando nella loro regressione. Il suo gesto è la
prova che tutto può precipitare, inavvertitamente.
La notte è stata lunga per l'uno come per l'altra. Mohsen è rimasto
seduto sulla soglia fino alla chiamata del muezzin, pietrificato
nel proprio sgomento. Neppure Zunaira ha chiuso occhio.
Rannicchiata sulla stuoia, si è rifugiata in ricordi lontani,
quelli del tempo in cui, al posto dei patiboli che oggi deturpano
gli spiazzi polverosi, si levava al cielo il canto dei bambini. Non
che fosse festa tutti i giorni, ma nessun energumeno gridava al
sacrilegio quando gli aquiloni volteggiavano in aria. Certo, la
mano di Mohsen prendeva mille precauzioni prima di sfiorare quella
della sua egeria, ma questo non smorzava la passione che nutrivano
l'uno per l'altra. Le tradizioni erano quelle e bisognava
conviverci. Lungi dal contrariarli, la discrezione preservava il
loro idillio dal malocchio, intensificava i brividi che facevano
fremere i loro petti ogni volta che le loro dita riuscivano ad
aggirare i divieti alla ricerca di un magico tocco estatico. Si
erano conosciuti all'università. Lui, figlio di borghesi; lei,
figlia di notabili. Lui studiava scienze politiche e aspirava alla
carriera diplomatica; lei ambiva a diventare magistrato. Lui era un
ragazzo senza tante storie, devoto senza eccessi; lei era una
musulmana illuminata, indossava vesti dignitose, talvolta pantaloni
a sbuffo, il foulard in bella mostra, e militava attivamente per
l'emancipazione della donna. Il suo zelo era pari agli elogi che le
rivolgevano. Era una ragazza brillante. La sua bellezza esaltava
gli animi. I ragazzi non si stancavano di divorarla con gli occhi.
Tutti sognavano di sposarla. Ma era Mohsen il prescelto: si era
invaghita di lui fin dal primo sguardo. Lui era cortese e avvampava
più di una vergine quando lei gli sorrideva. Si erano sposati molto
giovani e molto in fretta, come se avessero intuito che il peggio
era già alle porte della città.
Mohsen non nasconde il proprio sollievo. Cerca anzi di mostrarlo
senza riserve davanti alla moglie, perché valuti fino a che punto
si strugga per lei non appena gli volta le spalle. Non sopporta che
gli tenga il broncio: è l'ultimo appiglio che lo tiene ancora
legato a questo mondo.
Zunaira non dice nulla. Ma il suo sorriso è eloquente. Non è il
largo sorriso che suo marito conosce, tuttavia è più che
sufficiente a renderlo felice.
Gli serve la colazione e si siede sullo sgabello imbottito, le mani
incrociate sulle ginocchia. I suoi occhi da uri inseguono una
voluta di fumo prima di posarsi su quelli del marito.
«Ti sei alzato molto presto» dice.
Lui sussulta, sorpreso nell'udire che gli rivolge la parola come se
niente fosse. La sua voce è dolce, quasi materna; ne deduce che la
pagina è stata voltata.
Mohsen inghiotte tutto di un fiato il boccone di pane, rischiando
di strozzarsi. Si asciuga la bocca con un fazzoletto e confida:
«Ero andato alla moschea»
Lei inarca le magnifiche sopracciglia. «Alle tre di notte?»
Lui deglutisce ancora per schiarirsi la voce, cerca un argomento
plausibile e azzarda: «Non avevo sonno, così sono uscito a prendere
aria sulla soglia di casa».
«È vero, ha fatto molto caldo, stanotte.»
Entrambi concordano nel riconoscere che l'umidità e le zanzare sono
particolarmente sgradevoli in questi ultimi giorni. Mohsen aggiunge
che quasi tutti i vicini si erano precipitati in strada per
sfuggire a quelle fornaci delle loro topaie, che alcuni sono
rientrati in casa solo all'aurora.
La conversazione verte sul tempo inclemente, sulla siccità che da
anni imperversa in Afghanistan e sulle malattie che piombano
addosso alle famiglie come falconi impazziti. Parlano di tutto e di
niente senza fare alcuna allusione al malinteso del giorno prima né
alle esecuzioni pubbliche che tendono a diventare una routine.
«E se andassimo a fare un giro al mercato?» propone Mohsen.
«Non abbiamo un soldo.»
«Non siamo obbligati a comprare. Ci accontenteremo di dare
un'occhiata al mucchio di anticaglie che fanno passare per
antiquariato.»
«A cosa ci servirà?»
«Non a molto, ma ci farà camminare.»
Zunaira sorride, divertita dal patetico humour del marito.
«Non ti trovi bene qui?»
Mohsen fiuta la trappola. Con gesto imbarazzato, si gratta la
peluria ribelle sulle guance, abbozzando una piccola smorfia. «Non
c'entra niente. Ho voglia di uscire con te. Come ai vecchi
tempi.»
«I tempi sono cambiati.»
«Noi no.»
«E noi chi siamo?»
Mohsen si addossa al muro e si mette a braccia conserte. Cerca di
meditare sulla domanda della moglie, ma la trova eccessiva. «Perché
dici sciocchezze?»
«Perché è la verità. Noi non siamo più niente. Non abbiamo saputo
preservare quel che avevamo acquisito, e gli apprendisti mullah ce
l'hanno requisito. Mi piacerebbe uscire con te, tutti i giorni,
tutte le sere, fare scivolare la mia mano sotto il tuo braccio e
lasciarmi trasportare dalla tua falcata. Sarebbe meraviglioso, io e
te, in piedi l'uno contro l'altra, davanti a una vetrina oppure
attorno a un tavolo, a chiacchierare e architettare progetti
mirabolanti. Ma adesso non è più possibile. Ci sarà sempre un
fetido spaventapasseri, armato fino ai denti, che ci richiamerà
all'ordine e ci impedirà di parlare all'aria aperta. Piuttosto che
subire un tale affronto, preferisco murarmi viva in casa mia. Qui,
almeno, quando lo specchio riflette la mia immagine, non debbo
ripararmi dietro le mie braccia.»
Mohsen non è d'accordo. Prolunga la smorfia, indica la povertà
della stanza, le tende ormai logore che nascondono le imposte
putrescenti, le pareti senza più intonaco e le travi pericolanti
sulla testa.
«Non siamo a casa nostra, Zunaira. La nostra casa, dove avevamo
creato il nostro mondo, è stata spazzata via da una granata. Questo
è solo un rifugio. Non voglio che diventi la nostra tomba. Abbiamo
perduto il nostro patrimonio; non perdiamo le nostre buone maniere.
Il solo modo di combattere che ci è rimasto per rifiutare
l'arbitrio e la barbarie è di non rinunciare alla nostra
educazione. Siamo stati fatti crescere come esseri umani, con un
occhio rivolto al Signore e l'altro ai mortali che noi siamo;
abbiamo visto abbastanza da vicino lampadari e lampioni per non
credere alla sola luce delle candele, abbiamo gustato le gioie
della vita e le abbiamo trovate buone quanto le gioie eterne. Non
possiamo accettare che ci assimilino alle bestie.»
«Non è forse ciò che siamo diventati?»
«Non ne sarei così sicuro. I talebani hanno approfittato di un
attimo di confusione per assestare un colpo terribile ai vinti. Ma
non è il colpo di grazia. È nostro dovere convincercene.»
«E come?»
«Sfidando i loro diktat. Usciremo, Tu e io. Certo, non ci
prenderemo per mano, ma nulla ci impedisce di camminare fianco a
fianco.»
Zunaira scuote la testa. «Non ci tengo a tornare a casa con un
cuore gonfio così, Mohsen. Quel che vedremo per strada guasterà
inutilmente la mia giornata. Non sono capace di passare davanti a
qualcosa di orribile e fare come se niente fosse. E poi mi rifiuto
di portare il burqa. Di tutti i basti, questo è il più avvilente.
Una tunica di Nesso non lederebbe la mia dignità quanto questa
funerea infagottatura che mi reifica cancellando il mio volto e
confiscando la mia identità. Qui, almeno, sono io, Zunaira, moglie
di Mohsen Ramat, trentadue anni, magistrato licenziato
dall'oscurantismo, senza processo e senza indennità, ma con
sufficiente presenza di spirito per pettinarmi tutti i giorni e
badare alla mia toilette come alle pupille dei miei occhi. Invece,
sotto quel velo maledetto, non sono un essere umano né una bestia,
tutt'al più un affronto o un obbrobrio che si deve nascondere come
una infermità. È troppo duro da accettare. Soprattutto per una ex
avvocato, nonché militante femminista. Ti prego, non pensare che
faccia la preziosa. D'altra parte, mi piacerebbe farlo, ma
purtroppo mi manca il cuore. Non chiedermi di rinunciare al mio
nome, ai tratti del mio viso, al colore dei miei occhi e alla forma
delle mie labbra per una passeggiata attraverso la miseria e la
desolazione; non chiedermi di essere da meno di un'ombra, un
anonimo fruscio lanciato in un loggione ostile. Sai quanto sono
permalosa, Mohsen; mi rattristerebbe volertene mentre tu cerchi
solo di farmi piacere.»
Mohsen alza le mani. A un tratto, Zunaira prova pena per quell'uomo
che non riesce più a trovare la sua collocazione in una società
completamente sottosopra. Già prima dell'avvento dei talebani,
mancava di slancio e si accontentava di attingere al proprio
patrimonio piuttosto che spendersi in progetti impegnativi. Non che
fosse pigro, ma aborriva le difficoltà e non voleva complicarsi la
vita. Viveva di rendita ma senza sfarzo, era un ottimo marito,
affettuoso e pieno di premure. Non le faceva mancare niente, non le
rifiutava mai nulla e cedeva così facilmente alle sue richieste che
spesso lei aveva la sensazione di abusare della sua gentilezza. Era
così, il cuore in mano, pronto più a dire sì che a porsi problemi.
Il molteplice sconvolgimento provocato dai talebani l'ha
completamente destabilizzato. Mohsen non ha più punti di
riferimento, né la forza per inventarsene altri. Ha perso:
patrimonio, privilegi, parenti e amici. Ridotto al rango
d'intoccabile, vegeta alla giornata, rinviando a più tardi la
promessa di riprendere in mano la propria vita.
«Bène,» concede Zunaira «d'accordo, usciamo. Preferisco correre
mille rischi piuttosto che vederti così abbattuto.»
«Non sono abbattuto, Zunaira. Sé vuoi restare a casa, va benissimo.
Ti assicuro che non te ne voglio. Hai ragione. Le Strade di Kabul
sono odiose. Non si sa mai cosa ci aspetta.»
Zunaira sorride alle parole del marito che contrastano così
nettamente con la sua aria avvilita.
«Vado a cercare il mio burqa» dice.
CAPITOLO 7
Atiq Shaukat si fa ombra agli occhi con la mano.
La canicola ha ancora parecchi giorni davanti a sé. Non sono ancora
le nove e il sole, implacabile, martella come un fabbro su tutto
ciò che si muove. I carrettieri e i furgoni convergono verso il
mercato principale della città, i primi carichi di cassoni
semivuoti o di prodotti ortofrutticoli appassiti, i secondi di
passeggeri pigiati gli uni sugli altri come sardine. La gente
zoppica per i vicoli, raschiando con i sandali il suolo polveroso.
Velo opaco e passo da sonnambulo, sparute greggi di donne rasentano
i muri, guardate a vista da maschi impacciati. E poi, ovunque,
sulla piazza, sulle carreggiate, in mezzo alle vetture e intorno
alle bettole, centinaia di mocciosi dalle narici verdastre e lo
sguardo tagliente, abbandonati a se stessi, che si reggono a
malapena sulle gambe e sono già inquietanti, intrecciano in
silenzio la corda di canapa con la quale, un bel giorno,
impiccheranno senza indugio l'ultima salvezza della nazione. Atiq
prova sempre un profondo malessere ogni volta che li vede invadere
inesorabilmente, la città, simili a quelle mute di cani che vengono
non si sa da dove e che, dai bidoni alle discariche, finiscono con
il colonizzare la città e tenere a bada la popolazione. Le
innumerevoli scuole coraniche, che spuntano come funghi a
ogni angolo di strada, non bastano più a contenerli. Ogni giorno,
il loro numero aumenta e si fanno sempre più minacciosi, ma a Kabul
nessuno se ne preoccupa. Per tutta la vita, Atìq ha rimpianto che
Dio non gli abbia dato dei figli, ma da quando le strade ne
rigurgitano si ritiene fortunato. A cosa serve circondarsi di
marmocchi per poi vederli morire poco a poco o finire come carne da
cannone, vittime di chi si crogiola in una guerra senza fine, nella
quale s'identifica?
Persuaso che la sua sterilità sia una benedizione del cielo, Atìq
schiocca lo scudiscio sulla coscia e marcia dritto verso il centro
città.
Zanish sonnecchia al riparo del suo parasole, il collo storto.
Viene da credere che abbia trascorso la notte lì, sulla soglia di
casa, seduto per terra alla turca. Vedendo arrivare Atiq, fa finta
di dormire. Atiq gli passa davanti senza dire niente. Fatti una
trentina di passi, si ferma, soppesa il prò e il contro e torna
indietro. Zanish, che lo spiava con la coda dell'occhio, stringe i
pugni e si rattrappisce ulteriormente nel suo angolo. Atiq gli si
pianta di fronte a braccia conserte, poi si accovaccia e, con la
punta del dito, si mette a tracciare figure geometriche nella
polvere.
«Ieri sera sono stato maleducato» riconosce. Zanish stringe le
labbra per accentuare l'aria da cane bastonato.
«Eppure, non ti avevo fatto niente.»
«Ti chiedo scusa.»
«Bah!»
«Sì, davvero. Mi sono comportato molto male con te, Zanish. Sono
stato cattivo, ingiusto e stupido.»
«Ma no, sei stato soltanto un po' sgradevole.»
«Me la prendo con me stesso.»
«Non è necessario.»
«Mi perdoni?»
«Questo va da sé, via. E poi, a essere sinceri, me lo sono
meritato. Avrei dovuto riflettere un momento prima di venire a
disturbarti. Eri lì, in una prigione vuota, in cerca di
tranquillità per pensare ai tuoi problemi a mente fredda. E io
sbarco, senza alcun preavviso, a parlare di cose che non ti
riguardano. Colpa mia. Non dovevo disturbarti.»
«È vero, avevo bisogno di stare da solo.»
«Allora, sei tu che devi perdonarmi.»
Atiq tende la mano. Zanish l'afferra premuroso, trattenendola a
lungo nella sua. Senza mollare la presa, si guarda intorno per
essere sicuro che la strada sia sgombra; si raschia In gola e bela
con voce quasi impercettibile, tanto grande è l'emozione: «Pensi
che un giorno potremo sentire della musica a Kabul?».
«Chissà.»
La morsa del vecchio si accentua, il collo scarno si tende per
prolungarne il lamento: «Ho voglia di sentire una canzone. Non
immagini quanto. Una canzone con accompagnamento musicale e una
voce che ti scuota dalla testa ai piedi. Pensi che un giorno, o una
sera, potremo accendere la radio e ascoltare le orchestre fondersi
insieme fino a svenire?».
«Dio solo è onnisciente.»
Gli occhi del vecchio, per un attimo annebbiati, prendono a
luccicare per un lampo di dolore che pare risalire dal più profondo
del suo essere. Dice: «La musica è il vero soffio vitale. Si mangia
per non morire di fame. Si canta per sentirsi vivere. Capisci,
Atiq?».
«In questo momento, la mia testa non funziona del tutto.»
«Quando ero bambino, spesso mi capitava di non trovare nulla da
mettere sotto i denti. Non era grave. Mi bastava sedermi sopra un
ramo e soffiare nel mio flauto per placare i brontolii dello
stomaco. E quando cantavo, puoi non credermi se vuoi, stavo
benissimo.»
I due uomini si guardano. Il viso teso come un crampo. Alla fine,
Atiq ritrae la mano per alzarsi.
«arrivederci, Zanish.»
Il vecchio annuisce. Proprio quando il carceriere sta per
andarsene, lo trattiene per la falda della camicia.
«Eri sincero, ieri, Atiq? Pensi davvero che non me ne andrò mai,
che resterò piantato qui come un albero e non vedrò mai l'oceano né
i paesi lontani né l'ultimo orizzonte?»
«È chiedermi troppo.»
«Voglio che tu me lo dica in faccia. Tu non sei un ipocrita, non ti
curi della suscettibilità degli altri quando spiattelli loro in
faccia la verità. Non ho paura, e non te ne vorrò. Devo saperlo una
volta per tutte: pensi che un giorno lascerò questa città?»
«Sì, certo... Con i piedi in avanti.»
Detto ciò, si allontana schioccando lo scudiscio contro il
fianco.
Avrebbe potuto risparmiare il vecchio, dice fra sé e sé, e fargli
credere che, sebbene impossibile, la speranza era permessa. Non
capisce cosa gli abbia preso né perché, di punto in bianco, il
maligno piacere di angosciare ulteriormente quel povero diavolo
abbia prevalso sul resto. Tuttavia, l'irresistibile bisogno di
guastare in due parole ciò che quello implora in cento lo
impensierisce, come un prurito: se anche si grattasse a sangue non
vorrebbe liberarsene... Ieri, rientrando a casa, ha trovato
Mussarat addormentata. Senza sapere perché, ha rovesciato apposta
uno sgabello, sbattuto le imposte della finestra e si è messo a
letto solo dopo aver recitato ad alta voce versetti interminabili.
Al mattino, si è reso conto di quanto fosse stato sgarbato. E
tuttavia, pensa, se questa sera trovasse ancora sua moglie
addormentata, si comporterebbe allo stesso modo.
Prima, Atiq non era così. È vero, non passava per una persona
affabile, ma non era neppure cattivo. Troppo povero per essere
generoso, non esagerava astenendosi dal donare con la manifesta
intenzione di non aspettarsi nulla in cambio. In questo modo, non
esigendo niente da nessuno, non si sentiva in debito né in obbligo.
In un paese dove i cimiteri rivaleggiano in estensione con le terre
incolte e i funerali prolungano i convogli militari, la guerra gli
ha insegnato a non legarsi troppo a esseri che un semplice sbalzo
di umore avrebbe potuto rapirgli. Atiq si era deliberatamente
chiuso nel suo bozzolo, al riparo da dispiaceri inutili. Ritenendo
di aver visto abbastanza per commuoversi sulla sorte del prossimo,
diffidava della propria sensibilità come di una vipera e limitava
il dolore del mondo alle proprie sofferenze. Tuttavia, negli ultimi
tempi, non si limita più a ignorare quel che lo circonda. A lui,
che si era ripromesso d'impicciarsi solo degli affari propri, non
ripugna più pensare alle delusioni altrui per lenire le proprie.
Senza accorgersene, ha sviluppato una strana aggressività,
imperiosa quanto insondabile, che sembra confarsi ai suoi stati
d'animo. Non vuole più trovarsi solo di fronte alle avversità;
anzi, cerca di dimostrare a se stesso che, aggravando quelle
altrui, sopporterebbe più facilmente il peso delle proprie
sventure. Del tutto consapevole del torto che infligge a Zanish, e
ben lungi dall'angustiarsene, lo assapora come una prodezza. È
questo il "maligno piacere"? Che importa, gli va bene così e, anche
se non gli riesce concretamente, ha la sensazione di non perderci
nel cambio. È come se si prendesse la rivincita su qualcosa che
continua a sfuggirgli. Da quando Mussarat si è ammalata, ha
l'intima convinzione che è stato ingannato, che i suoi sacrifici,'
le sue concessioni, le sue preghiere non sono servite a niente; che
il suo destino non si raddrizzerà mai, mai, mai...
«Dovresti consultare un cospiratore» l'apostrofa un vocione.
Atiq si volta. Mirza Shah è seduto allo stesso tavolo che occupava
il giorno prima, sulla terrazza del chiosco, intento a
sgranare il rosario. Spinge indietro il tocco sulla testa e
aggrotta la fronte. «Non sei normale, Atiq. Ti ho detto che non
volevo più vederti parlare da solo per strada. La gente non è
cieca. Ti prenderanno per uno scimunito e ti sguinzaglieranno
dietro i loro marmocchi.»
«Non ho ancora preso a strapparmi i vestiti di dosso» borbotta
Atiq.
«Di questo passo, non ci vorrà molto.»
Atiq alza le spalle e continua per la sua strada.
Mirza Shah si prende il mento fra le dita e scuote la testa.
Osserva il carceriere squagliarsela, sicuro di vederlo riprendere
la sua pantomima prima che sia giunto in fondo alla strada.
Atiq è furente. Gli sembra che gli occhi della città lo spiino, e
che Mirza Shah lo perseguiti. Allunga il passo per allontanarsi al
più presto, convinto che l'uomo seduto al tavolo sulla terrazza
alle sue spalle lo sorvegli, pronto a lanciargli rozze frecciate. È
talmente incollerito che, nello svoltare, investe una coppia, prima
urtando la donna e incespicando poi nel suo accompagnatore, che
deve addossarsi al muro per non cadere all'indietro.
Atiq raccoglie lo scudiscio, scosta l'uomo che fa per rialzarsi e
si affretta a scomparire.
«Un vero cafone» impreca Mohsen Ramat ripulendosi.
Zunaira spolvera l'orlo del suo burqa.
«Non si è neppure scusato» dice, divertita dal broncio del
marito.
«Ti sei fatta niente?»
«Tranne un leggero spavento, niente.»
«Bene, meglio così.»
Si rassettano l'infagottatura, lui con gesto irritato, lei
chiocciando sotto la maschera. Mohsen percepisce il riso soffocato
della moglie. Brontola per un attimo, poi, tranquillizzato dal
buonumore di Zunaira, scoppia a ridere anche lui. Improvvisamente,
un manganello si abbatte sulla sua spalla. «Pensate di essere al
circo?» gli urla un talebano sgranando gli occhi lattiginosi nel
viso riarso dalla canicola.
Mohsen cerca di protestare. Il manganello piroetta in aria e lo
colpisce al viso.
«Non si ride per strada» insiste lo sbirro. «Se vi resta un
briciolo di pudore, tornate a casa e chiudetevi a doppia
mandata.»
Mohsen freme di rabbia, la mano sulla guancia.
«Cosa c'è?» lo schernisce il talebano. «Vuoi cavarmi gli occhi?
Dai, fammi vedere di cosa sei capace, femminuccia!»
«Andiamo via» supplica Zunaira tirando il marito per il
braccio.
«Tu non toccarlo; stai al tuo posto» le urla lo sbirro sferzandole
l'anca. «E non parlare in presenza di un estraneo.»
Attirato dall'alterco, un gruppo di sbirri si avvicina, lo
scudiscio bene in vista. Il più alto si liscia la barba con aria
beffarda e chiede al collega: «Qualche problema?».
«Pensano di essere al circo.»
Quello alto fissa Mohsen.
«Chi è questa donna?»
«Mia moglie.»
«Allora, comportati da uomo. Insegnale a stare in disparte quando
discuti con una terza persona. Dove stai andando?»
«Accompagno mia moglie dai suoi genitori» mente Mohsen.
Lo sbirro lo squadra intensamente. Zunaira sente che le gambe non
la reggono più. È in preda al panico. Dentro di sé implora il
marito di tenere i nervi saldi.
«L'accompagnerai più tardi» decide lo sbirro. «Per il momento,
unisciti ai fedeli nella moschea laggiù. Il mullah Bashir terrà un
sermone tra meno di un quarto d'ora.»
«Ma vi dico che devo accompagnare...»
§Due scudisciate l'interrompono. Le riceve tutte e due insieme
sulla spalla.
«Ti dico che il mullah Bashir terrà un sermone tra dieci minuti...
e tu mi parli di accompagnare tua moglie dai suoi genitori. Ma
davvero, cos'hai nel cervello? Devo forse intendere che per te una
visita famigliare è più importante del sermone di uno dei nostri
più eminenti eruditi?»
Con la punta della frusta, gli solleva il mento in modo da
incontrarne lo sguardo, poi lo allontana, sprezzante.
«Tua moglie ti aspetterà qui, ai piedi di questo muro, in disparte.
L'accompagnerai più tardi.»
Mohsen alza le mani in segno di resa e, data un'occhiata furtiva in
direzione della moglie, si dirige verso un edificio tinteggiato di
verde e di bianco, intorno al quale altri miliziani intercettano i
passanti per obbligarli ad assistere al sermone del mullah
Bashir.
CAPITOLO 8
«Non vi è nessun dubbio» proclama il mullah Bashir
da sopra il suo gozzo.
Il suo dito da orco sciabola l'aria.
Si aggiusta il cuscino per sedersi comodamente, si dimena sul podio
cigolante che funge da tribuna, enorme e famelico, il viso tozzo
che sbuca dalla barba filamentosa.
Gli occhi vigili spazzano l'assemblea, brillando di una vivida
intelligenza, che mette soggezione.
«Nessun dubbio a questo riguardo, fratelli. È vero, com'è vero che
il sole sorge a oriente. Ho consultato le montagne, interrogato i
segni del cielo, l'acqua dei fiumi e del mare, i rami degli alberi
e le carreggiate delle strade; tutto mi ha confermato che l'Ora
tanto attesa è giunta. Dovete solo tendere l'orecchio per udire
ogni cosa su questa terra, ogni creatura, ogni fruscio attestare
che il momento della gloria è vicina, che l'imam El Mehdi è fra di
noi e i nostri cammini ne sono illuminati. Coloro che ne dubitano
anche per un istante non sono dei nostri. Il Demonio li possiede e
l'Inferno troverà nelle loro carni un combustibile inesauribile. Li
udirete rimpiangere per l'eternità di non aver saputo cogliere
l'opportunità che gli offrivamo su un vassoio d'argento:
l'opportunità di unirsi a noi per porsi definitivamente sotto le
ali del Signore.»
Con il dito batte un colpo secco sul palco. Di nuovo, il suo
sguardo incendiario abbraccia l'assemblea, pietrificata in un
silenzio siderale. «Potranno supplicarci per milioni di anni, noi
rimarremo sordi alle loro invocazioni come oggi loro lo sono alla
propria salvezza.»
Mohsen Ramat approfitta di un ondeggiamento nelle prime file per
sbirciare da sopra la spalla. Vede Zunaira che lo aspetta seduta
sulla scalinata esterna di un rudere di fronte alla moschea. Uno
sbirro le si avvicina, il fucile a tracolla. Lei si alza e indica
la moschea con mano tremante. Lo sbirro guarda nella direzione
indicata, annuisce e se ne va.
Il mullah Bashir tambureggia sul palco esigendo un'attenzione
costante. «Non vi è nessun dubbio. La Parola di giustizia risuona
ai quattro angoli della Terra. I popoli musulmani uniscono le loro
forze e le loro più intime convinzioni. Presto su tutta la Terra vi
sarà una sola lingua, una sola legge, un solo ordine: questo!»
esclama brandendo un Corano. «L'Occidente è morto, non esiste più.
Il modello che proponeva agli stolti è fallito. Cos'è mai questo
modello? Cos'è, esattamente, quello che spaccia per liberazione e
modernità? Forse le società amorali che ha creato, dove primeggia
il profitto e gli scrupoli, la pietà, la carità non contano niente,
dove i valori sono esclusivamente monetari, dove i ricchi sono dei
tiranni e i salariati dei forzati, dove l'impresa soppianta la
famiglia per isolare gli individui al fine di addomesticarli e poi
licenziarli senza tante formalità, dove la donna si compiace della
propria natura viziosa e gli uomini si sposano fra loro, dove si fa
mercato del corpo umano sotto gli occhi e il naso di tutti senza
suscitare la minima reazione e generazioni intere sono parcheggiate
in esistenze rudimentali fatte di emarginazione e povertà? È questo
il modello che lo rende così fiero e orgoglioso? No, miei cari
fedeli, non si costruiscono monumenti sulle sabbie mobili.
L'Occidente è fottuto, morto e sepolto, il suo fetore appesta lo
strato d'ozono. È un universo costruito sulla menzogna. Quel che
voi credete di discernere in lui, è solo illusione, un fantasma
ridicolo, sprofondato sulle macerie della propria inconsistenza.
L'Occidente è una soperchieria, un'enorme farsa che si sta
disgregando. Il suo pseudoprogresso è una fuga in avanti. Il suo
gigantismo apparente, una mascherata. Il suo zelo ne tradisce il
panico. Non ha scampo, è preso in trappola e farà la fine del topo.
Perdendo la fede, ha perduto la propria anima, e noi di certo non
l'aiuteremo a ritrovare né l'una né l'altra. Crede che la sua
economia sia in grado di proteggerlo; crede d'impressionarci con la
sua tecnologia di punta e intercettare le nostre preghiere con i
suoi satelliti; crede d'intimidirci con le sue portaerei e i suoi
eserciti di paccottìglia... ma dimentica che non s'impressiona chi
ha scelto di morire per la gloria del Signore e che, se anche i
radar non riescono a captare i suoi bombardieri furtivi, nulla
sfugge allo sguardo di Dio.»
Stizzito, picchia il pugno. «Chi oserebbe sfidare la collera di
Dio?»
Un sorriso vorace dischiude le sue labbra. Con le dita si asciuga
la schiuma ispessitasi agli angoli della bocca. Scuote la testa
lentamente, poi il suo dito torna a picconare il palco come se
volesse trapassarlo.
«Fratelli, noi siamo i soldati di Dio. La vittoria è la nostra
vocazione, il paradiso il nostro caravanserraglio. Se uno di noi
soccombe alle sue ferite, un drappello di uri, splendide come mille
soli, verrà a raccoglierlo. Non crediate che chi si è sacrificato
per la causa del Signore muoia; egli vive a fianco del suo Signore
che lo colma di favori... Quanto ai loro martiri, lasceranno il
calvario di questo mondo solo per la geenna eterna. I loro cadaveri
marciranno come carogne sui campi di battaglia e nella memoria dei
superstiti. Non avranno diritto né alla misericordia del Signore né
alla nostra pietà. Nulla ci impedirà di purificare la terra dei
credenti affinchè, da Giakarta a Gerico, da Dakar a Città del
Messico, da Khartum a San Paolo, da Tunisi a Chicago risuoni dai
minareti il grido di vittoria...»
«Alla.hu' akbar!» prorompe un compagno del mullah.
«Allahu' akbar!» vibra l'assemblea.
Zunaira sussulta quando il grido rimbomba nella moschea. Pensando
che la riunione sia terminata, raccoglie i lembi del burqa e
aspetta di vedere uscire i fedeli. Dal santuario non emerge
nessuno. Anzi, al contrario, gli sbirri continuano a intercettare i
passanti e a dirigerli, a furia di scudisciate, verso l'edificio
dipinto di verde e di bianco. La voce del guru tuona più di prima,
galvanizzata dalle sue stesse parole. Ogni tanto, sale così in alto
che i talebani, soggiogati, dimenticano di controllare i passanti.
Anche i bambini, stralunati e cenciosi, si sorprendono ad ascoltare
la predica prima di correre strillando verso i vicoli gremiti di
folla.
Devono essere le dieci, e il sole non si trattiene più. L'aria è
satura di polvere. Mummificata sotto il velo, Zunaira soffoca. La
rabbia le contorce le viscere e le strozza la gola. Il folle
desiderio di alzare il cappuccio alla ricerca di un improbabile
refolo di frescura accentua il suo nervosismo. Ma non osa neppure
asciugarsi il viso madido con un lembo del burqa. Come un'ossessa
stretta nella camicia di forza, rimane accasciata sulla scalinata,
a grondare sotto la calura e ad ascoltare il suo ansito accelerarsi
e il sangue batterle alle tempie. Improvvisamente, se la prende con
se stessa perché si trova lì, seduta sulla soglia di un rudere,
simile a un fagotto dimenticato, ad attirare l'incuriosito sguardo
dei passanti ora le sprezzanti occhiate dei talebani. Ha la
sensazione di essere un oggetto sospetto, esposto a ogni sorta
d'interrogativi, e questo la tortura. È sopraffatta dalla vergogna.
Il bisogno di scappare via, di tornare subito a casa e
sbattere la porta per non uscire mai più le attanaglia la mente.
Perché ha accettato di seguire suo marito? Cosa sperava di trovare
nelle vie di Kabul, se non misèria e oltraggi? Come ha potuto
accettare d'infilarsi quell'orrenda infagottatura che l'annienta,
quella tenda ambulante che è il simbolo della sua destituzione e
della sua prigionia, con quella maschera graticciata intagliata nel
viso come caleidoscopiche grate, con quei guanti che le impediscono
di riconoscere le cose al tatto e il peso dei soprusi? È accaduto
quello che temeva. Sapeva che la sua imprudenza l'avrebbe esposta a
ciò che detesta maggiormente e che rifiuta perfino quando dorme: la
degradazione. È una ferita incurabile, un'infermità da cui non si
guarisce, un trauma che né la rieducazione né le terapie riescono a
far superare, al quale non ci si può abituare senza sprofondare nel
disprezzo di sé. Questo disprezzo, Zunaira lo percepisce
chiaramente; fermenta in lei, le consuma le viscere e minaccia
d'immolarla. Lo sente crescere nel più intimo del suo essere, come
un rogo. Forse è per questo che gronda e soffoca sotto il burqa,
mentre la gola disseccata sembra riversarle nel palato come un
puzzo di cremazione. Una rabbia incoercibile le opprime il petto,
calpesta il suo cuore e le gonfia le vene del collo. Il suo sguardo
si offusca: sta per scoppiare in singhiozzi. Con uno sforzo
inaudito, inizia a contrarre i pugni per frenarne il tremito,
raddrizza la schiena e si concentra per disciplinare il respiro.
Lentamente reprime la propria rabbia, gradualmente fa il vuoto
dentro di sé. Deve sopportare la sua pena e resistere fino al
ritorno di Mohsen. Un gesto avventato, una protesta, e si
esporrebbe inutilmente allo zelo dei talebani.
Il mullah Bashir è molto ispirato, constata Mohsen Ramat.
Trascinato dalle proprie diatribe, sospende i suoi slanci solo per
picchiare sul palco o portare alle labbra incandescenti una
caraffa. Parla da due ore, veemente e gesticolante, la bava dello
stesso biancore degli occhi. Il suo respiro da bufalo, che vibra
nello stanzone, ricorda una scossa di terremoto. Nelle prime file,
i fedeli inturbantati non si rendono conto di trovarsi in una
fornace. Sono letteralmente soggiogati dalla prolissità del guru,
la bocca spalancata per non perdere nulla del fiotto di parole
dissetanti che casca loro addosso. Alle loro spalle, le opinioni
sono equamente divise: c'è chi impara e c'è chi si annoia. Molti
non sono contenti di trovarsi lì invece che badare alle proprie
occupazioni. Quelli non smettono di agitarsi e triturarsi le dita.
Un vecchio si è addormentato, un talebano lo scuote con la punta
del manganello. Risvegliatosi, il povero diavolo sbatte le palpebre
come se non riconoscesse il posto, si asciuga il viso con il palmo
della mano, poi, dopo uno sbadiglio, il collo da uccello gli si
affloscia e si riaddormenta. Da un pezzo, Mohsen ha perso il filo
del sermone. Le parole del mullah non lo raggiungono più.
Preoccupato, non smette di voltarsi verso Zunaira, laggiù,
dall'altra parte della strada, immobile sulla scalinata. Sa che sta
soffrendo sotto quel suo paramento, per il sole e per il fatto di
stare lì come un fenomeno da baraccone in mezzo ai curiosi, lei che
odia dare spettacolo. La guarda, sperando che lei lo veda in mezzo
a quell'accozzaglia d'individui dall'espressione grave e dal
silenzio incongruo, forse capisce quanto sia dispiaciuto della
piega che ha preso una semplice passeggiata in una città, dove le
cose si muovono freneticamente senza avanzare di un passo. Qualcosa
gli dice che Zunaira ce l'ha con lui. La sua rigidità è raccolta
come quella di una tigre ferita costretta a passare
all'attacco...
Una frusta sibila all'altezza della sua tempia. «Guarda avanti» gli
ricorda il talebano.
Mohsen annuisce e volta le spalle alla moglie. Con
dolore.
Terminata la predica, le pecorelle delle prime file si alzano in un
moto di giubilo e ruzzolano verso il guru per baciargli la mano o
la falda del turbante. Mohsen deve pazientare finché i talebani
autorizzano i fedeli a lasciare la moschea. Alla fine, quando
riesce a sottrarsi alla calca, Zunaira è stordita dal sole. Le
sembra che il mondo si sia oscurato, che i rumori intorno a lei
girino al rallentatore, e fatica a rialzarsi.
«Non ti senti bene?» le chiede Mohsen.
Lei trova la domanda così assurda che non la degna di una
risposta.
«Voglio tornare a casa» dice.
Cerca di riprendere i sensi, appoggiata al portone, poi, senza dire
una parola, si mette a camminare barcollando, la vista annebbiata e
la testa in fiamme. Mohsen cerca di sorreggerla, lei lo respinge
senza tanti complimenti.
«Non mi toccare» gli urla con voce straziata.
Mohsen riceve il grido della moglie con lo stesso dolore che gli
avevano inflitto, due ore prima, le due scudisciate abbattutesi
insieme sulla sua spalla.
CAPITOLO 9
Il conducente sterza violentemente il volante per
evitare un enorme masso sulla strada, in un modo o nell'altro si
porta sulla banchina. I freni malconci non riescono a rallentare la
corsa del grosso 4x4 che, nell'assordante stridio degli
ammortizzatori, rimbalza in una crepa del terreno prima di fermarsi
miracolosamente sul bordo del fosso.
Imperturbabile, Qassim Abdul Jabbar si limita a scrollare la
testa.
«Vuoi ammazzarci o cosa?»
Il conducente deglutisce notando che una delle ruote è a meno di
dieci centimetri dal baratro. Si asciuga con la falda del turbante,
biascica uno scongiuro, innesta la retromarcia e riporta indietro
la vettura.
«Da dov'è caduto questo fottutissimo masso?»
«Forse è un meteorite» ironizza Qassim.
Il conducente si guarda intorno per cercare un punto che spieghi
come quell'enorme masso sia potuto rotolare fino alla strada.
Alzando gli occhi sulla cresta più vicina, sorprende un vecchio
intento a inerpicarsi lungo i fianchi della collina.
Aggrotta la fronte. «Non è Zanish, quello lassù?»
Qassim segue lo sguardo del conducente.
«Mi stupirebbe.»
Il conducente socchiude le palpebre per concentrarsi sullo
straccione intento a scalare pericolosamente la collina. «Se non è
Zanish, dev'essere suo fratello gemello.» «Non preoccuparti di lui
e cerca di riportarmi a casa intero.» Il conducente annuisce e,
incorreggibile, lancia a tutta velocità il 4x4 sulla pista
accidentata. Prima di scomparire dietro un poggio da un'ultima
occhiata nello specchietto retrovisore, convinto che il vecchio in
questione sia proprio il sempliciotto che di tanto in tanto viene a
gironzolare intorno alla prigione dove bazzica Atiq Shaukat.
Sfinito, la gola in fiamme e le gambe a pezzi, Zanish si accascia
in cima alla cresta. Carponi, cerca di riprendere fiato, poi si
allunga sulla schiena e si abbandona alla vertigine. Il cielo a
portata di mano gli infonde una sensazione di rara leggerezza; ha
l'impressione di schiudersi come una crisalide, d'insinuarsi, spira
dopo spira, fra le maglie sfibrate del suo corpo. Rimane così,
steso a terra, il petto ansante e le braccia in croce. Quando il
respiro torna regolare, si rimette a sedere e si porta la borraccia
alla bocca. Adesso che ha vinto la montagna, nulla gli impedirà di
affrontare l'orizzonte. Si sente capace di camminare fino in capo
al mondo. Fiero della sua impresa, inimmaginabile per un uomo della
sua età, alza al cielo il pugno e lascia planare lo sguardo
vendicativo sopra quella vecchia strega di Kabul, ostinatamente
chiusa nei propri tormenti, che giace bocconi ai suoi piedi,
smembrata, irsuta, le mandibole rotte a furia di mordere la
polvere. Un tempo, la sua fama rivaleggiava con quella di
Samarcanda o di Baghdad e i suoi re, non appena saliti al trono,
immediatamente sognavano imperi più vasti del firmamento... Quel
tempo è passato, pensa Zanish indispettito, e non saranno i ricordi
a farlo tornare. Perché Kabul ha orrore del ricordo. Ha giustiziato
la propria storia sulla pubblica piazza, immolato i nomi delle vie
in terrificanti autodafé, polverizzato i monumenti a colpi di
dinamite e annullato i giuramenti che i suoi fondatori avevano
sottoscritto nel sangue nemico. Oggi, i nemici di Kabul sono i suoi
stessi figli. Hanno rinnegato i loro avi e si sono abbruttiti per
non assomigliare a nessuno," meno che mai a quegli esseri inferiori
che vagano spettrali tra il disprezzo dei talebani e l'anatema dei
guru.
A un tiro di schioppo, un varano troneggia sopra un masso, la lunga
coda al fianco come una sciabola. Decisamente, fra i predatori la
tregua genera gravi equivoci. Nella terra degli afghani, si può
appartenere alle tribù o alla fauna, si può essere nomadi o
guardiani del tempio, ma ci si sente vivi solo accanto a un'arma.
Anche il varano reale è sul chi va là: fiuta l'aria a caccia di
trappole. Ora, Zanish non vuole più sentire parlare di battaglie,
assedi, sciabole o fucili; non vuole più affidarsi allo sguardo
vendicativo dei mocciosi. Ha deciso di voltare le spalle al
frastuono delle mitragliatrici per andare a raccogliersi sulle
spiagge selvagge e vedere da vicino l'oceano. Vuole raggiungere il
paese che le sue utopie hanno partorito e che ha costruito con i
suoi sospiri, le sue preghiere, i suoi voti più fervidi; un paese
in cui gli alberi non muoiono di noia, in cui i sentieri viaggiano
come gli uccelli, in cui nessuno metterà in dubbio la sua
determinazione a percorrere le immutabili contrade da cui non farà
più ritorno. Raccoglie sette sassi. A lungo il suo sguardo sfida la
città in cui non ha più punti di riferimento. Improvvisamente,
stende il braccio e lancia lontano i suoi proiettili per
scongiurare la sorte e lapidare il Demonio sul suo cammino.
Il 4x4 beccheggia follemente sull'imprevedibile pista. Lo
sbandamento di poco prima non ha fatto rinsavire il conducente.
Qassim Abdul Jabbar si aggrappa alla portiera e porta pazienza. Da
quando hanno lasciato il villaggio tribale, il giovane autista ha
fatto di testa sua.
Visto che ha imparato a guidare facendolo, come quasi tutti i
combattenti, non si rende conto dei danni che arreca al veicolo.
Per lui, la docilità del mezzo si misura in funzione della velocità
che gli si strappa dalle viscere, come si fa con i ronzini. Qassim
si avvinghia al sedile e cerca di non badargli, certo che nessuna
argomentazione avrà ragione della sua caparbietà. Pensa alla tribù
che la guerra ha spogliato, alle vedove e agli orfani il cui numero
è diventato intollerabile, al bestiame decimato dall'inclemenza
delle stagioni, al villaggio distrutto, dove non ha ritenuto
necessario attardarsi. Se fosse per lui, non ci metterebbe più
piede. Ma è appena morta sua madre. È stata sepolta ieri. Arrivato
troppo tardi per il funerale, si è limitato a raccogliersi sulla
sua tomba. Qualche minuto in silenzio e un versetto sono stati
sufficienti. Poi, ha fatto scivolare una mazzetta di banconote nel
gilet di suo padre e ha ordinato al conducente di riportarlo a
Kabul.
«Potevamo restare fino a domani» dice l'autista come se leggesse
nei suoi pensieri.
«Perché?»
«Be', per riposarci. Non abbiamo nemmeno pranzato.»
«Non avevo niente da fare laggiù.»
«Eri dai tuoi.»
«E allora?
«E che ne so. Al posto tuo, me la sarei presa comoda. Da quante
settimane non torni al villaggio? Mesi e mesi, o forse anni.»
«Non mi trovo bene al villaggio.»
Il conducente annuisce, senza crederci troppo. Sorveglia il
passeggero con la coda dell'occhio, trovando che ha uno strano
atteggiamento, per uno che ha appena perso la madre. Affronta una
curva a tutta velocità e poi rilancia.
«Uno dei tuoi cugini mi ha raccontato che tua madre era una
santa.»
«Era una brava donna.»
«Ti mancherà?»
«Probabile, ma non vedo come. Era sordomuta. A dire la verità, di
lei mi rimarrà ben poco. E poi sono andato via che ero molto
giovane. A dodici anni correvo da una frontiera all'altra dietro la
mia ciotola di riso. Raramente tornavo all'ovile. Ogni tre ramadan.
Per questo non ho conosciuto la defunta come si doveva. Per me, era
la donna che mi aveva messo al mondo. Punto e basta. Ero il sesto
dei suoi quattordici figli, e il meno interessante. Imbronciato,
inawicinabile, le mani più leste della lingua, per me c'era troppa
gente in quella stamberga. E troppo poca ambizione. D'altra parte,
la defunta era di una discrezione sconcertante. Il vecchio amava
dire che l'aveva sposata perché non discutesse i suoi ordini. E
scoppiava a ridere a crepapelle. Un vero burlone, il vecchio.
Spilorcio, ma per nulla esigente né cattivo. Del resto, non aveva
motivo di esserlo. Le rare scenate si svolgevano in silenzio e lo
divertivano più di quanto lo facessero uscire dai gangheri...»
I ricordi riempiono il suo sguardo di un remoto bagliore. Tace
sporgendo le labbra. Non è triste; più che altro deluso, come se i
ricordi lo disturbassero. Dopo un lungo silenzio, si raschia la
gola e aggiunge voltandosi tutto sulla sinistra: «Forse era una
santa. Tutto sommato, perché no? Non udiva né proferiva
ingiurie».
«Una beata, allora.»
«Comunque, non fino a questo punto. Era una persona tranquilla,
senza tante storie e senza inimicizie. Per me, incarnava il suo
sorriso, sempre lo stesso, largo quando era contenta, tirato quando
la contrariavano. Se sono andato via troppo presto, è stato proprio
per questo. Con lei, mi sembrava di parlare al muro.»
Il conducente sporge la testa fuori del finestrino per sputare.
La saliva piroetta nella polvere prima di ricadérgli sulla barba.
Si asciuga con il dorso della mano e dice, in tono stranamente
allegro: «Non ho conosciuto mia madre. È morta mettendomi al mondo.
Aveva quattordici anni, il vecchio faceva pascolare il gregge a due
passi. Era appena pubere. Perso nelle sue bambinate. Quando mia
madre ha iniziato a gemere, non si è fatto prendere dal panico.
Invece di avvisare i vicini, ha voluto cavarsela da solo. Come un
adulto. Ben presto, la faccenda ha preso una brutta piega. Lui si è
intestardito. Ed ecco. Ignora come io sia sopravvissuto; peggio,
non capisce perché mia madre gli sia morta fra le mani. Ancora ci
pensa, dopo tanti anni e quattro matrimoni... Mia madre ha molto
sofferto prima di rendere l'anima. Io non l'ho conosciuta, e
tuttavia è sempre qui, al mio fianco. Ti giuro che, ogni tanto,
sento il suo respiro sul mio viso. È il mio terzo matrimonio in
meno di un anno».
«Per causa sua?»
«No, le mie due prime mogli erano ribelli. Non erano dinamiche e
facevano troppe domande.»
Qassim non vede il nesso. Rovescia la nuca sullo schienale e fissa
la plafoniera. Dopo una curva, Kabul!... rannicchiata in mezzo ai
viali devastati, simile a una tragica farsa e, in disparte, come un
rapace in attesa della selvaggina data in pasto ai cani, la tetra
prigione di Pul-e-Charki. Gli occhi di Qassim s'illuminano di uno
strano bagliore. Se non perde occasione di accompagnare i
malcapitati al patibolo è proprio per attirare su di sé
l'attenzione dei mullah. È stato un ottimo combattente. La sua
reputazione di miliziano è encomiabile. Un giorno, a forza di
perseveranza e dedizione, finirà con l'ottenere che i governanti lo
nominino direttore di quella fortezza, ossia del più importante
penitenziario del paese. Potrà così entrare nei ranghi dei
notabili, allacciare relazioni e buttarsi negli affari. Solo allora
assaporerà il riposo del guerriero.
«A quest'ora sarà in paradiso?»
«Chi?» sussulta Qassim.
«Tua madre.»
Qassim squadra il conducente che sembra un po' toccato.
Quest'ultimo gli sorride guidando maldestramente in mezzo a un
intrico di solchi. In quel mentre, la curva volta le spalle alla
città e la fortezza di Pul-e-Charki scompare dietro una cava di
arenaria.
Più in basso, molto più in basso, lì dove la valle si tuffa nelle
ingannevoli acque del miraggio, una squadra di cammelli risale la
scarpata. Ancora più in basso, in piedi in mezzo a un cimitero,
Mohsen Ramai scruta la montagna percorsa dallo scintillio di un
grosso 4x4. Tutte le mattine viene qui a contemplare le vette
taciturne, senza però osare scalarle. Da quando Zunaira si è
barricata dietro un opprimente mutismo, non sopporta più la
promiscuità. Non appena esce di casa, si affretta a raggiungere il
vecchio cimitero e si isola per ore, al riparo dai bazar infestati
di imbonitori e di zelanti miliziani. E tuttavia, sa che la sua
ascesi non lo porterà lontano. Non c'è niente da vedere, tranne
l'abbandono, e niente da sperare. Tutt'intorno, l'aridità supera se
stessa. Sembra che si denudi solo per accentuare lo sgomento degli
uomini incastrati fra le pietraie e la canicola. Le rare strie di
verde, che ardiscono manifestarsi qua e là, non promettono nessuna
fioritura; le erbe disseccate si sbriciolano al minimo stormire.
Gigantesche idre disidratate, i fiumi languono nei loro letti
sfatti, potendo offrire agli dèi dell'insolazione solo le loro
viscere pietrificate. Cosa viene a cercare in mezzo a queste tombe
grottesche, ai piedi di queste montagne taciturne?...
Il grosso 4x4 sbuca al cimitero con un'impressionante nube di
polvere alle calcagna. Qassim da un'occhiata al giovane avvilito
che vaga in mezzo ai morti. È lo stesso tizio che aveva
intravisto la mattina, quando correva verso il villaggio natio. Per
un attimo lo squadra ben bene, chiedendosi cosa mai potesse
trattenerlo, tutto il giorno, in un cimitero deserto e sotto un
sole di piombo.
Il conducente si rilassa e alza il piede dall'acceleratore, mentre
affronta i primi vicoli della città. La vista dei gruppoli di
vecchi ammonticchiati all'ombra delle palizzate e delle sfilze di
mocciosi lo rinfranca. È contento di tornare a casa.
«Per essere una gita, è stata una vera gita» ammette salutando con
la mano qualcuno di sua conoscenza in mezzo alla calca. «Ore e ore
a spaccarsi la schiena sulle gobbe della strada e a inghiottire
schifezze di ogni genere.»
«Smettila di frignare» impreca Qassim.
«Quando avrò spento il motore, non prima» s'impunta l'autista
facendo una smorfia ridicola. «Che si fa? Ti deposito a casa
tua?»
«Non subito. Ho bisogno di rinfrescarmi le idee. Visto che non
smetti di rompermi i timpani con il tuo digiuno forzato, che ne
diresti di andare a smangiucchiare degli spiedini da Khorsan?
Invito io.»
«Ti avverto che mangio per quattro.»
«Non mi fa paura.»
«Sei un principe generoso, padrone. Grazie a te, mi abbufferò fino
a scoppiare.»
La taverna di Khorsan si trova all'angolo di una piazza devastata,
di fronte a una stazione delle corriere. Il fumo del barbecue
contende i rari refoli d'aria della piazzetta ai tornado che i
veicoli sollevano al loro passaggio. Pochi clienti, fra cui Atiq il
carceriere, occupano i rudimentali tavolacci affiancati sotto una
volta di vimini; indifferenti al sole e alle squadriglie di mosche,
reagiscono solo per respingere i monelli affamati, stuzzicati
dall'odore della carne ai ferri. Il ventre sulle ginocchia e la
barba fino all'ombelico, Khorsan ravviva la brace con un ventaglio.
Con l'altra mano rivolta i quarti di carne sul fuoco e si lecca i
baffi, quando verifica che la carne è cotta a puntino. Il 4x4 che
si ferma di fronte a lui non lo distrae minimamente. Rivolge solo
il ventaglio verso la polvere che l'avvolge tutto, senza perdere di
vista le cotolette che sfrigolano. Qassim gli mostra quattro dita
sedendosi su una panca tarlata; Khorsan registra l'ordinazione con
un cenno del capo e prosegue meticolosamente il suo rituale.
Atiq consulta l'orologio. La sua impazienza è evidente, ma è
soprattutto l'arrivo di Qassim Abdul Jabbar ad accentuare il suo
nervosismo. Cosa penserà sorprendendolo lì, in una taverna a due
passi da casa? Incassa il collo nelle spalle e s'imbosca dietro la
mano finché un cameriere non gli porta un enorme sandwich avvolto
in carta da pacchi. Atiq lo fa scivolare in una busta di plastica,
deposita alcune banconote sul tavolo e batte in ritirata senza
aspettare il resto. Proprio quando crede di essersi tratto
d'impaccio, lo raggiunge la mano di Qassim.
«È da me che scappi, Atiq?»
Il carceriere finge di cascare dalle nuvole.
«Già di ritorno?»
«Perché te ne vai così, all'inglese? Ti ho fatto qualcosa?»
«Non ti seguo.»
Qassim scrolla la testa, deluso: «Vuoi che te lo dica, Atiq? Non ti
comporti bene. No, per favore, non è il caso di protestare. Non è
necessario, ti assicuro. Non ti sto facendo la predica. Solo che,
ecco, ti trovo molto cambiato negli ultimi tempi, e questo mi
dispiace. Di solito, mi faccio gli affari miei, e tuttavia non
riesco a fregarmene. Forse è a causa dei lunghi anni passati
insieme, qualche volta nella buona, più spesso nella cattiva sorte.
Non ci tengo a immischiarmi in cose che non mi riguardano, però
nulla m'impedisce di farti notare che, a furia di rinchiuderti a
doppia mandata nelle tue preoccupazioni, finirai per non uscirne
più».
«Non è niente. Ogni tanto mi prende la malinconia, tutto qua.»
Qassim non gli crede e neppure lo nasconde. Si china verso di lui.
«Hai bisogno di soldi?»
«Non so che farmene.»
Il miliziano si gratta la fronte per riflettere. Propone: «Perché
non vieni a trovarci, la sera, da Haji Palwan? Saremo tra amici. Si
beve té, si chiacchiera, si parla di eserciti e scaramucce e si
ride dei guai di un tempo. Ti farà bene, te lo prometto. Saremo in
compagnia, molto rilassati. Se hai qualche progetto, lo discuteremo
insieme per trovare dei soci e darci da fare subito dopo.
Organizzare un affare non è difficile. Un po' d'immaginazione, uno
straccio di motivazione e la locomotiva è pronta sui binari. Se non
hai soldi, te li presteremo e ce li restituirai dopo».
«Non si tratta di soldi» dichiara stancamente Atiq. «È un miraggio
che non mi abbaglia.»
«Nemmeno t'illumina, a quel che vedo.»
«Il buio non mi dispiace.»
«È da vedere. Per parte mia, ci tengo solo a dirti che non c'è
niente di male ad andare a trovare, ogni tanto, un amico quando non
si sta bene.»
«Ti manda Mirza Shah?»
«Lo vedi? Ti sbagli su tutta la linea. Non ho bisogno di Mirza Shah
per tendere la mano a un collega che stimo.»
Atiq osserva la sua busta, sporgendo le ossa della nuca. Con la
punta del piede, dissotterra un sasso e inizia a scavare una buca
nella polvere.
«Posso andarmene?» chiede con voce strozzata.
«Ma certo, che idea!»
Atiq lo ringrazia con un cenno del capo e se ne va.
«C'era un erudito a Jalalabad» gli racconta d'improvviso Qassim
seguendolo passo passo. «Un sapiente fuori del comune. Aveva una
risposta per tutto. Non gli sfuggiva nessun riferimento libresco.
Conosceva a memoria gli hadit certificati, i grandi eventi che
hanno segnato la storia dell'islam dall'Oriente fino all'estremo
Occidente. Era un uomo allucinante. Se fosse vissuto fino ai nostri
giorni, credo che sarebbe finito impiccato oppure decapitato, tanto
il suo sapere oltrepassava il comune intendimento. Un bel giorno,
mentre faceva lezione, qualcuno gli ha bisbigliato qualcosa
all'orecchio. L'illustre erudito è diventato grigio di colpo. Il
rosario gli è scivolato dalle dita. Senza dire una parola, si è
alzato e ha abbandonato la stanza. Nessuno l'ha più rivisto.»
Atiq inarca un sopracciglio. «Cosa gli hanno bisbigliato
all'orecchio?» dice, sulla difensiva.
«La storia non lo dice.»
«E la morale della storia?»
«Possiamo sapere tutto della vita e degli uomini, ma cosa sappiamo
davvero di noi stessi? Mio buon Atiq, non complicarti troppo la
vita. Non indovinerai mai cosa ti riserva. Smettila di riempirti la
testa di idee fasulle, questioni inspiegabili e ragionamenti
inutili. Avere una risposta per tutto non ti mette al riparo da ciò
che il domani tace. L'erudito sapeva molte cose, ma ignorava
l'essenziale. Vivere è anzitutto tenersi pronti a che il cielo ci
cada sulla testa. Se parti dal principio che l'esistenza è solo una
prova, sei preparato ad affrontare le pene e le sorprese che ti
riserva. Se continui ad aspettarti da lei quel che non può darti, è
la prova che non hai capito nulla. Prendi le cose come vengono, non
farne un dramma e non farla tanto lunga; non sei tu a condurre la
barca, ma il corso del tuo destino. Ieri è morta mia madre. Oggi
sono andato a raccogliermi sulla sua tomba. Adesso sono da Khorsan
a mangiare un boccone. Stasera prevedo di andare da Haji Palwan a
tastare il polso agli amici. Se nel frattempo mi capita qualcosa,
non è la fine del mondo. Non vi è amore più infelice dello sguardo
che ci si scambia in una stazione quando i due treni partono per
opposte direzioni.»
Atiq si ferma, la nuca sempre china. riflette per un attimo, poi,
sollevando il mento, chiede: «Si vede proprio che me la passo
male?».
«Se vuoi la mia opinione, salta agli occhi.»
Atiq scrolla la testa prima di allontanarsi.
Addolorato, Qassim lo guarda andarsene, poi si gratta sotto il
turbante e va a raggiungere il suo conducente nella taverna.
La vita è solo inesorabile consunzione, pensa Mussarat. Ci si può
prendere cura di sé oppure lasciarsi andare, non cambia nulla. La
caratteristica di ogni nascita è di essere votata alla morte, è la
regola. Se il corpo potesse fare di testa sua, gli uomini
vivrebbero mille anni. Ma non sempre la volontà ha modo di
realizzare i propri proponimenti, e la lucidità del vecchio non
saprebbe indurre le sue ginocchia a essere più salde. La tragedia
principale degli uomini deriva dal fatto che nessuno può
sopravvivere ai suoi voti più ferventi, che sono per di più la
causa prima della sua sventura. Il mondo non è forse il fallimento
dei mortali, la mostruosa dimostrazione della loro inconsistenza?
Mussarat ha deciso di non sottrarsi all'evidenza. Velarsi gli occhi
non serve a niente. Ha lottato contro il male che la rode, si è
rifiutata di darsi per vinta. Adesso, è ora di risparmiarsi e di
affidarsi ai destino, perché è l'unica cosa che rimane quando si è
tentato tutto. Le dispiace solo di dover cedere a un'età in cui i
miraggi non sono irraggiungibili. A quarantacinque anni, si ha
ancora la vita davanti a sé, più sfumata, più misurata; i sogni non
sono più deliranti, gli slanci sereni e il corpo, quando gli
artigli del desiderio lo strappano all'indolenza, freme con tale
discernimento che quel che i piaceri perdono in freschezza lo
recuperano in intensità. La quarantina è un'età della ragione, una
carta in più per venire a patti con le sfide che ci attendono.
Troppo forte è la convinzione per dubitare un solo secondo del suo
successo. Mussarat non dubita. Solo che la sua convinzione non la
porterà a nessun successo. Non ci sarà alcun miracolo. E questo
l'affligge. Ma non troppo; è inutile, quasi grottesco, in ogni caso
blasfemo. Certo, le sarebbe piaciuto farsi bella, sottolineare le
ciglia con il rimmel e sgranare gli occhi per non perdere nulla di
quelli di Atiq. Ma adesso non è più possibile. A quarantacinque
anni, si fa fatica ad ammetterlo. Ahimè, far fatica non esime da
granché. Il riflesso che le rimanda lo specchietto sbreccato è
senza appello; si sta putrefacendo più velocemente delle sue
preghiere. Il suo viso è solo un cranio scarnificato, con le guance
solcate dalle rughe e le labbra rientranti. Il suo sguardo ha già
un lucore d'oltretomba, vitreo, glaciale; una scheggia di vetro
incagliatasi in fondo alle sue pupille. E le mani, Dio mio, ossute,
ricoperte di una pelle sottile e opaca, sgualcite come fossero di
carta, impacciate nel riconoscere gli oggetti al tatto. Questa
mattina, quando ha finito di pettinarsi, una manciata di capelli le
è rimasta tra le dita. Come si possono perdere tanti capelli in
così poco tempo? Li ha arrotolati intorno a un legnetto e li ha
nascosti in una crepa del muro, poi si è lasciata scivolare a
terra, la testa fra le mani e ha aspettato che una lacrima venisse
a riportarla in sé. Non vedendo arrivare nulla, si è trascinata
carponi fino al pagliericcio. Lì, seduta alla turca, si è messa
faccia al muro per un'ora. Avrebbe continuato a voltare le spalle
al patio per tutta la giornata se le forze non le fossero venute
meno. Vinta dalla propria testardaggine, si è stesa a terra e si è
subito addormentata, la bocca aperta in un lungo gemito.
Trovandola sdraiata a terra, Atiq ha subito pensato al peggio.
Curiosamente, la busta non gli è sfuggita di mano e il
respiro non gli si è spezzato. È rimasto in piedi nel vano della
porta, un sopracciglio più alto dell'altro e si è imposto di non
far rumore. Per lunghi minuti ha osservato il corpo, la mano
rivolta al soffitto, le dita contratte, la bocca aperta, il torace
in tensione, alla ricerca di un segno di vita. Mussarat non ha
mosso un capello. Sembra proprio morta. Atiq ha deposto la busta
sopra un tavolino, poi, deglutendo, si è accostato al corpo inerte
della moglie. Si è inginocchiato con mille precauzioni; proprio
quando si è chinato sulla mano esangue per tastarle il polso, un
sospiro l'ha rigettato indietro. Il pomo d'Adamo ha preso ad
agitarsi rabbiosamente. Ha teso l'udito, sospettando un banale
fruscio, e ha accostato l'orecchio al volto impenetrabile. Un
respiro flebile gli ha sfiorato nuovamente la guancia. Ha stretto
le labbra per reprimere la collera, raddrizzato il busto e, gli
occhi e i pugni chiusi, è indietreggiato fino al muro per mettersi
a sedere. Le mascelle contratte e le braccia rigidamente incrociate
sul ventre, ha fissato il corpo steso ai suoi piedi come se volesse
trapassarlo con lo sguardo.
CAPITOLO 10
Mohsen Ramat non ne può più. Le interminabili
giornate che trascorre regolarmente al cimitero non fanno che
aggravare il suo smarrimento. Ha un bel vagare in mezzo alle tombe,
non riesce a rimettere ordine nelle sue idee. Le cose gli sfuggono
a velocità vertiginosa; non ritrova più le proprie orme. Lungi
dall'aiutarlo a concentrarsi, il suo isolamento lo rende fragile,
accentua il suo malessere. Ogni tanto, il folle desiderio di
afferrare una spranga e devastare ogni cosa intorno a sé dilaga per
tutto il suo essere; stranamente, non appena si prende la testa fra
le mani, il suo furore si tramuta nell'irresistibile bisogno di
scoppiare a singhiozzare e allora si abbandona alla propria
prostrazione, i denti stretti e le palpebre sigillate. Sente che
sta per impazzire.
Da quell'alterco per le vie di Kabul, non distingue più il giorno
dalla notte. Qualcosa d'irreversibile ha segnato quella maledetta
passeggiata. Se solo avesse ascoltato sua moglie! Come ha potuto
credere che gli innamorati potessero ancora passeggiare in una
città che sembra un cronicario, infestata da arcigni energumeni,
dallo sguardo buio come la notte dei tempi? Come ha potuto perdere
di vista gli orrori che costellano quotidianamente una
nazione sbeffeggiata al punto che lo scudiscio ne è diventato
la lingua ufficiale? Non avrebbe dovuto cullarsi nelle illusioni.
Stavolta, Zunaira rifiuta di passarvi sopra. Ce l'ha con lui, non
sopporta la sua vista, tanto meno la sua voce. «Per l'amor del
cielo,» l'ha implorata «non complicare le cose fra di noi.» Zunaira
lo ha squadrato, lo sguardo torvo dietro la maschera graticciata.
Il petto le si è sollevato in una risacca d'indignazione. Ha
cercato le parole più dure, più cattive, per dirgli quanto soffra a
causa di quel che lui ormai rappresenta per lei, quanto non riesca
a dissociarlo dagli sbirri inturbantati che hanno trasformato le
strade in arene e le giornate in agonia, quanto la vicinanza di un
uomo le ripugni e l'opprima nello stesso tempo. Non trovando parole
così virulente da tradurre il suo livore e il suo tormento, si è
chiusa in una stanza e si è messa a urlare come una forsennata.
Terrorizzato dagli ululati assordanti della moglie, Mohsen si è
affrettato a uscire di casa. Di corsa. Se la terra si fosse
spalancata sotto i suoi piedi, non avrebbe esitato a lasciare che
si richiudesse sopra di lui. Era orribile. Le urla di Zunaira si
propagavano per il quartiere, richiamavano capannelli di vicini, lo
braccavano come uno stormo di rapaci scatenati. Gli girava la
testa. Sembrava la fine del mondo.
Zunaira non è più la donna di un tempo; quella che, coraggiosa e
vigile, lo aiutava a tener duro e a rialzarsi ogni volta che
cedeva. La creatura che ha deciso di non sbarazzarsi più del suo
burqa è sprofondata deliberatamente in un mondo abominevole, dal
quale non sembra prossima a emergere. Dal mattino fino a notte
fonda, gira per casa, ostinatamente imbacuccata nel suo velo di
sventura, che non abbandona nemmeno per dormire. «Il tuo volto è
l'ultimo sole che mi resta» le ha confessato. «Non
confiscarmelo...» «Non vi è sole che resista alla notte» lei gli ha
ritorto contro, sistemandosi significativamente il cappuccio.
Dall'affronto subito l'altro giorno, non se lo toglie più. È
diventato la sua fortezza e la sua diserzione, la sua bandiera e la
sua abiura. Per Mohsen è una vera barriera che s'innalza fra lui e
lei, il simbolo della dolorosa frattura che minaccia di dividerli.
Negandosi al suo sguardo, lei si sottrae al suo mondo, lo rinnega
da cima a fondo. Questa intransigenza lo destabilizza. Ha cercato
di capire, ma non c'era nulla da capire. Zunaira si rende conto dei
suoi eccessi? In ogni caso, sembra prenderli grottescamente sul
serio. Quando cerca di avvicinarsi, lei indietreggia, le braccia
protese per tenerlo a distanza. Mohsen non insiste. A sua volta,
alza le mani in segno di resa ed esce in strada, la schiena curva
sotto un peso mortale.
Dieci giorni!
Sono dieci giorni che il malinteso consolida i suoi bastioni.
Dieci giorni da vivere in un delirio comicamente crudele, in una
totale infermità.
«Non si può andare avanti così» si ripete Mohsen ogni volta che
torna a casa. A chi lo dice? Zunaira non cede di un millimetro, non
solleva di un dito la sua cappa. Il dolore del marito non la
commuove; anzi, la inasprisce. Non sopporta più il suo sguardo da
cane bastonato né la sua voce salmodiante. Non appena riconosce il
suo passo nel cortile, smette quello che sta facendo e si precipita
nella stanza accanto. Mohsen contrae le mascelle per contenere gli
assalti del suo furore, poi, battendo le mani, torna sui propri
passi.
Stasera, ha diritto alla stessa accoglienza. Ha appena spinto la
porta del patio che la vede attraversare la sala e sparire dietro
la tenda della camera, furtiva come un'allucinazione. Tutto il suo
essere vibra per alcuni istanti; non è più il caso di andarsene
sbattendo la porta. Le sue intempestive partenze non l'hanno fatto
avanzare di molto. Al contrario, hanno a allargato il fossato
che lo separa dalla moglie. È ora di andare a fondo della
questione, pensa. È un momento che teme, per via della caparbietà
di una Zunaira sbrigativa e imprevedibile, ma non può prolungare
oltre una situazione che si va sempre più deteriorando.
Respira profondamente e raggiunge la moglie in camera.
Zunaira è seduta sul pagliericcio, la schiena dritta. S'intuisce
che è compressa come una molla, pronta a balzare sulle gambe.
Mohsen non l'ha mai vista in quello stato. Il suo mutismo è gravido
di tempesta. Quando tace a quel modo, Zunaira diventa impossibile
da decifrare, il che rende ogni approccio problematico, per non
dire rischioso. Mohsen ha paura. Tremendamente paura. Sembra un
artificiere intento a disinnescare una bomba, sicuro che la sua
vita è appesa a un filo. Zunaira è sempre stata difficile. È una
persona scorticata, che detesta subire e perdona raramente. Forse è
per questo che la teme, perdendo il proprio sangue freddo non
appena lei aggrotta le ciglia. Il momento è decisivo. Mohsen trema,
e tuttavia non ha scelta. Spia un segno, un minuscolo segno in
grado d'ispirargli un barlume di fiducia. Niente. Zunaira non si
muove. Dietro il suo contegno da sfinge, Mohsen sente che qualcosa
cresce dentro di lei, come se nelle sue viscere ribollisse la lava
in attesa di schizzar fuori all'improvviso, violenta come un
geyser. Sebbene il suo viso sia nascosto dal velo, lui è convinto
che lo guardi con odio. «Cosa mi rimproveri, esattamente?» esclama
sfinito. «Di non aver messo al suo posto quell'imbecille di
talebano? Cosa potevo fargli? Loro sono la legge. Hanno diritto di
vita e di morte su tutto quel che si muove. Credi che i loro modi
di fare mi lascino indifferente? Disgusterebbero una bestia da
soma. Quando penso che quel cane di un miliziano non meriterebbe
neppure di baciare le orme dei tuoi passi nella polvere. Sono
perfettamente cosciente dell'abiezione che sgretola i rari sussulti
d'orgoglio che non riesco a esternare, ma, per la memoria dei
nostri morti, dimmi, cosa potevo fare, Zunaira?»
S'inginocchia di fronte a lei, concitato, sgomento, cerca di
prenderle la mano. Lei si getta indietro e si rannicchia nel suo
sudario.
«È ridicolo» borbotta Mohsen. «Completamente ridicolo. Mi tratti
come se fossi un appestato... Non mi voltare le spalle, Zunaira. È
come se l'universo intero mi tenesse il broncio. Ho solo te. Guarda
come t'implorano le mie mani, come sono perduto senza di te. Sei il
solo ormeggio che ancora mi tenga legato a questo mondo.»
Le lacrime gli gonfiano le palpebre. Non capisce come siano
riuscite a ingannare la sua vigilanza e a scorrergli sulle guance
di fronte a Zunaira... Zunaira che detesta vedere gli uomini
piangere.
«Sto malissimo» si scusa. «Improvvisamente ho paura dei miei
pensieri. Devo tornare in me, Zunaira. Il tuo atteggiamento è un
incubo. Non so cosa fare dei miei giorni, né delle mie notti. Sei
la mia unica ragione di vita, se vivere ha ancora un senso in
questo paese.»
Cerca nuovamente di afferrarle il polso.
Zunaira getta un grido e si alza, ansimante.
«Ti ho detto cento volte di non toccarmi.»
«Cos'è questa storia? Sono tuo marito...»
«Dimostralo.»
«Non ha senso. Insomma, dove vuoi arrivare?»
Zunaira si strappa dal muro per ergersi contro di lui, quasi lo
sfiora con la punta del naso. La sua collera è tale che il velo
sobbalza sotto il respiro incontrollato.
«Non voglio vederti mai più, Mohsen Ramat!»
Una deflagrazione non l'avrebbe scosso fino a quel punto. Mohsen è
stordito dalle parole della moglie. Dapprima incredulo, impiega
qualche istante per comprendere quel che ha appena udito. Il pomo
d'Adamo impazzisce nella sua gola. Batte le mani, gira sui talloni.
Nella stanza, il respiro dell'uno si avvinghia al respiro
dell'altra in un ronzio sovrannaturale. Improvvisamente, Mohsen
emette un rantolo incongruo e sferra un pugno contro le imposte
della finestra, così forte da rompersi il polso.
Sfigurato dal dolore, torna a fronteggiare la moglie e la minaccia:
«Ti proibisco di parlarmi a questo modo, Zunaira. Non ne hai il
diritto. Mi stai ascoltando?» urla afferrandola alla gola e
scuotendola. «Te lo proibisco, categoricamente.»
Imperturbabile, Zunaira scioglie le dita che le stritolano il
collo.
«Non voglio vederti mai più, Mohsen Ramat» martella, scandendo le
parole.
Preso dal panico, Mohsen si asciuga le mani madide lungo i fianchi,
come per cancellare le tracce della propria brutalità, si guarda
intorno, poi, considerando che la situazione sta degenerando, si
porta le mani alle tempie e cerca di calmarsi.
«D'accordo» concede. «Forse stasera sono rientrato troppo presto.
Tornerò da dove sono venuto. Se vuoi, posso passare la notte fuori.
Bisogna assolutamente dare una possibilità alla riconciliazione...
Zunaira, io ti amo. Ecco, non trovo parole più ragionevoli. Quello
che hai appena detto è sicuramente la più atroce dichiarazione che
abbia mai udito. Detta da te, ha l'impatto di una terribile
bestemmia. Adesso vedo quanto sia necessario che ti lasci
tranquilla. Tornerò domani, oppure fra due giorni. Non so come farò
a tener duro fino a quel momento, ma ci riuscirò. Per salvare il
nostro matrimonio sono disposto a tutto. Cerca anche tu di fare
altrettanto. Ti amo. Qualunque cosa succeda, voglio che tu lo
sappia. È molto importante. Non c'è nulla di più importante.»
Zunaira non cede. Sotto il velo, le sue labbra si muovono
insidiosamente. Mohsen le mette la mano alla bocca. «Non una parola
di più. Hai detto abbastanza per oggi. Lasciami sperare che si
tratti solo di un brutto momento, che domani tutto tornerà come
prima.»
Zunaira indietreggia per liberarsi della mano del marito.
«Credo che tu non abbia capito bene» dice. «Non voglio vederti mai
più, Mohsen. Non sono parole dette a vanvera, e i giorni a venire
non le renderanno più giudiziose. Esci dalla mia vita e non tornare
in questa casa. Altrimenti, sarò io ad andarmene.»
«Ma perché?» si ribella Mohsen strappandosi la camicia in un gesto
di stizza e denudandosi il petto macilento, di un pallore
malaticcio. «Dimmi quale grande errore ho mai commesso per meritare
la sorte che si accanisce contro di me!»
«È finita, Mohsen... Eppure è così semplice: fra di noi, tutto è
finito. La sola cosa che voglio è che tu te ne vada per
sempre.»
Mohsen scuote la testa.
«Non è vero. Rifiuto di accettarlo.»
«Mi dispiace.»
Fa per andarsene. Lui la trattiene per il braccio e l'attira
violentemente a sé.
«Sono ancora tuo marito, Zunaira Ramat! Non ho ritenuto necessario
ricordartelo, ma, visto che insisti, farò violenza a me stesso.
Qui, comando io. Non è nelle nostre tradizioni che una moglie
ripudi il marito. Non si è mai visto. E io non lo permetterò. Da
dieci giorni, cerco di fare la mia parte, sperando che tu
rinsavisca. A quanto pare, non ci tieni a rinsavire, e io ne ho
abbastanza.»
Con uno strattone, lei si strappa dalla sua morsa.
Lui la riacciuffa, le torce il polso e la costringe a guardarlo in
faccia.
«Inizierai subito togliendoti questo fottuto burqa.»
«Neanche a parlarne, visto che la sharia di questo paese lo
esige.»
«Te lo togli, e subito.»
«Prima chiedi il permesso ai talebani. Dai, fammi vedere di che
pasta sei fatto. Valli a trovare, intima loro di abrogare la loro
legge e ti prometto che un minuto dopo mi toglierò il velo. Perché
stai qui ad angariarmi, a fare il duro, invece di andare a tirar
loro le orecchie finché non odono chiaramente la voce del Signore?
Visto che sei mio marito, va' da quel miserabile bastardo che ha
osato alzare la mano su tua moglie e mozzagli il polso. Vuoi vedere
il mio volto, l'ultimo sole che ti resta? Dimostrami, allora, che
si è fatto giorno e la notte dell'infamia è solo un brutto sogno
frutto di un lontano ricordo.»
Mohsen le stropiccia il velo, si sforza di sollevarlo. Zunaira si
contorce in tutti i modi per impedirglielo. Una lotta accanita li
oppone. Agli ansiti seguono i gemiti e le imprecazioni. Zunaira si
avvinghia al suo burqa, nonostante il dolore causatole dalle
numerose, frenetiche artigliate che l'attanagliano. Visto che suo
marito non molla la presa, lei gli morde la spalla, il braccio, il
petto, senza riuscire a scoraggiarlo. Al culmine della
disperazione, lo morde selvaggiamente al viso. Sorpreso, Mohsen
indietreggia per il morso che gli ha inciso lo zigomo. Un fiotto di
dolore gli inonda le pupille accecandolo; le sue narici fremono di
rabbia. La mano, irrefrenabile, descrive una curva folgorante e si
abbatte sulla guancia della moglie che, stordita, stramazza a
terra.
Orripilato dal proprio gesto, Mohsen si guarda la mano. Come ha
osato? Non ricorda di aver mai alzato il mignolo su di lei. Mai si
è creduto capace di apostrofarla o rimproverarle alcunché. Si
guarda la mano come se non la riconoscesse. «Cosa ci sta
succedendo?» farfuglia. Letteralmente sconvolto, si accovaccia di
fronte alla moglie tremando come una foglia.
«Perdonami. Non volevo...»
Zunaira lo respinge, riesce ad alzarsi e barcolla verso la
sala.
Lui la segue, supplicandola.
«Sei solo un volgare cafone e non sei migliore di quei pazzi
furiosi che si pavoneggiano per strada.»
«Perdonami.»
«Non potrei nemmeno se lo volessi.»
Lui le afferra il braccio. Lei si volta di scatto, raccoglie le
ultime forze e lo scaraventa contro il muro. Mohsen incespica in
una caraffa e cade all'indietro. La testa urta una sporgenza della
parete prima di picchiare violentemente contro il pavimento.
Tornata in sé, Zunaira si accorge che il marito non si muove. La
nuca storta in modo bizzarro, giace a terra, gli occhi sgranati e
la bocca spalancata. Sul viso livido, si è diffusa una strana
serenità, appena alterata dal rivolo di sangue che fuoriesce da una
narice.
«Oh! Mio Dio!» esclama.
CAPITOLO 11
«Qassim Abdul Jabbar ti prega di non abbandonare
il tuo posto oggi» dice il miliziano. «C'è un nuovo arrivo per
te.»
Atiq, seduto su uno sgabello all'ingresso della prigione, alza le
spalle senza togliere lo sguardo dai camion carichi di guerrieri
che stanno lasciando la città in un'agitazione indescrivibile. Lo
sbraitare dei conducenti e i colpi di clacson fendono la folla come
un rompighiaccio mentre, eccitati dalla confusione generata dal
convoglio, dei monelli corrono strillando da ogni parte. La notizia
è arrivata stamattina: le truppe del comandante Massud sono cadute
in un'imboscata e Kabul invia rinforzi per annientarle.
Anche il miliziano guarda i mezzi militari attraversare il
quartiere alla velocità del vento, una tempesta di polvere alle
calcagna. Con la mano nerastra per le cicatrici tritura
istintivamente la culatta del fucile. Si volta per sputare e
impreca: «Stavolta si fa sul serio. A quanto pare, abbiamo perso
molti uomini, ma quel rinnegato di Massud farà la fine del topo.
Non rivedrà più il suo maledetto Panshir».
Atiq raccoglie un bicchiere di té ai suoi piedi e se lo porta alla
bocca. Chiude un occhio per via del sole, squadra il miliziano
prima di brontolare: «Spero che il tuo Qassim non mi farà aspettare
tutto il giorno. Ho un sacco di cose da fare, io».
«Non mi ha detto a che ora verrà. Al tuo posto, non mi muoverei di
qui. Sai com'è fatto.»
«Non so com'è fatto, e non ci tengo a saperlo.»
Il miliziano corruga la fronte, che ha larga e prominente. Osserva
il carceriere con aria infastidita: «Non stai bene,
stamattina».
Atiq posa il bicchiere, le labbra imbronciate. La presenza del
miliziano lo esaspera. Non capisce perché non se ne vada, ora che
gli ha trasmesso il suo messaggio. Lo fissa per un attimo, nota che
ha un profilo ributtante con quella barba arruffata, il naso
schiacciato e gli occhi cisposi dallo sguardo ebete.
«Se vuoi, me ne vado» dice il miliziano come se leggesse nei
pensieri della guardia carceraria. «Non mi piace disturbare la
gente.»
Atiq trattiene un sospiro e si volta. Gli ultimi mezzi militari
sono passati. Per qualche minuto ancora li si sente rombare dietro
le macerie, poi il silenzio si addensa, attenuando il baccano della
marmaglia. La polvere continua a fluttuare per aria, velando un
lembo di cielo, dove staziona immobile un branco di nuvole di un
desolante biancore. Laggiù, dietro le montagne, si ha l'impressione
di udire delle deflagrazioni, che l'eco falsifica a modo suo. Da
due giorni," eruttano tiri sporadici nell'indifferenza generale. A
Kabul, in particolare al mercato e nei bazar, il bailamme delle
speculazioni coprirebbe il coro delle battaglie più aspre. Le
mazzette di banconote si vendono all'asta, per uno sbalzo d'umore
si fanno e si disfano fortune, la gente ha occhi solo per il
guadagno e l'investimento; quanto alle notizie dal fronte, le si
ascolta di nascosto, come per dar brio agli affari. Atiq non ne può
più. A sua volta, inizia a chiedersi seriamente se non sia il caso
di seguire le orme di Zanish. Quel povero diavolo ha finito per
decidersi; un bel mattino ha preso baracca e burattini e si è
volatilizzato, senza una parola ai figli che l'hanno cercato per
una settimana. Alcuni pastori hanno dichiarato di aver visto il
vecchio sulle montagne, ma nessuno li ha presi sul serio. Alla sua
età, Zanish sarebbe incapace di affrontare la più modesta delle
colline dei dintorni, soprattutto con un caldo del genere. Eppure,
Atiq è convinto che l'ex mullah si sia davvero avventurato fra le
montagne, se non altro per dimostrare a lui, carceriere crudele e
sardonico, che aveva torto a seppellirlo prima del tempo.
Il miliziano si accovaccia bruscamente per impossessarsi del
bicchiere del guardiano.
«Sei simpatico» dice. «Non so cos'hai in questi ultimi tempi, ma
non fa niente, non te ne vorrò se mi mandi via.»
«Non ti mando via» sospira Atiq mentre, disgustato, lo guarda bere
dal suo bicchiere. «Sei tu che parli di andare via.»
Il miliziano annuisce. Accoccolato, si addossa al muro e si rimette
a maneggiare il suo kalashnikov.
«Che fine ha fatto Qaab?» gli chiede Atiq dopo un lungo silenzio.
«Sono lustri che non lo vedo.»
«Qaab, chi? Quello dei blindati?»
«E chi, se no?»
Il miliziano si volta verso il guardiano, inarcando le
sopracciglia.
«Non vorrai farmi credere di non saperne nulla?»
«Sapere cosa?»
«Qaab è morto, dai, da più di due anni.»
«È morto?»
«Basta, Atiq. Siamo stati tutti al suo funerale.»
Il guardiano abbozza una smorfia, si gratta una tempia, poi,
sapendone quanto prima, scuote la barba, imbarazzato.
«Come mai l'ho dimenticato?»
Il miliziano lo spia con la coda dell'occhio, sempre più
incuriosito.
«Non ti ricordi?»
«No.»
«Strano.»
Atìq recupera il bicchiere, si accorge che è vuoto. Lo contempla
con aria assorta e lo ripone sotto lo sgabello.
«Com'è morto?»
«Non mi starai prendendo in giro, vero, Atiq Shaukat?»
«Ti assicuro che sono serio.»
«Il suo carro armato è esploso durante un'esercitazione di tiro. La
carica della granata era difettosa. Invece di attenersi alle misure
di sicurezza e osservare il minuto di attesa regolamentare, ha
proceduto immediatamente all'espulsione della granata, che è
esplosa dentro la torretta. Il carro armato si è sparpagliato in un
raggio di cinquanta metri.»
«Il corpo di Qaab è stato ritrovato?»
Il miliziano picchia a terra il calcio del fucile e si rialza,
sicuro che il carceriere lo prenda in giro.
«Non stai bene, tu, oggi. In tutta franchezza, non stai bene
proprio per niente.»
Al che, sputa per terra e si allontana biascicando
imprecazioni.
Qassim Abdul Jabbar arriva nel tardo pomeriggio a bordo di un
furgone scassato. Le due miliziane che l'accompagnano afferrano la
prigioniera e la spingono brutalmente dentro l'edificio. Atiq
chiude a doppia mandata la sua nuova pensionante in una fetida
cella in fondo al corridoio. La testa altrove e il gesto meccanico,
non sembra rendersi conto di quel che capita intorno a lui. Qassim
l'osserva in silenzio, a braccia conserte, lo sguardo intenso
dall'alto della sua statura da lottatore. Quando le due miliziane
hanno raggiunto il furgone, lo provoca: «Almeno avrai
compagnia».
«Altroché!»
«Non vuoi sapere cos'ha combinato?»
«A che mi serve?»
«Ha ammazzato il marito.»
«Sono cose che capitano.»
Qassim intuisce il crescente disgusto del carceriere. La cosa lo
esaspera più che mai, ma resiste alla tentazione di rimetterlo in
riga. Si liscia la barba con aria assorta e, voltandosi verso il
fondo del corridoio, aggiunge: «Resterà un po' di più delle
altre».
«Perché?» chiede Atiq, seccato.
«Per la grande manifestazione che si terrà venerdì allo stadio.
Sono attesi ospiti di alto rango. Le autorità hanno deciso di
eseguire pubblicamente una decina di condanne per creare
l'atmosfera. La tua pensionante sarà della partita. All'inizio, i
capi volevano fucilarla subito. Poi, visto che nessuna donna era in
programma per venerdì, le hanno concesso un rinvio di cinque
giorni.»
Atiq scrolla la testa, per niente convinto.
Qassim gli mette una mano sulla spalla.
«Noi ti abbiamo aspettato l'altra sera, da Haji Palwan.»
«Ho avuto un contrattempo.»
«Anche le sere successive.»
Atiq preferisce battere in ritirata. Si ritira nello stambugio che
funge da ufficio. Qassim esita un momento prima di andargli
dietro.
«Hai riflettuto sulle mie proposte?»
«Dovrei avere una testa per riflettere su qualcosa.»
«Sei tu che rifiuti di rialzarla. Le cose sono chiare. Basta solo
guardarle in faccia.»
«Tì prego, Qassim, non ho voglia di tornare sull'argomento.»
«D'accordo» si scusa Abdul Jabbar portando le mani al petto,
«ritiro quanto ho detto. Ma, per l'amor del cielo, sbrigati a
toglierci di torno questa faccia da funerale.»
CAPITOLO 12
Atiq Shaukat non ha capito subito. Qualcosa è
scattato in lui e un soffio tetanizzante l'ha attraversato dalla
testa ai piedi, come se una doccia gelata si fosse riversata sul
suo corpo. Il tegame gli sfugge di mano e si schianta per terra,
spandendo palline di riso nella polvere. Per tre o quattro secondi
pensa di avere un'allucinazione. Stordito dall'apparizione che l'ha
colpito in pieno, torna nel suo stambugio per cercare di riprendere
i sensi. La luce della finestra lo aggredisce, gli schiamazzi dei
bambini, che si fanno la guerra lì fuori, lo disorientano; si
lascia cadere sulla branda e, le dita contro le tempie, maledice
più volte il Demonio per respingere le influenze malefiche.
«Dio è misericordioso!»
Dopo aver recuperato parte della propria lucidità, torna nel
corridoio per cercare il tegame, recuperare il coperchio che è
rotolato più lontano e raccogliere i grumi di riso sparsi a terra.
Mentre continua a ripulire il pavimento, alza cautamente gli occhi
sulle sbarre chiuse col lucchetto, sull'abbaino che incombe
sull'alveolo come un uccello del malaugurio, si attarda sul debole,
anemico lume che agonizza sul soffitto, poi, preso il coraggio a
due mani, torna verso la cella e lì, nel bel mezzo della gabbia,
l'incantevole visione!... La prigioniera ha sollevato il
burqa. Seduta a gambe incrociate, i gomiti sulle ginocchia e le
mani giunte sotto il mento, prega. Atiq è sbalordito. In vita sua,
non ha mai visto una simile meraviglia. La detenuta è di una
bellezza inaudita, con un profilo da dea, i lunghi capelli sciolti
lungo la schiena e gli occhi immensi, simili a orizzonti. Sembra di
assistere al sorgere dell'aurora nel cuore stesso di quella cella
fetida, sordida e funesta.
Tranne quello di sua moglie, è da parecchi anni che Atiq non vede
il viso di una donna. Ha imparato a farne a meno. Per lui, a parte
Mussarat, ci sono solo spettri, senza voce e senza attrattive, che
attraversano le strade senza suscitare alcunché; nugoli di rondini
decrepite, blu o giallastre, il più delle volte scolorite e in
ritardo di parecchie stagioni, che, quando passano accanto agli
uomini, emettono un suono cupo.
Ed ecco che un velo cade e ne spunta una meraviglia. Atiq non si
capacita. Una donna integrale, compatta; un volto di donna
autentico, tangibile, anch'esso integrale, lì, davanti a lui?
Inimmaginabile. Ha divorziato da così tanto tempo da una simile
realtà che riteneva fosse stata bandita dai pensieri. Quand'era più
giovane, sul limitare dell'adolescenza, gli capitava di profanare
il nascondiglio di alcune cugine per spiarle da lontano, di
nascosto, attento ai loro scoppi di risa, alla loro venustà e alla
scioltezza dei loro movimenti. Si era anche innamorato di una
maestra uzbeka, di dieci anni più grande di lui, dalle trecce senza
fine, che rendevano la sua andatura seducente come una danza
mistica. Era convinto, in quell'età incerta, in cui le leggende
resistono pateticamente all'assedio dei pregiudizi e delle
tradizioni, che bastasse sognare una ragazza per intravedere uno
spiraglio di paradiso. Non era la via più sicura per accedervi, ma
di certo la meno inumana... Poi, più nulla. Il mondo delle
deliziose imprudenze si sfascia e si sgretola. I sogni si velano il
volto. Cala un cappuccio graticciato e confisca ogni cosa, le
risate, i sorrisi, gli sguardi, le fossette sulle guance, il
frusciare delle ciglia...
Il giorno dopo, Atiq si accorge di aver trascorso la notte in
bianco seduto nel corridoio di fronte alla detenuta, dalla quale
non ha mai distolto lo sguardo. Si sente sottosopra, con la testa
leggera e la gola straziata. Ha l'impressione di risvegliarsi nella
pelle di un altro. Qualcosa di simile a una possessione fulminante
lo ha investito fin nelle sue pieghe più riposte, abita i suoi
pensieri, martella i suoi polsi, cadenza il suo respiro, anima il
più piccolo dei suoi fremiti, ora canna rigida e immobile, ora
edera strisciante che s'aggroviglia intorno al suo essere. Atiq non
cerca neppure di vederci chiaro. Subisce, senza soffrirne, una
sensazione vertiginosa e implacabile, un'ebbrezza estatica che
strapazza le sue difese al punto da fargli dimenticare le
abluzioni. Ha tutta l'aria di un sortilegio, ma non lo è. Atiq è
cosciente della gravità della sua scorrettezza, ma non ci bada. Si
abbandona, da qualche parte, così lontano eppure così vicino,
all'ascolto delle sue più impercettibili pulsazioni, sordo ai più
perentori richiami all'ordine.
«Qualcosa non va?» gli chiede Mussarat. «È la quinta volta che
aggiungi sale al tuo riso senza mangiarlo e porti la tazza d'acqua
alle labbra senza berne un sorso.»
Atiq contempla la moglie con aria inebetita. Non sembra cogliere il
senso delle sue parole. Le mani gli tremano, il petto s'ingolfa e,
di tanto in tanto, pare sul punto di soffocare. Non ricorda di aver
attraversato il quartiere con le gambe molli e la testa vuota, non
ricorda di aver incontrato qualcuno per strada, dove, di solito,
non può avventurarsi senza essere interpellato o salutato da
qualcuno che conosce. Mai, in tutta la sua vita, ha vissuto la
condizione che lo consuma dal giorno prima. Non ha fame, non ha
sete, il mondo circostante non lo sfiora neppure; sta vivendo
qualcosa di prodigioso e terrificante insieme, ma non vorrebbe
privarsene per tutto l'oro del mondo: sta bene.
«Cos'hai, Atiq?»
«Scusa?»
«Dio sia lodato, mi senti. Temevo che fossi diventato
sordomuto.»
«Ma, insomma, che vuoi?»
«Niente» rinuncia Mussarat.
Atiq posa la tazza a terra, attinge un pizzico di sale da una
minuscola terrina e torna a cospargerne la sua razione di riso.
Mussarat si porta la mano alla bocca per nascondere un sorriso. La
distrazione del marito la diverte e la preoccupa, ma, riconosce, lo
splendore del suo viso è rasserenante. Di rado l'ha visto così
teneramente maldestro. Sembra un bambino al ritorno da uno
spettacolo di burattini. I suoi occhi sfavillano di luce interiore
e la sua eccitazione è appena credibile in uno come lui, che
vibrava solo d'indignazione, quando non minacciava di spaccare
tutto quel che si trovava a portata della sua collera.
«Mangia» lo invita.
Atiq s'irrigidisce. Corruga la fronte attorno alle sopracciglia. Si
alza di scatto picchiando le mani sulle cosce.
«Dìo mio!» esclama correndo verso il mazzo di chiavi appeso al
chiodo. «Sono imperdonabile.»
Mussarat cerca di alzarsi. Le braccia scarne cedono e ricade sul
giaciglio. Spossata dallo sforzo, si addossa alla parete e osserva
il marito.
«Cos'hai combinato, ancora?»
E Atiq, frastornato: «Ho dimenticato di dar da mangiare alla
detenuta».
Mussarat rimane assorta. Suo marito è uscito dimenticando turbante,
gilet e scudiscio. È la prima volta che succede.
Si aspetta di vederlo tornare a riprenderli. Atiq non torna.
Mussarat ne deduce che quel carceriere occasionale di suo marito ha
perso la testa.
Assopita sopra una logora coperta, Zunaira sembra offerta in
sacrificio. Intorno a lei, la cella vacilla sotto le luci della
lanterna, gli angoli crivellati di schizzi acuminati. Si sente
cigolare la notte, densa e vischiosa, priva di effettiva
profondità. Atiq posa a terra un piatto ricolmo di spiedini che ha
pagato di tasca sua, una focaccia e una manciata di bacche.
Accoccolato, allunga la mano per risvegliare la prigioniera. Le
dita rimangono sospese sopra la spalla tornita. Deve riprendere le
forze, si dice. I suoi pensieri non riescono a spronare il suo
gesto; la mano resta interdetta a mezz'aria. Camminando a ritroso,
finisce per addossarsi al muro, incrocia le braccia intorno alle
gambe, ficca il mento fra le ginocchia e non si muove più, gli
occhi inchiodati al corpo della donna, la cui ombra, plasmata dal
biancore accecante della lanterna, disegna un paesaggio di sogno
sulla parete che funge da tela. Atiq è sbalordito dalla serenità
della detenuta, non pensa che la calma possa evidenziarsi meglio
che su quel volto limpido e puro come acqua di sorgente. E quei
capelli neri, lisci e morbidi, che il meno audace dei respiri
solleverebbe in aria come un aquilone. E quelle mani da uri,
trasparenti e delicate, che s'intuiscono tenere come una carezza. E
quella bocca piccola e rotonda... La hawla, si riprende Atiq. Non
ho il diritto di approfittare del suo sonno. Devo tornare a casa e
lasciarla in pace. Atiq pensa, ma non si muove. Rimane accovacciato
nel suo angolo, le gambe imprigionate dalle braccia, gli occhi più
grandi della coscienza.
«È molto semplice,» confessa Atiq «non vi sono parole per
descriverla.»
«È davvero così bella?» s'informa Mussarat, dubbiosa.
«Bella? La parola mi sembra dozzinale, al limite della banalità. La
donna che marcisce nella mia segreta è più che bella. Ne tremo
ancora. Ho trascorso la notte a vegliare sul suo sonno, così
abbagliato dal suo splendore che non ho visto spuntare l'alba.»
«Spero che non ti abbia distratto dalla preghiera.»
Atiq china la testa. «È la verità.»
«Hai dimenticato di assolvere alla salai (Salai è la preghiera in
generale)?»
«Sì.»
Mussarat scoppia in una risata i cui sussulti subito si tramutano
in una sfilza di colpi di tosse. Atiq si acciglia. Non capisce
perché sua moglie rida di lui, ma non si offende. È raro che la
senta ridere, e la sua insolita allegria rende la penombra del
tugurio quasi abitabile. Mussarat si asciuga gli occhi, affannata
ma estasiata, si sistema il cuscino dietro la schiena e vi si
appoggia.
«Ti diverto?»
«Enormemente.»
«Mi trovi ridicolo.»
«Ti trovo fantastico, Atiq. Come hai potuto nascondermi parole così
generose? Siamo sposati da più di vent'anni e solo adesso riveli il
poeta che si nascondeva in te. Non puoi immaginare quanto sia
felice di apprendere che sei capace di dire le cose con il cuore
invece di limitarti a esorcizzarle come se si trattasse di conati
di vomito. Atiq, l'eterno imbronciato, che passava accanto a una
moneta d'oro senza vederla, in grado di provare buoni sentimenti?
Non mi diverte, mi fa risuscitare. Ho voglia di andare a baciare i
piedi di quella donna che, nello spazio di una notte, ha
risvegliato tanta sensibilità in te. Dev'essere una santa. Oppure
una fata.»
«È quel che mi sono detto la prima volta che l'ho vista.»
«Ma perché l'hanno condannata a morte?»
Atiq sussulta. Evidentemente, è una domanda che non si era posto.
Scrolla la testa e biascica: «Mi rifiuto di ritenerla capace di
azioni riprovevoli. Non sarebbe da lei. C'è un errore, senza
dubbio».
«E lei, cosa dice?»
«Non ho parlato con lei.»
«Perché?»
«Non si fa. Ho ospitato tante condannate a morte, alcune per
parecchi giorni. Non abbiamo scambiato nemmeno una parola. È come
se nessuno fosse lì per l'altro; ci ignoriamo, loro nelle celle, io
nella mia tana. Nemmeno le lacrime servono a granché dopo che è
stata pronunciata una sentenza capitale. In quei casi, non vi è
posto migliore della prigione per raccogliersi. Quindi si sta
zitti. Soprattutto alla vigilia di un'esecuzione.»
Mussarat afferra la mano del marito e la stringe al seno.
Stranamente, il carceriere la lascia fare. Forse non se ne accorge
nemmeno. Il suo sguardo è remoto, il respiro profondo.
«Oggi, mi sento in forma» dice, rinvigorita dal colorito soffuso
sul viso del marito. «Se vuoi, posso prepararle qualcosa da
mangiare.»
«Faresti questo per lei?»
«Farei qualunque cosa per te.»
CAPITOLO 13
La detenuta allontana il vassoio e si asciuga
delicatamente la bocca con il lembo di uno strofinaccio. Il modo in
cui si strofina gli angoli delle labbra denota un rango sociale
ormai abolito; ha classe e, di certo, ha studiato. Atiq la scruta
facendo finta di esaminare le linee della propria mano. Non vuole
perdere nulla dei suoi gesti, delle sue espressioni, del suo modo
di mangiare, bere, prendere e posare gli oggetti intorno a lei. Non
ha dubbi, quella donna è stata ricca e di alto rango, ha indossato
sete e gioielli, si è cosparsa di profumi da favola e ha
strapazzato il cuore d'innumerevoli pretendenti; il suo volto è
brillato sopra idilli fulminanti e il suo sorriso ha lenito più di
un dolore. Come è arrivata fin lì? Quale vento miserabile l'ha
cacciata in quella prigione, lei che sembra addolcire nello sguardo
le luci del mondo intero?
Alza gli occhi su di lui. Lui si volta immediatamente, il petto
assediato da insondabili affanni. Quando torna su di lei, la
sorprende a osservarlo con un sorrisetto enigmatico sulle labbra.
Per vincere il disagio che lo invade, le chiede se ha ancora fame.
Lei scrolla la testa. Si ricorda delle bacche sul suo tavolo, ma
non osa andare a cercarle. In verità, non vuole assentarsi nemmeno
per un attimo. Sta bene dov'è, dall'altra parte delle sbarre e,
nello stesso tempo, così vicino a lei da aver l'impressione di
percepirne le pulsazioni.
Il sorriso della donna non si smorza. Erra sul suo volto come un
sogno appena accennato. Sorride davvero o è lui che sta
farneticando? Non ha detto una parola da quando l'hanno
imprigionata. Si trincera nel suo esilio, dignitosa e in silenzio,
senza tradire angoscia né tormento. Sembra aspettare che spunti il
giorno per andarsene con lui, senza far rumore. La fatale scadenza,
che aleggia sulle sue preghiere paziente come la mannaia, non
allunga la sua ombra perniciosa fino ai suoi pensieri. Sembra
inespugnabile nel suo martirio.
«È mia moglie che le ha preparato da mangiare» dice Atic..
«E molto fortunato.»
Che voce! Atiq deglutisce. Aspetta che parli ancora e riveli una
parte di quel dramma che le rode dentro. Inutilmente.
Dopo un lungo silenzio, sente se stesso borbottare: «Meritava di
morire».
Poi, con maggior convinzione: «Ci metterei la mano sul fuoco. Chi
non è consapevole della propria fortuna, non ha diritto a nessuna
simpatia».
Il pomo d'Adamo gli raschia la gola quando aggiunge: «Sono sicuro
che era un bruto. Della peggior specie. Pieno di sé. Non poteva
essere diversamente. Quando non si è consapevoli della propria
fortuna, non la si merita, per forza».
Le spalle della detenuta si contraggono.
Ariq alza il tono man mano che le sue parole si susseguono.
«La picchiava, vero? Per un sì o per un no, tirava su le maniche e
si accaniva contro di lei.»
Lei alza la testa. I suoi occhi ricordano delle gemme; il suo
sorriso si è accentuato, triste e sublime insieme.
«Non ne poteva più, è così? Era diventato insopportabile...»
«Era meraviglioso» si lascia sfuggire con voce serena. «Sono io che
non mi rendevo conto della mia fortuna.»
Atiq è in piena esaltazione. Non sta fermo un minuto. Rientrato
prima del previsto, non smette di misurare il patio a larghe
falcate, alzare gli occhi al cielo e parlare da solo.
Seduta sul pagliericcio, Mussarat lo guarda senza dire una parola.
Questa storia comincia a preoccuparla. Atiq non è più lo stesso da
quando gli hanno affidato la prigioniera.
«Cosa c'è?» le urla. «Perché mi guardi così?»
Mussarat non ritiene prudente rispondergli, tanto meno calmarlo.
Atiq sembra aspettare solo questo per saltarle addosso. Ha uno
sguardo carico di fulmini e i pugni sono bianchi alle giunture.
Le si avvicina, una secrezione lattiginosa agli angoli della bocca.
«Hai detto qualcosa?»
Lei scuote la testa.
Atiq si porta le mani alle anche, si volta verso il cortile, poi,
facendo una smorfia di rabbia, picchia contro il muro e ruggisce:
«È stato uno stupido incidente. Può capitare a chiunque. È qualcosa
che non puoi prevedere, che ti prende alla sprovvista. Suo marito è
scivolato su una caraffa e ha picchiato mortalmente la testa contro
il pavimento. È così semplice. Tragico, certo, ma un incidente. La
poveretta non ha colpa. Bisogna che le autorità si rendano conto di
aver condannato ingiustamente una vittima. Non hanno il diritto di
mandare a morte un'innocente solo perché ha provocato un incidente.
Quella donna non ha ucciso suo marito. Non ha ucciso nessuno».
Mussarat l'approva annuendo. Timidamente. Immerso nel suo rancore,
Atiq non lo nota nemmeno.
«Devo dire due paroline a Qassim» dice al termine di un lungo
monologo. «Ha conoscenze in alto loco, amici influenti al posto
giusto. Gli daranno ascolto. Non è il caso di consegnare al boia
un'innocente per colpa di un malinteso.»
«Ma cosa dici?» s'indigna Qassim Abdul Jabbar, che non ha
apprezzato che Atiq sia venuto a disturbarlo a casa per una
sciocchezza. «Quella cagna rabbiosa è stata giudicata e condannata.
Sarà giustiziata fra tre giorni, allo stadio, davanti a ospiti di
prestigio. È la sola donna prevista per la cerimonia. Anche se
fosse innocente, nessuno potrebbe fare più niente per lei. E poi, è
colpevole.»
«È innocente...»
«Ma che ne sai?»
«Me l'ha detto lei.»
«E tu le hai creduto?»
«Perché no?»
«Perché ti ha mentito. È solo una bugiarda matricolata, Atiq. Si
prende gioco della tua cortesia. Non metterti a difendere una
criminale di cui non sai nulla. Hai già abbastanza
preoccupazioni.»
«Non ha ucciso nessuno...»
«I suoi vicini hanno testimoniato contro di lei. Sono stati
categorici. Quella puttana ne combinava di tutti i colori al
marito. Lo cacciava continuamente di casa. I capi non hanno neppure
avuto bisogno di deliberare... (Lo prende per le spalle e lo fissa
dritto negli occhi.) Atiq, mio povero Atiq, se non torni subito in
te, finirai per non trovare più la via di casa. Dimentica quella
strega. Fra tre giorni, raggiungerà quelle che l'hanno preceduta, e
un'altra la sostituirà. Non so come abbia fatto ad abbindolarti,
ma, al posto tuo, cercherei di non sbagliare persona. Sei tu ad
aver bisogno di attenzioni, non lei. Ti avevo messo in guardia
l'altro giorno. Ti chiudi troppo nella tua acredine, Atiq, ti ho
avvisato, fai attenzione: dopo non potrai più uscirne. Non mi hai
dato ascolto. Risultato, sei ancora più fragile ed è bastato che
una lurida cagna si mettesse a guaire per spezzarti il cuore.
Lascia che crepi. Ti assicuro che sta bene dove sta. E poi, è solo
una donna.»
Atiq è fuori di sé. Preso in un turbine, non sa dove sbattere la
testa né dove menare le mani quando si sorprende a imprecare contro
il mondo intero. Non capisce niente di niente. E un altro, qualcuno
che lo sovrasta, lo sommerge, lo maltratta, ma senza il quale si
sentirebbe menomato. Che dire dei tremori che lo fanno battere i
denti nelle ore più calde della giornata e dei sudori che lo
rinfrescano un minuto dopo? Che dire dell'audacia che lo afferra
ogni volta che osa rifiutare il fatto compiuto, lui che non muoveva
il mignolo davanti a un dramma che un semplice schiocco di dita
avrebbe potuto evitare? Che dire di questa risacca impetuosa che lo
fa uscire di senno quando il suo sguardo s'incaglia in quello della
detenuta? Non avrebbe mai pensato di condividere l'angoscia di una
terza persona. Tutta la sua vita è trascorsa con questa ambizione:
passare davanti a un suppliziato senza farci caso, tornare da un
cimitero senza rimangiarsi le proprie decisioni. Ed eccolo farsi
carico del destino di una detenuta che nulla potrebbe sottrarre
all'ombra della forca. Atiq non capisce perché, di punto in bianco,
il suo cuore batta al posto di un altro né come, da un giorno
all'altro, abbia accettato che nulla sarebbe più stato come prima.
Si aspettava di trovare in Qassim Abdul Jabbar un simulacro
d'indulgenza in grado di aiutarlo a sollecitare le autorità, a
convincerle a riesaminare il loro verdetto. Qassim l'ha deluso.
Imperdonabile. Atiq l'ha detestato in blocco. Fra loro, è tutto
finito. Nessuna predica, nessun guru potrebbero riconciliarli.
Qassim è solo un bruto. Non ha più cuore di una clava, più pietà di
un serpente. È l'immagine della propria sventura. Ne morirà. Tutti
ne moriranno, senza eccezioni. I dignitari rannicchiati nella loro
veneranda mostruosità. Gli energumeni sbraitanti, osceni e
febbrili, che già si preparano a invadere lo stadio venerdì. Gli
ospiti di prestigio, che si divertiranno a seconda delle esecuzioni
pubbliche, salutando l'applicazione della sharia con la stessa mano
che scaccia le mosche e spazzando via le spoglie con lo stesso
gesto che benedice lo zelo grottesco dei carnefici. Tutti. Compresa
Kabul, la maledetta, che ogni giorno impara a uccidere e a svivere,
visto che in questa terra le feste sono diventate atroci come i
linciaggi.
«Non permetterò che l'ammazzino» esplode una volta tornato a
casa.
«Perché ti riduci in questo stato?» lo rimprovera Mussarat. «Non è
la prima né l'ultima. Quel che fai non ha senso. Devi tornare in
te.»
«Non voglio tornare in me.»
«Ti stai infliggendo una sofferenza inutile. Guardati. Sembri sul
punto d'impazzire.»
Atiq la minaccia col dito. «Ti proibisco di trattarmi da
pazzo.»
«Allora, torna in te, e subito» protesta Mussarat. «Ti comporti
come chi non sa più dove si trovi. Il peggio è che diventi una
belva quando si cerca di farti ragionare.»
Atiq l'afferra per il collo e la sbatte contro il muro. «Smettila
di gracchiare, vecchia megera. Non sopporto più il suono della tua
voce né l'odore del tuo corpo...»
La lascia andare.
Sorpresa dalla violenza del marito e annichilita dalle sue parole,
Mussarat s'accascia a terra, le mani intorno alla gola dolorante,
gli occhi fuori delle orbite per l'incredulità.
Atiq abbozza un gesto di stizza, raccoglie scudiscio e turbante ed
esce in strada.
C'è moltissima gente alla moschea; i mendicanti e gli invalidi di
guerra si contendono aspramente gli anfratti del santuario. Atiq
sputa da sopra la spalla, tanto lo disgusta quello spettacolo e
decide di andare a pregare altrove. Poco lontano incrocia Mirza
Shah che si affretta a unirsi ai fedeli prima della chiamata del
muezzin. Gli passa davanti senza badargli. Mirza Shah si ferma, si
volta per seguire con lo sguardo il suo vecchio amico e si gratta a
lungo sotto il turbante, prima di riprendere il cammino. Atiq
cammina dritto davanti a sé strizzando gli occhi, il passo
aggressivo. Attraversa le strade senza guardare a destra e a
sinistra, indifferente ai colpi di clacson e alle urla dei
carrettieri. Qualcuno lo chiama ad alta voce da una bettola, ma non
lo sente. Non sentirebbe l'uragano tuonargli sopra la testa.
Ascolta solo il sangue battergli alle tempie, vede solo i meandri
della sua furia secernere la loro oscurità nel suo animo: Qassim
che non tiene conto del suo turbamento, Mussarat che non capisce il
suo dolore, il cielo che si vela il viso, le macerie che gli
voltano le spalle, i curiosi che si preparano a invadere lo stadio,
i talebani che si pavoneggiano lungo i viali, i mullah che
arringano le folle con il dito, letale quanto una sciabola..
Sbattuta la porta della prigione alle sue spalle, i rumori che lo
perseguitano si smorzano. Improvvisamente, l'abisso è lì, e il
silenzio profondo come una caduta. Cosa gli sta succedendo? Perché
non riapre la porta per far sì che lo raggiungano i rumori, le luci
del crepuscolo, gli odori e la polvere? La schiena curva,
ansimante, percorre in lungo e in largo il corridoio. Lo scudiscio
gli sfugge di mano, non lo raccoglie. Cammina, cammina, la barba
nell'incavo del collo, le mani dietro la schiena. Improvvisamente,
si volta verso la porta della cella e l'apre con rabbia.
Zunaira si ripara dietro le braccia, spaventata dalla violenza del
carceriere.
«Vada via» le dice. «Presto sarà notte. Ne approfitti per
proteggersi la fuga e vada il più lontano possibile da questa città
di pazzi. Corra con quanto fiato ha in gola, ma, soprattutto, non
si volti indietro, qualunque cosa succeda, altrimenti farà la fine
della moglie di Lot.»
Zunaira non capisce dove voglia arrivare il carceriere. Si
rannicchia nella coperta, pensando che sia giunta la sua ora.
«Vada via» l'implora Atiq. «Se ne vada, non rimanga qui. Dirò che è
stata colpa mia, che devo aver chiuso male le catene col lucchetto.
Sono pashtun come loro. Me ne diranno di tutti i colori, ma non mi
faranno del male.»
«Cosa succede?»
«Non mi guardi così. Raccolga il burqa ed esca di qui...»
«Per andare dove?»
«Dove vuole, ma non rimanga qui.»
Lei scrolla la testa. Le sue mani si allungano sotto la coperta per
cercare qualcosa che non mostreranno.
«No» dice. «Ho già distrutto una famiglia, non voglio rovinarne
un'altra.»
«Il peggio che mi possa capitare è perdere il posto. È l'ultima
delle mie preoccupazioni. Adesso, se ne vada.»
«Non so dove andare. I miei sono morti o dispersi. L'ultimo legame
che mi restava si è volatilizzato per colpa mia. Era una fiammella,
vi ho soffiato sopra troppo forte per trasformarla in torcia e l'ho
spenta. Non c'è più nulla che mi trattenga qui. Ho fretta di
andarmene, ma non come lei mi propone.»
«Non permetterò che la uccidano.»
«Siamo stati tutti uccisi. Da così tanto tempo che l'abbiamo
dimenticato.»
CAPITOLO 14
I giorni passano simili a pachidermi indolenti.
Atiq è sballottato fra l'incompiutezza e l'eternità. Le ore durano
meno di una scintilla; le notti sono infinite come i supplizi.
Sospeso fra i due estremi, nella sua folle disperazione chiede solo
di esserne squartato. Non sta bene da nessuna parte. Lo si vede
vagare per i vicoli, gli occhi stralunati, la fronte segnata da
solchi implacabili. In prigione, non osando più avventurarsi nel
corridoio, si chiude nel suo box e si trincera dietro il Corano.
Dopo qualche capitoletto, esce all'aria aperta, stremato e senza
fiato, per farsi largo tra la folla come uno spettro fra le
tenebre. Mussarat non sa cosa fare per venire in suo aiuto. Non
appena torna a casa, si chiude nella camera e lì, seduto di fronte
a un leggio, sillaba versetti senza interruzione. Quando va a
vedere cosa fa, lo trova sprofondato nella sua angoscia, le mani
sulle orecchie e la voce tremula, sul punto di perdere i sensi. Si
siede di fronte a lui e, recitata la fatiha rivolta al cielo,
prega. Non appena si accorge della sua presenza, lui richiude
seccamente il Libro Santo e torna in strada. Per rientrare poco
dopo, il viso violaceo e il respiro in affanno. Non mangia quasi
più, di notte non chiude occhio, diviso tra la prigione, dove non
resta a lungo, e la camera da letto, che abbandona prima
ancora di mettervi piede. Mussarat è angustiata dalle condizioni
del marito al punto da dimenticare il male che l'attanaglia. Quando
Atiq tarda a tornare a casa, è assediata da orribili presentimenti.
Qualcosa le dice che il carceriere è impazzito e una disgrazia fa
in fretta a capitare.
Una sera, lo raggiunge nella camera, quasi gli strappa il leggio
affinchè fra loro non vi sia nulla, lo prende per i polsi e lo
scuote vigorosamente.
«Torna in te, Atiq.»
Atiq, inebetito: «Le ho spalancato la porta e le ho detto di
andarsene. Si è rifiutata di uscire dalla cella».
«Perché sa, diversamente da te, che non si sfugge al proprio
destino. Ha accettato la propria sorte e vi si è piegata. Sei tu
che rifiuti di guardare le cose in faccia.»
«Non ha ucciso nessuno, Mussarat. Non voglio che paghi per una
colpa che non ha commesso.»
«Ne hai viste altre morire prima di lei.»
«È la dimostrazione che non ci si può abituare a tutto. Ce l'ho con
me e con l'universo intero. Come si può accettare di morire solo
perché l'hanno deciso dei dignitari sbrigativi? È assurdo. Se non
ha più la forza per lottare, io mi proibisco di darmi per vinto. È
così giovane, così bella... così raggiante di vita. Perché non se
n'è andata quando le ho spalancato la porta?»
Mussarat gli solleva il mento, con la mano rovista teneramente
nella barba arruffata.
«Ma tu, sinceramente - guardami, per piacere e dimmi in tutta
coscienza, l'avresti lasciata andare via?»
Atiq rabbrividisce. Gli occhi luccicano d'incontenibile
sofferenza.
«Visto che ti ho detto che le ho spalancato la porta...»
«Ho capito, ma tu l'avresti lasciata andare via?»
«Certo...»
«L'avresti guardata allontanarsi nella notte, senza correrle
dietro? Avresti accettato che sparisse per sempre per non rivederla
mai più?»
Atiq accusa il colpo; la sua barba grava pesantemente nel palmo
tremante della moglie. Mussarat continua ad accarezzargli la
guancia.
«Io non credo» dice lei.
«Allora, spiegami» le risponde in un gemito. «Per amore del
profeta, dimmi cosa mi sta capitando.»
«Quanto di meglio possa capitare a un essere vivente.»
Atiq alza la testa, così repentinamente che le sue spalle
sussultano. «Cosa, esattamente, Mussarat? Voglio capire.»
Lei gli prende il viso fra le mani. Quel che legge nel suo sguardo
le da il colpo di grazia. Un brivido l'attraversa da parte a parte.
Cerca invano di lottare; due grosse lacrime le imperlano le
palpebre, le scorrono lungo il viso e raggiungono il mento prima
che abbia modo di trattenerle.
«Credo che alla fine tu abbia trovato la tua strada, Atiq, marito
mio. Si è fatto giorno in te. Quel che ti succede, i re e i santi
te lo invidierebbero. Il tuo cuore rinasce. Non posso spiegarti. E
poi è meglio così. Queste cose vanno vissute senza tante
spiegazioni. Perché non c'è nulla da temere.»
«Cosa devo fare?»
«Torna da lei. Prima di aprirle la porta, apri il tuo cuore e
lascia che le parli. Lei lo ascolterà. E ti seguirà. Prendila per
mano e andatevene il più lontano possibile senza voltarvi
indietro.»
«Sei tu che mi chiedi di andarmene, Mussarat?»
«Mi getterei ai tuoi piedi per convincerti. Nessuno ha il diritto
di sciupare quanto di meglio possa capitare a un essere vivente,
anche se dovesse patirne per il resto della vita. Sono istanti così
rari da diventare sacri.»
«Non ti abbandonerò.»
«Ci credo. Ma non è questo il problema. Quella donna ha bisogno di
te. La sua vita dipende dalla tua decisione. Da quando
l'hai vista, i tuoi occhi risplendono. T'illumina dentro. Al tuo
posto, un altro starebbe cantando a squarciagola sui tetti. Se tu
non canti, Atiq, è perché non te l'hanno insegnato. Sei felice, ma
non lo sai. Trabocchi di gioia, e non sai come rallegrartene. Per
tutta la vita hai ascoltato gli altri; i tuoi maestri e i tuoi
guru, i tuoi capi e i tuoi demoni che ti parlavano di guerra,
livore e offese. Le tue orecchie ne tracimano; le tue mani ne
tremano. Ecco perché ora hai paura di ascoltare il tuo cuore e
cogliere la fortuna che, alla fine, ti sorride. Sotto un altro
cielo, il tuo turbamento commuoverebbe l'intera città. Ma Kabul non
comprende questi turbamenti. È proprio perché vi ha rinunciato che
più nulla le riesce, né le gioie né i dolori... Atiq, marito mio,
uomo della mia vita, tu sei benedetto. Ascolta il tuo cuore. È il
solo a parlarti di te stesso, il solo a conoscere la verità vera.
La sua ragione è più forte di tutte le ragioni del mondo. Fidati di
lui, lascia che guidi i tuoi passi. Ma soprattutto, non avere
paura. Perché, fra tutti gli uomini, questa sera, tu sei colui che
ama...»
Atiq si mette a tremare.
Mussarat riprende il suo viso tra le mani e lo supplica: «Torna da
lei. Avete ancora tempo. Con un po' di fortuna, prima dell'alba
sarete dall'altra parte della montagna».
«Ci penso da due giorni e due notti. Non sono sicuro che sia una
buona idea. Ci raggiungeranno e ci faranno lapidare. Non ho il
diritto di propinarle false speranze. È così fragile e infelice.
Giro a vuoto per le strade ruminando il mio piano d'evasione. Ma
non appena la vedo, serena nel suo angolo, tutte le mie convinzioni
si sgretolano. Allora, esco di nuovo a vagare per il quartiere,
torno qui, con i miei progetti alle calcagna, e quando ritrovo le
forze perdo le mie certezze. Sono disperato, Mussarat, non voglio
che me la confischino, capisci? Ho dato loro i più begli anni della
mia vita, i miei sogni più folli, la mia carne e la mia
anima...»
E, con grande meraviglia della moglie, Atiq si nasconde dietro le
ginocchia, le spalle scosse dai singhiozzi.
Atiq deve prepararsi. Domani, Qassim Abdul Jabbar verrà a prendere
la detenuta per portarla là dove gli dèi e gli angeli non si
avventurano. Si cambia nella camera da letto, stringe forte il
turbante. I gesti precisi contrastano con la fissità del suo
sguardo. In fondo alla stanza, Mussarat l'osserva, metà del viso
nella penombra. Non dice nulla quando le passa accanto, non si
muove quando lo sente sollevare il paletto dell'uscio e uscire in
strada.
È luna piena. Si vede chiaro e lontano. Grappoli d'insonni
affollano la soglia dei tuguri; il loro farfugliare eccita gli
stridori della notte. Un neonato vagisce dietro le mura; la sua
vocina sale lentamente al cielo dove milioni di stelle si
chiamano.
La prigione è rintanata nelle proprie ossessioni. Atiq tende
l'orecchio, ma percepisce solo lo scricchiolio delle travi
schiantate dal calore. Accende la lanterna che proietta sul
soffitto la sua ombra deforme. Si siede sulla branda, di fronte al
corridoio della morte e si prende la testa fra le mani. Per una
frazione di secondo, l'attanaglia il desiderio di andare a vedere
come sta la detenuta; resiste e rimane seduto. Il cuore gli batte
fino a spezzarsi. Il sudore si ramifica sul suo viso e gocciola
lungo la schiena; non si muove. La voce di Mussarat gli attraversa
la mente: Stai vivendo i soli momenti degni di essere vissuti... In
amore, anche le bestie diventano divine... Atiq si aggrappa al
proprio dolore, cerca di contenerlo. Ben presto, le sue spalle
riprendono a sussultare e un lungo gemito lo costringe a
inginocchiarsi a terra. Si prosterna, la fronte nella polvere, e si
mette a recitare tutte le preghiere che gli vengono in mente...
«Atiq...»
Si risveglia, faccia a terra. Si è addormentato mentre pregava.
Alle sue spalle, la finestra riflette il primo riverbero
dell'aurora.
Una donna in burqa è dritta davanti a lui.
«Cosa? Le miliziane sono già qui?»
La donna solleva il cappuccio graticciato.
È Mussarat.
Atiq si alza con un balzo e si guarda attorno.
«Come hai fatto a entrare?»
«La porta era aperta.»
«Dio mio! Dove avevo la testa?» Poi, tornando in sé: «Che ci fai
qui? Cosa vuoi?».
«Stanotte è avvenuto un miracolo» gli dice. «Le mie preghiere e le
tue si sono congiunte e il Signore le ha ascoltate. Credo che i
tuoi voti saranno esauditi.»
«Di quale miracolo parli?»
«Ho visto le lacrime scorrere dai tuoi occhi. Ho pensato: se quel
che vedo è vero, allora non è tutto perduto. Tu, piangere? Anche
quando ho estratto le schegge di granata dalle tue carni, non sono
riuscita a strapparti un solo lamento. Per lungo tempo mi ero
abituata all'idea che il tuo cuore si fosse fossilizzato, che più
nulla avrebbe potuto far palpitare la tua anima o farti sognare. Ti
ho visto, giorno dopo giorno, diventare l'ombra di te stesso,
insensibile alle tue delusioni come una roccia all'erosione che la
sbriciola. La guerra è una mostruosità e i suoi figli sanno a chi
rassomigliare. Visto che le cose stanno così, ho accettato di
dividere la mia vita con qualcuno che ambiva solo a corteggiare la
morte. Almeno, così, avevo ragione di credere che il mio fallimento
non dipendesse da me. Poi, stanotte ho visto con i miei occhi
l'uomo che credevo irrecuperabile prendersi la testa fra le mani e
piangere. Mi sono detta, è la prova che in lui vi è ancora un
barlume di umanità. Sono venuta a soffiarci sopra affinchè divenga
più luminoso del giorno.»
«Ma cosa dici?»
«Che il mio fallimento dipendeva proprio da me. Eri infelice perché
non ho saputo dare un senso alla tua vita. Se i tuoi occhi non
riuscivano a rendere sinceri i tuoi sorrisi è colpa mia. Non ti ho
dato figli né alcun'altra consolazione. Quando mi prendevi, le tue
braccia cercavano qualcuno che non hanno mai trovato. Quando mi
guardavi, tristi ricordi ti afferravano. Sapevo di essere solo
un'ombra che si sostituiva alla tua ombra, e provavo vergogna ogni
volta che distoglievi lo sguardo. Non ero la donna che avevi amato,
ero l'infermiera che ti aveva curato e nascosto, e che tu hai
sposato in segno di gratitudine.»
«La tua malattia ti fa sragionare, Mussarat. Torna a casa,
adesso.»
«Ho cercato di essere bella e desiderabile per te. Soffrivo di non
riuscirci. Sono fatta di carne e sangue, Atiq. Ogni tuo sospiro è
come una frustata per me. Quante volte mi sono sorpresa ad annusare
i tuoi vestiti, come una pecora l'orma del suo agnellino che si è
allontanato dal gregge e ancora non torna, quante volte ho peccato
non riconoscendo nel destino la Volontà divina. Mi chiedevo perché
fosse capitato a te, perché fosse capitato a me, mai perché fosse
capitato a noi.»
«Cosa vuoi esattamente?»
«Che si compia un miracolo. Quando ho visto le lacrime spuntare dai
tuoi occhi, ho creduto di vedere il cielo aprirsi su quanto vi è di
più bello. E mi sono detta che la donna capace di produrre un tale
sconvolgimento non deve morire. Dopo che te ne sei andato, ho
palpato il posto dove stavi alla ricerca di una lacrima
dimenticata. Volevo bagnarmi in lei, ripulirmi delle pene di questo
mondo. Nel ripulirmi sono andata oltre, Atiq.»
«Non ti capisco.
«Perché voler capire quel che, in sé, è un enigma? Da noi, chiodo
scaccia chiodo. Non c'è niente di male a sopportare quel che non si
può evitare; la buona e la cattiva sorte non dipendono da noi. Quel
che voglio dire è semplice e doloroso insieme, ma bisogna
accettarlo: cos'è la vita e cos'è la morte? Le due si equivalgono,
e si annullano.»
Atiq arretra mentre Mussarat avanza verso di lui. Cerca di
prendergli le mani; lui se le mette dietro la schiena. La luce
dell'alba illumina il viso della donna. Mussarat è serena. Il suo
volto non è mai stato così bello.
«Nel paese degli errori senza rimpianti, la grazia o l'esecuzione
non sono il risultato di una deliberazione, ma la conseguenza di
uno sbalzo d'umore. Le dirai che hai perorato la sua causa presso
un mullah influente. Non aggiungere altro. Non deve sapere quel che
è successo. Fra poco, quando verranno a prenderla, rinchiudila nel
tuo ufficio. Io m'introdurrò furtivamente nella sua cella. Sarà
solo un burqa al posto di un altro. Nessuno si prenderà la briga di
controllare l'identità di chi c'è sotto. Vedrai, tutto filerà
liscio.»
«Sei completamente pazza.»
«Comunque, io sono condannata. Tra qualche giorno, al più tardi tra
qualche settimana, il male che mi consuma finirà per avere la
meglio. Non voglio prolungare inutilmente la mia agonia.»
Atiq è spaventato. Respinge la moglie e, le mani in avanti, la
implora di restare dov'è.
«Quel che dici non ha senso.»
«Sai benissimo che ho ragione. È il Signore che m'ispira: quella
donna non morirà. Sarà tutto quel che io non ho saputo offrirti.
Non puoi immaginare come sono felice stamattina. Morta, sarò più
utile che viva. Ti supplico, non sciupare l'occasione che infine ti
è stata data. Ascoltami per una volta...»
CAPITOLO 15
Il 4x4 di Qassim Abdul Jabbar ruggisce frenando
davanti alla prigione, subito seguito da un pulmino pieno di donne
e bambini, che preferisce disporsi sul lato opposto della strada,
come per proteggersi dai sortilegi che gravitano intorno al
malefico edificio. Atiq Shaukat scivola furtivamente nel corridoio
e si addossa al muro, le mani tremanti schiacciate dalle natiche,
lo sguardo a terra per non tradire l'intensità delle proprie
emozioni. Ha freddo, e paura. Le sue viscere si contorcono fino a
spezzarsi in uno stridio incessante mentre crampi lancinanti, quasi
voraci, gli martirizzano le gambe. Le pulsazioni del sangue
risuonano sordamente alle sue tempie simili a colpi di maglio
dentro gallerie sotterranee. Contrae le mascelle e trattiene il
respiro sempre più caotico per non cedere al panico.
Qassim si raschia la gola per strada. È il suo modo di annunciarsi.
Stamattina, il suo gorgoglio ha un che di mostruoso. Si sente
sbattere il ferrovecchio, poi scendere qualcuno. Delle ombre si
agitano a terra, dove si riflette una luce violenta. Due miliziane
si precipitano nell'edificio immerso in un'oscurità malsana, gelida
e umida nonostante l'incipiente canicola del giorno. Passano con
aria marziale davanti al carceriere senza dire una parola e si
dirigono verso la cella in fondo. Compare Qassim. La
colossale larghezza delle sue spalle s'inquadra nel vano della
porta, accentuando la penombra. I pugni sui fianchi, rotea la testa
a destra e a sinistra, si contorce esageratamente e si avvicina al
guardiano fingendo d'interessarsi a una lucertola sul soffitto.
«Su la testa, guerriero. La tua nuca s'incepperà e dopo non potrai
più guardarti decentemente allo specchio.»
Atiq annuisce senza obbedire.
Tornano le miliziane, la prigioniera davanti a loro. I due uomini
si scostano per farle passare. Qassim, che sorveglia l'amico con la
coda dell'occhio, tossicchia nel pugno.
«È già finito» si lascia sfuggire.
Atiq incassa ulteriormente il collo, scosso da brividi senza
fine.
«Devi venire con me» insiste Qassim. «Devo definire alcune cose con
te.»
«Non posso.»
«Cosa te lo impedisce?»
Visto che il carceriere preferisce mantenere il silenzio, Qassim si
guarda attorno e crede di scorgere una sagoma nascosta in un
angolo.
«C'è qualcuno nel tuo ufficio.»
Atiq sente il cuore contrarsi, mozzandogli di netto il respiro.
«Mia moglie.»
«Scommetto che vuole andare allo stadio.»
«Già, è così... è proprio così.»
«Anche le mie mogli e le mie sorelle. Mi hanno costretto a
requisire il pulmino qua fuori. Ma che importa. Dille di unirsi a
loro. La recupererai all'uscita dallo stadio. Quanto a te, verrai
con me. Devo assolutamente sottoporti un progetto che mi sta a
cuore.»
Atiq annaspa. Cerca di farsi venire subito un'idea, ma il vocione
di Qassim gli impedisce di concentrarsi. «Che succede? Ce l'hai con
me?»
«Non ce l'ho con te.»
«E allora?»
Preso alla sprovvista, Atiq si trascina verso l'ufficio, gli occhi
socchiusi per cercare di rimettere in ordine le idee. Intorno a lui
le cose precipitano, l'oltrepassano, lo travolgono. Aveva previsto
tutt'altro esito, nulla è andato come doveva andare. Lo sguardo di
Qassim non gli è mai sembrato così acuto e accorto. Ne trasuda in
ogni poro. Un principio di vertigine isterilisce il suo respiro e
gli trancia le gambe. Si ferma nel vano, medita per un paio di
secondi mentre si chiude la porta alle spalle. La donna seduta
sulla branda l'osserva. Non ne distingue lo sguardo, ma la sua
rigidità acuisce il suo disagio.
«Vedi?» bofonchia. «Il cielo ci ha ascoltati: sei libera. L'uomo
che aspetta qui fuori me l'ha appena confermato. Non vi è più nulla
a tuo carico. Puoi tornare a casa fin da oggi.»
«Chi sono le donne che ho visto passare nel corridoio?»
«È una prigione femminile. Vanno e vengono di continuo.»
«Hanno portato una prigioniera?»
«Non è più affar tuo. La finestra di ieri si è chiusa, apriamo
quella di domani. Sei libera. Solo questo conta.»
«Posso andarmene adesso?»
«Certo. Ma prima ti accompagnerò da altre donne, in un pulmino che
sta perdendo la pazienza qua fuori. Non è necessario che tu dica
loro chi sei né da dove vieni. Non devono sapere... Il pulmino vi
farà scendere allo stadio, dove si sta svolgendo una cerimonia
ufficiale.»
«Voglio tornare a casa.»
«Zitta! Parla a bassa voce.»
«Non voglio andare allo stadio.»
«Bisogna... Non durerà a lungo. Finita la manifestazione, ti
aspetterò all'uscita e ti porterò al sicuro.»
Nel corridoio Qassim si raschia la gola per indicare al carceriere
che è ora di andare.
Zunaira si alza. Atiq l'accompagna al pulmino e torna a prendere
posto nel 4x4 a fianco di Qassim. Neppure per una volta ha guardato
le due miliziane e la loro prigioniera sedute nella parte
posteriore del veicolo.
Le diatribe dei mullah, diffuse da numerosi altoparlanti,
rimbombano sulle macerie circostanti. Di tanto in tanto, lo stadio
vibra per le ovazioni e le grida isteriche. La folla continua ad
affluire da tutti gli angoli della città. Nonostante i cordoni del
servizio d'ordine siano stati rinforzati, un'agitazione sfrenata
impregna i dintorni dell'arena. Qassim comincia con il dirigere il
pulmino verso un ingresso meno gremito, fa scendere le donne e le
affida ad alcune miliziane perché le accompagnino in tribuna.
Rassicurato, risale sul 4x4 e piomba sul prato dove dei
talebani armati si danno da fare con indebito entusiasmo. I corpi
che penzolano un po' dovunque attestano che le esecuzioni pubbliche
sono già iniziate. La gente si accalca sugli spalti gremiti. Molti
sono lì per evitare noie e assistono agli orrori senza manifestare
alcuna emozione. Altri, che hanno scelto di portarsi il più vicino
possibile alla tribuna dove si pavoneggiano i dignitari
dell'apocalisse, fanno di tutto per essere notati; il loro giubilo
eccessivo, anzi morboso, e le loro grida dissonanti disgustano
finanche gli stessi guru. Atiq balza a terra e, immobile davanti al
veicolo, non toglie lo sguardo dalla tribuna riservata alle donne,
credendo di riconoscere Zunaira in ognuna di esse. Trincerato in
fondo al proprio delirio, il ventre mestricabile come la testa, non
ode gli applausi né i sermoni dei mullah. Non sembra neppure vedere
le migliaia di spettatori che riempiono le gradinate di torme
inferocite dalle fauci più sudice delle barbe. Le pupille
incandescenti, cerca d'indovinare dove sia la sua protetta,
relegando il resto del mondo a nulla. In un'ala dell'arena scoppia
un putiferio, si alzano urla funeste. Degli sbirri spintonano un
"maledetto" al suo destino, dove un uomo lo aspetta con il coltello
in mano. Lo spettacolo dura il tempo di pochi gesti. L'uomo
immobilizzato viene fatto inginocchiare. Il coltello brilla prima
di tagliargli la gola. Sugli spalti, sporadici applausi salutano la
destrezza del boia. Il corpo insanguinato viene gettato in una
barella; avanti un altro! Atiq è talmente concentrato sulle schiere
di burqa che lo sovrastano come un bastione blu che non vede le
miliziane afferrare la loro prigioniera. Quest'ultima cammina fino
al centro del prato poi, scortata da due uomini, si dirige verso lo
spazio che le è riservato. Una voce perentoria le intima
d'inginocchiarsi. Obbedisce e, alzando per l'ultima volta lo
sguardo dietro la maschera graticciata, scorge Atiq che le volta le
spalle, laggiù, accanto al 4x4. Quando sente la canna del fucile
sfiorarle la nuca, prega il cielo perché il carceriere non si
volti. Il colpo parte all'improvviso, trascinando nella sua
bestemmia una preghiera incompiuta.
Atiq ignora se la cerimonia sia durata qualche ora oppure
un'eternità. I barellieri finiscono di ammucchiare i loro cadaveri
sul rimorchio di un trattore. Un sermone particolarmente perentorio
conclude i "festeggiamenti". Immediatamente, il prato è invaso da
migliaia di fedeli per la grande preghiera. Un mullah dai modi di
sultano guida il rito mentre sbirri rabbiosi danno la caccia ai
ritardatari. Partiti gli ospiti di prestigio, orde pullulanti si
tramutano in risacche feroci prima di convergere verso le uscite.
Scoppiano zuffe inaudite, e così violente che il servizio d'ordine
è costretto a battere in ritirata. Non appena i burqa iniziano a
defluire dagli spalti, Atiq raggiunge un assembramento di
uomini fuori dello stadio. Qassim è lì, le mani sui fianchi,
visibilmente soddisfatto della sua prestazione. È convinto che il
suo contributo al buon svolgimento delle esecuzioni pubbliche non
sia sfuggito ai guru. Si vede già promosso alla testa del più
grande penitenziario del paese.
Le prime donne iniziano a uscire dallo stadio, subito recuperate
dai loro uomini. Si allontanano a gruppetti più o meno uniformi,
alcune cariche di figli. La gazzarra si attenua man mano che le
orde sgombrano i dintorni dello stadio. La folla si diluisce nella
polvere risalendo verso la città, inframmezzata dai camion dei
talebani che s'inseguono in un carosello infernale.
Qassim riconosce il suo harem in mezzo alla calca; con un cenno del
capo, indica il pulmino in attesa sotto un albero.
«Se vuoi, posso portare te e tua moglie a casa.»
«Non c'è bisogno» gli dice Atiq.
«La deviazione non mi darebbe alcun fastidio.»
«Ho delle faccende da sbrigare in città.»
«Bene, d'accordo. Spero che rifletterai sulle mie proposte.»
«Certo...»
Qassim lo saluta e si affretta a raggiungere le sue donne.
Atiq continua ad aspettare la sua. Intorno a lui, l'assembramento
si restringe come una pelle di zigrino. Ben presto, solo un piccolo
grappolo d'individui irsuti gli tiene compagnia per pochi minuti
ancora, prima di sparire a sua volta, trascinandosi dietro il
fruscio dei burqa. Tornato in sé, Atiq si accorge che sul piazzale
non è rimasto più nessuno. Tranne il cielo gravido di polvere e il
portone dello stadio spalancato, è il silenzio; un silenzio
miserabile, profondo come un abisso. Atiq si guarda intorno,
incredulo, completamente disorientato; è proprio solo. Preso dal
panico, si precipita dentro la cinta. Il prato, gli spalti, la
tribuna sono deserti. Rifiuta di ammetterlo e corre verso la
tribuna riservata alle donne. Tranne i lastroni di una straziante
nudità, nessuno. Torna sul prato e si mette a correre come un
pazzo. Il suolo ondeggia sotto le sue falcate. Gli spalti
abbandonati si mettono a girare, vuoti, vuoti, vuoti. Per un
momento, la nausea lo costringe a fermarsi. Ma subito riprende la
sua folle corsa mentre il respiro ronzante minaccia di sommergere
lo stadio, la città, il paese intero. Stordito, terrorizzato, il
cuore sul punto di schizzargli fuori dalla gola, torna in mezzo al
prato, esattamente lì dove si è coagulata una pozza di sangue e, la
testa fra le mani, scruta ostinatamente, una dopo l'altra, le
tribune. Realizzando improvvisamente quanto vasto sia il silenzio,
le gambe gli cedono e cade in ginocchio. Il suo urlo da bestia
folgorata si riversa sulla cinta, raccapricciante come la caduta di
un titano: Zunaira!
Nel cielo plumbeo, le prime striature della notte si accingono a
spegnere gli ultimi fuochi del crepuscolo. Una dopo l'altra, le
luci del giorno si rannicchiano in cima agli spalti mentre le
ombre, subdole e tentacolari, stendono il loro manto a terra per
accogliere la notte. I rumori della città si vanno placando in
lontananza. E nello stadio, che una brezza intrisa di fantasmi si
prepara ad assillare, i lastroni si rintanano in un mutismo
sepolcrale. Atiq, che ha pregato e aspettato come mai prima d'ora,
accetta infine di rialzare la testa. La dolorosa miseria della
cinta lo richiama all'ordine; non ha più nulla da fare in mezzo a
quelle livide mura. Si alza poggiando una mano a terra. Le gambe
malferme barcollano. Azzarda un passo, poi due, riesce a
raggiungere alla meno peggio il portone. Fuori, la sera accumula
oscurità ai piedi delle macerie. Dei mendicanti emergono dalle loro
tane, la voce abbastanza assonnata da rendere convincente la
loro cantilena. Poco lontano, dei ragazzini armati di spade e
fucili di legno continuano le cerimonie della mattinata; hanno
immobilizzato alcuni loro compagni in un piazzale sinistrato e si
accingono a giustiziarli. Qualche incanutito perdigiorno li osserva
sorridendo, divertito e intenerito dalla verosimiglianza della
ricostruzione. Atiq va dove lo portano i suoi passi. Ha
l'impressione di camminare sopra una nuvola. Nella bocca inaridita,
un solo nome ritorna - Zunaira - impercettibile, ma ossessivo.
Passa davanti alla prigione, poi; davanti alla casa di Zanish. La
notte lo coglie in fondo a un vicolo ingombro di macerie. Sagome
evanescenti l'attraversano da parte a parte. Quando raggiunge casa
sua, le gambe lo tradiscono nuovamente e s'accascia nel patio.
Supino, Atiq contempla la luna. Stasera, è perfettamente rotonda.
Sembra una mela d'argento sospesa per aria. Quando era piccolo,
passava le ore a contemplarla. Seduto sopra una collinetta, lontano
dalla topaia di famiglia, si sforzava di capire come un astro così
pesante potesse fluttuare nello spazio e si chiedeva se degli
esseri simili agli abitanti del suo villaggio vi coltivassero i
campi e vi facessero pascolare le capre. Una volta, suo padre era
venuto a tenergli compagnia. Fu così che gli rivelò il mistero
della luna. Era il sole, gli disse, che, dopo essersi pavoneggiato
tutto il giorno, aveva spinto il proprio zelo fino a profanare i
segreti della notte. Ma quel che vide era così insopportabile che
perse tutti i suoi ardori.
A lungo Atiq aveva creduto a quella storia.
Ancora oggi, non può impedirsi di credervi. Cosa c'è di così
terribile dall'altra parte della notte perché il sole vi lasci
tutti i suoi colori?
Raccolte le ultime forze, si trascina dentro casa. Il braccio
brancolante rovescia la lampada. Non l'accende. Sa che il più
debole chiarore lo accecherebbe. Le sue dita scivolano lungo il
muro, raggiungono il vano della stanza dove dormiva sua moglie.
Cerca il pagliericcio, vi si lascia cadere e lì, la gola gonfia di
singhiozzi, prende la coperta e se l'annoda intorno fino a
strozzarsi: «Mussarat, mia povera Mussarat, cosa ci hai
fatto?».
Si allunga sul giaciglio, stringe le ginocchia al ventre e si fa
piccolo, piccolo.
"Atiq..."
Trasale.
Una donna è in piedi in mezzo alla stanza. Il burqa opalescente
brilla nell'oscurità. Atiq è sbalordito. Si stropiccia
energicamente gli occhi. La donna non scompare. È rimasta nello
stesso posto, ondeggiando nella luce incerta.
"Pensavo che te ne fossi andata e che non ti avrei rivisto mai più"
farfuglia cercando di alzarsi.
"Ti sbagliavi..."
"Da dove sei passata? Ti ho cercata dappertutto..."
"Non ero lontano... mi nascondevo."
"Sono stato sul punto d'impazzire."
"Adesso sono qui."
Atiq si appoggia al muro per rimettersi in piedi. Trema come una
foglia. La donna allarga le braccia.
"Vieni" gli dice.
Lui corre a rannicchiarsi contro di lei. Come un bambino restituito
alla madre.
"Oh, Zunaira, Zunaira, cosa sarei diventato senza di te?»
"Il problema non si pone."
"Ho avuto tanta paura."
"È colpa del buio che imperversa qui dentro."
"Non ho acceso apposta. E non ci tengo a farlo. Il tuo volto
m'illuminerebbe più di mille candelabri. Togliti il cappuccio, per
favore, e lascia che sogni di te."
Lei fa un passo indietro e solleva la parte superiore del burqa.
Atiq lancia un grido di terrore gettandosi indietro. Non è più
Zunaira; è Mussarat e ha metà del viso strappato via da una
fucilata.
Atiq si risveglia urlando con le mani in avanti per respingere
l'orrore. Gli occhi fuori delle orbite e il corpo madido di sudore,
gli ci vorrà qualche secondo per capire che era solo un incubo.
Fuori, il sole sorge, e con lui i dolori del mondo.
È un Atiq spettrale quello che si arena al cimitero della città.
Senza scudiscio né turbante. I pantaloni bassi, appena trattenuti
da una cintura allacciata malamente. Non cammina in senso proprio,
si trascina, lo sguardo sconvolto, il passo pesante. Le stringhe
delle sue ciabatte imprimono nella polvere arabeschi sinuosi; la
destra è rotta ed espone al sole un alluce informe, con l'unghia
spezzata, orlata da una macchia di sangue. Deve essere scivolato da
qualche parte, perché il fianco destro è macchiato di fango e ha il
gomito scorticato. Sembra che sia ubriaco, e che ignori dove è
diretto. Ogni tanto, si ferma per appoggiarsi contro un muro, la
schiena curva, le mani schiacciate contro le ginocchia, indeciso
fra la voglia di vomitare e la necessità di riprendere fiato. Il
volto cupo, che una barba arruffata ombreggia, è sgualcito come una
mela vizza con la fronte incisa e le palpebre tumefatte. Il suo
dramma è lampante; il suo sfacelo, avanzato. I pochi curiosi che
gli passano accanto lo esaminano intimoriti; alcuni effettuano
larghe deviazioni per evitarlo, mentre i ragazzini che giocano un
po' ovunque non lo perdono di vista. Atiq non è consapevole della
paura che suscita. La testa gli pesa sulle spalle, i suoi gesti
sono incoerenti; vede vagamente il labirinto dei vicoli. Non mangia
da tre giorni. Il digiuno e il dolore lo hanno svigorito. Una
saliva lattiginosa si è disseccata agli angoli della bocca; non
smette di soffiarsi il naso sul polso. Gli ci vuole più di un colpo
di reni per staccarsi dal muro e riprendere il cammino. Le gambe
tremano sotto la carcassa sfibrata. Un gruppo di talebani l'ha
fermato due volte, sospettando uno stato di ebbrezza; qualcuno l'ha
anche picchiato intimandogli di tornare subito a casa. Atiq non se
n'è accorto. Non appena l'hanno rilasciato, ha ripreso la strada
del cimitero, come guidato da un richiamo sconosciuto.
Una famiglia, composta di donne cenciose e bambini dai visetti
screziati da tracce di sudiciume, si raccoglie intorno a una tomba
scavata di fresco. Poco lontano, un mulattiere cerca di riparare la
ruota del carretto che una grossa pietra deve aver fatto uscire
dall'asse. Qualche cane macilento annusa i sentieri, il muso sporco
di terra, le orecchie dritte. Atiq barcolla in mezzo ai cumuli di
terra che rigonfiano il terreno abbandonato di ecchimosi
screpolate, senza pietre tombali né epitaffi; giusto delle fosse
ricoperte di polvere e breccia, scavate un po' alla rinfusa, in un
guazzabuglio allarmante che aggiunge un tocco tragico alla
tristezza del luogo. Atiq si attarda sulle tombe scheletriche, ogni
tanto si accovaccia per tastarle con la punta delle dita, poi le
scavalca o v'inciampa sopra brontolando. Dopo aver fatto un giro,
si rende conto che non è in grado di riconoscere l'estrema dimora
di Mussarat, visto che non sa neppure dove si trovi. Scorge un
becchino intento a mordere un pezzo di carne affumicata sul lato
opposto del quadrato, e va a chiedergli dov'è sepolta la donna
giustiziata pubblicamente il giorno prima allo stadio della città.
Il becchino gli indica un ammasso di polvere poco distante e
riprende a mangiare con appetito.
Atiq si lascia cadere davanti alla tomba della moglie. Si prende la
testa fra le mani. Resta così fino a pomeriggio inoltrato. Senza
una parola. Senza un lamento. Senza una preghiera.
Incuriosito, il becchino viene a controllare se lo strano
visitatore sia sveglio. Gli fa notare che il sole picchia forte e
che, se non si mette al riparo, rischierà di pagarne le
conseguenze. Atiq non capisce di cosa lo stiano rimproverando.
Continua a fissare la tomba della moglie senza muoversi. Poi, con
la testa che gli scoppia, mezzo cieco, si rialza e lascia il
cimitero senza voltarsi indietro. La mano ora appoggiata a un muro,
ora contro un arbusto, vaga da un vicolo all'altro. È allora che
una donna, uscendo da una mansarda, quasi lo fa rinsavire. Indossa
un burqa scolorito, dai lembi strappati, e calza scarpe
scalcagnate. Atiq si piazza in mezzo al vicolo per intercettarla.
La donna si scansa sul lato; Atiq l'afferra per il braccio e cerca
di trattenerla. Lei si libera con uno strattone dalla morsa
dell'uomo e scappa via... Zunaira, le dice, Zunaira... La donna si
ferma in fondo al vicolo, lo osserva incuriosita e scompare. Atiq
si affretta a correrle dietro, le braccia protese come se cercasse
di afferrare una voluta di fumo. In un altro vicolo, sorprende una
donna sulla soglia di un rudere. Vedendolo arrivare, questa rientra
e si chiude la porta alle spalle. Atiq si volta e vede un burqa
giallo scivolare verso la piazza del quartiere. Lo segue, le mani
sempre in avanti. Zunaira, Zunaira... I bambini si fanno da parte,
spaventati da quell'uomo arruffato, dagli occhi in fuori e le
labbra blu, che sembra braccare la propria follia. Il burqa giallo
si ferma di fronte a una casa. Atiq gli piomba addosso, lo
raggiunge proprio mentre una porta si apre... Da dove sei passata?
Ti ho aspettato all'uscita dello stadio, come avevamo deciso, e tu
non sei venuta... Il burqa giallo cerca di sottrarsi agli artigli
che lo lacerano... Lei è pazzo. Mi lasci o mi metto a gridare. ..
Stavolta non ti lascerò più sola, Zunaira. Se non sei capace di
trovarmi, non ti costringerò più a cercarmi... Non sono Zunaira.
Vada via, disgraziato, altrimenti i miei fratelli la uccideranno...
Togliti il cappuccio. Voglio vedere il tuo viso, il tuo bel viso da
uri... Il burqa sacrifica un lembo del fianco e si volatilizza.
Alcuni ragazzini, che hanno assistito alla scena, raccolgono dei
sassi e si mettono a mitragliare il pazzo finché non torna
indietro. La tempia squarciata da un proiettile, il sangue che gli
cola sull'orecchio, Atiq si mette a correre, dapprima a passettini,
poi, man mano che si avvicina alla piazza, allunga la falcata, il
respiro rauco, le narici frementi, la schiuma alla bocca. Zunaira,
Zunaira, balbetta urtando i passanti a caccia di burqa.
Improvvisamente, in preda alla frenesia, si mette a braccare le
donne e - oh, sacrilegio! - a scoprirne i volti. Zunaira, so che
sei qui. Esci dal tuo nascondiglio. Non hai nulla da temere.
Nessuno ti farà del male. Ho sistemato tutto. Non permetterò a
nessuno di darti fastidio... Si alzano grida indignate. Le sue mani
afferrano i veli, li strappano con rabbia, facendo talvolta cadere
le donne prese in trappola. Se qualcuna gli resiste, la scaraventa
a terra, la trascina nella polvere e la lascia andare solo dopo
essersi accertato che non si tratta di colei che sta cercando. Una
prima manganellata lo raggiunge alla nuca. Non demorde. Catapultato
da una forza sovrannaturale, prosegue la sua corsa forsennata. Ben
presto, una folla scandalizzata si dispiega per trattenerlo. Le
donne si disperdono urlando; lui riesce ad afferrarne qualcuna, ne
lacera la veste, solleva loro la testa tirandole per i capelli.
Alla manganellata seguono le frustate, poi i pugni e i calci. Gli
uomini "disonorati" travolgono le loro donne pur di gettarsi
addosso al pazzo... Demone! Tizzone d'inferno!... Atiq ha la vaga
sensazione di essere trascinato da una valanga. Mille ciabatte si
abbattono su di lui, mille bastoni, mille scudisci. Depravato!
Maledetto! Travolto dal tumulto, crolla a terra. La muta furibonda
si avventa su di lui per linciarlo. Ha giusto il tempo di notare
che la sua camicia non c'è più, lacerata da dita rapaci, che il
sangue cola copioso sul petto e lungo le braccia, mentre le
sopracciglia spaccate gli impediscono di commisurare
l'irrefrenabile furia che l'assedia.
Frammenti di parole confuse si aggiungono alla miriade di colpi per
tenerlo a terra... Impicchiamolo; crocifiggiamolo, bruciamolo
vivo... Improvvisamente, la sua testa vacilla e quanto lo circonda
piomba nell'oscurità. Segue un silenzio, grave e intenso. Chiudendo
gli occhi, Atiq supplica gli antenati affinchè il suo sonno sia
impenetrabile come i segreti della notte.